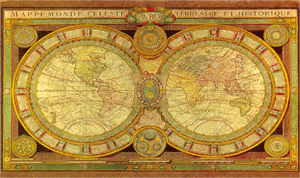L’eredità del Leone
Una presenza costante nelle vicende
dell’Alto Adriatico e del confine orientale dopo la caduta
di Venezia: l’emblema di San Marco
Non è necessario appartenere alla «eletta schiera» degli storici cattedratici per interpretare il passato in chiave attuale, come accade in una storiografia moderna, conforme ai canoni essenziali indicati da buona parte della scuola contemporanea, a suffragio e condivisione di un beninteso revisionismo. Esempio notevole di tale realtà oggettiva è quello costituito dall’opera di Flavio Fiorentin (L’eredità del Leone: dal trattato di Campoformio alla Prima Guerra Mondiale, Aviani & Aviani, Udine 2018, 336 pagine). Questi, appartenente a famiglia esule, ha dedicato un lungo «excursus» alla complessa vicenda del mondo giuliano e dalmata dalla fine della Serenissima alle persecuzioni austriache e alla rivoluzione nazionale indotta dalla Grande Guerra, confermando l’assunto e dimostrando che le fondamentali esigenze di fedeltà al vero possono essere tranquillamente onorate, talvolta meglio degli storici professionali, come ha fatto lo stesso Fiorentin, esperto di diritto amministrativo ed ex dirigente del settore pubblico, dapprima in sede ministeriale, e poi presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il volume scorre in modo agile nell’ambito di una documentazione organica e funzionale, non senza cogliere i nessi di causa ed effetto presenti in molte vicende di una storia multiforme come quella del confine orientale: ad esempio, ravvisando nella politica filo-slava perseguita da Vienna, soprattutto dopo la perdita del Veneto conseguente alla Terza Guerra d’Indipendenza, una matrice fondamentale dell’irredentismo e del suo sofferto successo, nonostante i lacci imposti dalla Triplice Alleanza che l’Italia aveva sottoscritto con gli Imperi Centrali, e quelli rivenienti dalle nuove vocazioni africaniste di Governi Italiani non necessariamente nazionalisti né tanto meno imperialisti. In effetti, alla progressiva maturazione delle aspettative giuliane, istriane e dalmate nonostante il proibizionismo di Francesco Giuseppe, dei suoi Ministri e dei suoi Generali, si contrappose la non meno visibile decadenza dell’Impero e delle sue pregiudiziali assolutiste, sempre più anacronistiche anche a livello internazionale.
Fra i tanti episodi che attestano questa tendenza alla catarsi basti ricordare la pervicace negazione della richiesta di istituire l’Università Italiana a Trieste, tanto da indurre disordini di origine studentesca nella stessa Vienna, per non dire del ricorrente nonché dichiarato «presentimento» di Francesco Ferdinando, diventato erede al trono asburgico dopo la scomparsa di Rodolfo: una sorta di preavviso della morte violenta, in apparenza surreale, che la dice lunga sulla cupa atmosfera da autentico crepuscolo degli dèi in cui si viveva nell’Austria d’inizio secolo, e che fu tragicamente confermato dagli spari di Sarajevo.
Un’ottima fotografia di questa realtà, ben diversa nell’ottica italiana, è presente nelle pagine dedicate al volontariato di parte giuliana e dalmata che si tradusse nelle tante «diserzioni» dalla duplice Monarchia Asburgica durante la Grande Guerra, ma precedute da importanti segnali premonitori. Considerazioni analoghe valgono per l’ampia reazione popolare al disastro di Caporetto, ancor prima di quella politica espressa dal Gabinetto di solidarietà nazionale presieduto da Paolo Boselli (col primo ingresso di cattolici e riformisti nella compagine ministeriale). Ciò, in una sorta di tardiva reazione al «colpo di Stato» con cui il Governo di Antonio Salandra, spinto da Vittorio Emanuele III di Savoia e dalle promesse del patto di Londra, aveva deciso per la discesa in campo dell’Italia (maggio 1915) dopo dieci mesi di neutralità.
Non erano stati da meno i Ministri irredenti, testimoni di una lunga e nobile attesa, come il Capodistriano Elio Italico Vittorio Zupelli, titolare del Dicastero della Guerra, dove sarebbe stato richiamato dopo una significativa presenza in prima linea; ovvero, come il Triestino Salvatore Barzilai, esponente della Sinistra repubblicana, entrato nel Governo come Ministro senza portafoglio e molto utile anche nell’ambito della sua attività giornalistica.
Nonostante il «sole» di Vittorio Veneto che parve iterare i fasti di Austerlitz onorando le 125.000 decorazioni al Valor Militare conferite nel corso della guerra (fra cui 360 Medaglie d’Oro), il dopoguerra non fu ottimale: a prescindere dalle vicende sanitarie culminate nella terribile epidemia di «febbre spagnola» che impose ulteriori sacrifici di vite umane sostanzialmente dovunque, e da quelle economiche espresse dal deprezzamento delle monete e dalla distruzione del risparmio privato, gli impegni assunti dagli Alleati Occidentali non vennero rispettati anche per la strenua opposizione di un nuovo protagonista anti-italiano come il Presidente Statunitense Woodrow Wilson, mentre la grande crisi mondiale del 1929 veniva a sovrapporsi al terrorismo slavo di «Orjuna» e di TIGR che non faceva mistero delle sue mire su Fiume, sull’Istria e sulla stessa Trieste, cui l’Italia contrappose i processi a Vladimir Gortan e ai «Quattro di Basovizza» conclusi con altrettante condanne alla pena capitale, conformi allo spirito mondiale dell’epoca, come venne riconosciuto dagli osservatori internazionali.
Solo nel 1937, col trattato d’amicizia italo-jugoslavo firmato dal Premier Jugoslavo Milan Stojadinovic e dal Ministro degli Esteri Italiano Galeazzo Ciano, le relazioni sarebbero sensibilmente migliorate, salvo precipitare nel marzo 1941 con il colpo di Stato che vide il cambiamento di campo da parte di Belgrado e la conseguente invasione della Jugoslavia per iniziativa dell’Asse.
La ricerca storica del Fiorentin si estende oltre il 1918 soltanto per linee essenziali ma non senza proporre importanti considerazioni anche per quanto riguarda la storia più recente: in modo particolare, quella del secondo dopoguerra, laddove confuta la tesi di 34.000 Vittime infoibate o diversamente massacrate, e di 350.000 Esuli, dato che queste cifre parrebbero riferirsi, fonti alla mano, ai soli territori dove l’Italia aveva esercitato la propria sovranità, con il supporto di adeguate informazioni anagrafiche e statistiche. Al contrario, si dovrebbe tener conto anche degli «Italiani residenti nelle città e nei territori della Dalmazia che mai fecero parte del Regno d’Italia» portando a rivedere le cifre in senso più realistico e attestandole intorno a 45.000 Vittime e a circa mezzo milione di profughi. Si tratta di uno spunto di riflessione importante, che se non altro ha il merito di proporre la necessità di maggiori approfondimenti, tanto più che la recente congiuntura storica ha promosso motivi di ulteriore avvicinamento non solo formale, soprattutto con la Slovenia. In questo senso, sembra di poter aggiungere un commento pertinente: quanto è accaduto a Trieste il 13 luglio 2020, in occasione dei 100 anni dall’incendio del «Balkan» e della «cessione» di detto edificio alla comunità slovena della città di San Giusto, ha assunto un significato emblematico, se non altro con il contestuale omaggio italiano ai summenzionati «Quattro di Basovizza» sebbene fossero stati condannati quali rei di azioni terroristiche non prive di Vittime.
La storia di Venezia Giulia e Dalmazia si caratterizza per un «leit-motiv» riassumibile nella sua costante propensione a gravitare verso Occidente: dapprima nell’ambito della cultura latina e poi di quella veneta, seguita dalla breve parentesi francese del periodo napoleonico e dai 100 anni della dominazione asburgica (1815-1918) rovinosamente chiusa dalla Grande Guerra.
In effetti, la scomparsa dell’Impero a favore delle diverse nazionalità assurte al rango di Stati indipendenti fu un evento che quattro anni prima non sarebbe sembrato immaginabile. Comunque sia, quando si poteva presumere che il fiume riprendesse a scorrere nella direzione plurimillenaria aperta da Roma e proseguita da Venezia, il Novecento ha finito per dare luogo a un «ribaltamento» rivoluzionario in cui le pressioni del mondo slavo, contenute per tanti secoli, sono diventate incontenibili dalla Finlandia all’Italia, passando per tutta la celebre «cortina di ferro» di cui all’immaginifica definizione di Winston Churchill.
Ne seguirono le tristi successioni degli esodi, cominciando da quello «dimenticato» del 1921 quando i Dalmati superstiti lasciarono affetti e focolari per non diventare sudditi della nuova Jugoslavia, e finendo con l’anabasi plebiscitaria del secondo dopoguerra protrattasi per oltre un decennio (1943-1954) quando nove decimi di un intero popolo scelsero l’ignoto pur di non accettare l’ateismo di Stato, il collettivismo forzoso e il rischio della foiba o di altre varietà di massacro. È rimasta la fede, nonostante l’accoglienza che tanti profughi trovarono in Italia e su cui il Fiorentin ha voluto «sorvolare per carità di Patria»; e nonostante un «Giorno del Ricordo» (10 febbraio) che ha finito per diventare una mera «occasione retorica» come da pertinente rilievo nelle valutazioni introduttive dello storico Fulvio Salimbeni. È rimasta una fede davvero granitica, destinata a fare giustizia di tante incomprensioni e di tante iniquità, convergendo nel consapevole conforto di rinnovate speranze.