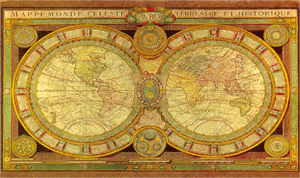La poesia latina dell’età di Augusto
Una fioritura letteraria di altissimo
livello
Generalmente, quando si parla di storia romana, si è portati a pensare a qualche guerra o a fatti politici. Invece, la storia romana è ricca di eventi e personaggi che hanno a che fare principalmente col mondo della cultura.
In particolare, l’epoca di Ottaviano Augusto, a cavallo tra il I secolo avanti Cristo e il I secolo dopo Cristo, è stata caratterizzata da un vero e proprio «vivaio» di artisti.
La fine delle lunghe guerre civili susseguenti all’assassinio di Giulio Cesare e poi alla tormentata vicenda di Antonio e Cleopatra aveva lasciato Ottaviano unico padrone di Roma. La Repubblica aveva emesso i suoi ultimi gemiti, spegnendosi lentamente, ma nel contempo la capitale di quello che era un Impero (di fatto se non ancora di nome) attraversava un periodo di benessere. Le porte del tempio di Giano, che restavano aperte in caso di guerra, erano state finalmente chiuse. La pace aveva portato allo sviluppo del commercio e, di conseguenza, all’afflusso a Roma di nuove ricchezze. Gli studi e le arti potevano prosperare; l’architettura ebbe un grande impulso e la Città Eterna si adornò di archi trionfali, acquedotti, teatri.
Alla Corte di Ottaviano acquistò grande importanza un cavaliere romano, amico dello stesso Imperatore, di nome Mecenate. Amante della vita in tutti i suoi aspetti, divenne protettore di poeti e artisti, tanto che da lui deriva il termine di «mecenate» usato ancor oggi per designare chi aiuta e protegge gli artisti.
È in questo periodo che la poesia romana raggiunse le vette più alte, per merito soprattutto di tre grandi poeti: Virgilio, Orazio, Ovidio. Furono i migliori, ma non gli unici.
Virgilio nacque il 15 ottobre dell’anno 70 avanti Cristo ad Andes, un piccolo villaggio nei pressi di Mantova, probabilmente l’odierna Pietole, là dove il fiume Mincio scorre lentamente verso il Po. Il padre era un agricoltore e un allevatore di api, e in campagna Virgilio visse libero fino ai 12 anni. Era di alta statura e di carattere timido fino al punto di balbettare, modesto e generoso, non conosceva il sentimento dell’invidia e ha raccontato che l’unica vendetta che prendeva contro i suoi critici era di approfittare dei loro buoni consigli; soffriva di emicranie, di mal di gola, di disordini gastrici e di frequenti spuri sanguigni; non si sposò mai e a Napoli verrà conosciuto come «il vergine».
La campagna folta di verzura e intrisa di acque fu la sua prima maestra e la sua principale ispiratrice, e a essa Virgilio rimase sempre legato: le sue prime opere poetiche, le Bucoliche e le Georgiche, descrivono con accenti amorevoli la vita serena e il lavoro nei campi in anni in cui i Romani, ormai ricchi, sdegnavano le fatiche agresti, riuscendo a essere allo stesso tempo educative e artisticamente belle; le Egloghe erano bozzetti pastorali pieni di pensosa dolcezza e di amore romantico. Per scrivere e perfezionare queste opere, Virgilio impiegò sette anni: componeva assai lentamente, scrivendo pochissimi versi al giorno, e poi aveva l’uso di correggerli più volte, di lisciarli – diceva – come fa l’orsa con gli orsacchiotti. Nella stessa Eneide possiamo leggere bellissimi versi dedicati alla natura e quasi un’insofferenza per la guerra e i fatti d’arme (quasi un controsenso in un poema epico!).
A 13 anni Virgilio iniziò la sua carriera di scolaro a Cremona, a 16 fu a Milano e l’anno successivo a Roma, dove frequentò la scuola di eloquenza, ovvero dell’arte del ben parlare. Divenne avvocato, ma era una professione poco adatta al suo carattere: parlò una sola volta in tribunale e, pare, senza troppa fortuna. Se ne tornò perciò nella sua terra natale.
A causa delle sue delicate condizioni di salute non prese parte alla vita pubblica né come cittadino, né come soldato. Ma la guerra lo colpì comunque: per ricompensare i soldati più fedeli, gli vennero confiscate – per assegnarle ai militari – alcune terre nei pressi di Cremona e Mantova, e solo l’intervento di un amico gli salvò la casa. Un anno dopo, però, venne definitivamente cacciato.
Virgilio fece ritorno a Roma, e qui ebbe inizio la sua fortuna. L’amicizia di Mecenate, che apprezzava i suoi versi, e poi dell’Imperatore Ottaviano gli permisero di condurre una vita tranquilla parte a Napoli, parte nella capitale, dove divenne poeta di Corte. Fu in questo periodo che compose la sua opera più famosa, l’Eneide. Inizialmente doveva cantare solamente le battaglie di Ottaviano, ma il progetto originale si allargò a un’opera più ambiziosa, un grandioso affresco nel quale, sotto le sembianze di raccontare le vicende di Enea dopo la caduta di Troia fino al suo insediamento nel Lazio, in realtà c’è tutto un elogio della storia e delle glorie di Roma. Nello scudo che Vulcano, il fabbro degli dèi, consegna a Enea, è istoriata l’intera storia di Roma, da Romolo e Remo fino al trionfo di Ottaviano:
«Ma Cesare, con tre trionfi salendo alle rocche Romane,
agli Itali dèi voto immortale scioglieva,
trecento are massime per l’intera città.
Di gioia, di giochi, d’applausi fremevan le strade:
in tutti i templi cori di donne, are in tutti:
coprivan la terra davanti alle are i giovenchi.
Lui, sulla nivea soglia del candido Apollo sedendo,
passa in rassegna i doni dei popoli e li appende alle porte
superbe: avanzano, lungo corteo, le genti sconfitte,
tanto varie di lingue quanto di foggia dell’abito e d’armi.
Qui la stirpe dei Nomadi e i nudi Africani,
qui i Lelegi e i Cari, e bravi a gettar frecce i Geloni
fece Vulcano, e più mite l’Eufrate ormai scorrer con l’onde;
poi gli estremi degli uomini, i Morini, e il Reno bicorne,
poi gli indomabili Dai e irato del ponte l’Arasse.
Tutto nello scudo vulcanio, dono materno,
ammira Enea, e ignaro dei fatti si bea dell’immagine,
sopra la spalla alzando la fama e il fato dei suoi» (Eneide,
Libro VIII, versi 714-731).
Sebbene nella struttura si rifaccia sia all’Odissea (il viaggio di Enea verso l’Italia richiama le peregrinazioni di Ulisse verso Itaca) sia all’Iliade (la guerra dei Troiani contro i Rutuli ricorda in più di un punto quella dei Greci contro Troia), e sebbene siano numerosi i rimandi – e anche più di semplici rimandi – a Nevio, Ennio, Lucrezio e Apollonio Rodio, in realtà il poema virgiliano possiede una sua identità che non permette di considerarlo una semplice «copia» dei poemi omerici, a cui non è certo secondo. Si tratta di un’opera con un chiaro intento celebrativo, un sorta di «libello» politico, con la differenza che le opere politiche odierne sono di qualità letteraria spesso assai modesta, se non proprio volgare, mentre l’Eneide raggiunge vette poetiche ineguagliate. In essa, Virgilio mette in evidenza il carattere che ha permesso ai suoi personaggi di compiere le imprese più ardue (un carattere che voleva resuscitare nei Romani le loro antiche virtù) e mostra il desiderio che i cittadini riacquistino la «pietas», ovvero la riverenza verso gli dèi, verso la patria, verso la propria famiglia, una devozione che era stata alimentata dal primitivo culto agreste e aveva reso grande Roma: la religione dell’Eneide è l’amore della patria e la sua più grande divinità è Roma.
L’opera si diffuse fino a divenire per i Romani la fonte di ogni sapere e persino un libro di pronostici: aprendolo a caso, si attribuiva significato di augurio e di consiglio ai versi che capitavano sotto gli occhi. Virgilio finì con l’essere considerato un mago (il nome di sua madre, neanche a farlo apposta, era Magia), e tale fama gli rimase per tutto il Medioevo. Anzi, dato che nella IV Egloga dedicata al suo protettore Asinio Pollione aveva predetto che la nascita di suo figlio avrebbe portato al mondo una nuova epoca di pace e di serenità («Ora ritorna la Vergine [la Giustizia], ritorna il Regno di Saturno; / ora una nuova stirpe discende dall’alto cielo»), per diversi secoli si credette che avesse predetto la nascita di Gesù, e fu considerato un profeta: questa fu una fortuna, perché nel Medioevo salvò le sue opere dalla distruzione e ne favorì la conservazione. In realtà non fu mai messa in discussione la sua fama di grande poeta, e lo stesso Dante, che lo scelse come guida nel suo immaginario viaggio nell’oltretomba, riconobbe in lui l’ultimo grande poeta pagano.
Nel corso di un lungo viaggio in Oriente, Virgilio si ammalò, e la malattia si aggravò durante il ritorno. Il poeta giunse a Brindisi allo stremo delle forze. Aveva con sé il manoscritto dell’Eneide, che doveva ancora terminare di correggere, rivedere e limare. Sono ben riconoscibili alcune parti che non «funzionano», per esempio in alcuni punti Ascanio – il figlio di Enea – è presentato come un bambino piccolo, in altri sembra di vedere in lui un giovanotto. Piuttosto che far conoscere al mondo un’opera non perfetta, Virgilio ordinò che venisse bruciata. Ma l’Imperatore riconobbe in essa un poema di grandissimo valore, e ne proibì la distruzione. Cominciò così l’editoria: si facevano anche 10.000 copie di certi libri, tutte scritte a mano dagli schiavi.
Il 22 settembre dell’anno 19 avanti Cristo, Virgilio morì. Venne sepolto nei pressi di Napoli, su una strada ora adagiata sul fondo del mare. Per la sua tomba furono composti questi versi, che riassumono in breve la sua vita e le sue opere:
«Mantua me genuit
Tenet nunc Partenope
Cecini pascua, rura, duces»
che significano «Nacqui a Mantova / Ora mi trattiene Napoli / Cantai i pascoli [Bucoliche], i campi [Georgiche], i condottieri [Eneide]».
Nativo di Venosa, in Puglia, Orazio fu una figura straordinariamente gentile, che anche dopo aver raggiunto la fama mantenne una grande umiltà e parlò di sé con molta frachezza. Non nascose mai di essere figlio di un povero usciere, o di un liberto salito alla dignità di esattore delle tasse, o di un pescivendolo (le fonti non sono concordi) che aveva fatto tanti sacrifici per farlo studiare, anzi, disse che se gli fosse stata data la facoltà di scegliere un genitore, avrebbe voluto ancora lui.
A 23 anni, Bruto lo arruolò nel suo esercito con il grado di tribuno. Ma Orazio non era fatto per le armi e durante la battaglia di Filippi, per scappare più in fretta, gettò lo scudo (l’atto considerato più disonorevole per un soldato).
Rientrò a Roma, e nei primi tempi fece la fame. Era basso e tarchiato, orgoglioso e timido. Conobbe Virgilio, che apprezzò i suoi versi e lo aiutò, e Mecenate, alla cui mensa sedeva ogni giorno. Ottaviano gli offrì di fargli da segretario ma lui rifiutò, perché da giovane era stato repubblicano.
L’Imperatore gli voleva bene. Un giorno si lamentò perché non gli aveva dedicato nessuna poesia: «Hai paura» gli disse scherzando «che i posteri ti possano credere mio amico?» Per questo gli dedicò una delle sue Epistole.
Grazie a Mecenate e Ottaviano, Orazio poté vivere in una agiatezza senza preoccupazioni, tutto dedito al suo lavoro di poeta: una villa donatagli da Mecenate aveva 24 stanze, tre piscine, parecchi pavimenti a mosaico e un vasto giardino circondato da un porticato.
Orazio fu autore, oltre che degli Epodi (poesie dure e aspre, poco piacevoli), delle Satire e delle Odi.
Le Satire sono poesie in cui descriveva gli uomini e le donne di Roma che incontrava, persone vere, non tipi idealizzati: lo schiavo insolente, il poeta vanitoso, il conferenziere pieno di sé, il filosofo goloso, il chiacchierone seccatore, il Semita astuto, l’uomo d’affari, l’uomo politico, la prostituta; rideva dei ghiottoni che banchettavano con leccornie e zoppicavano per la gotta, si meravigliava delle anime irrequiete che in città rimpiangevano la campagna e in campagna la città, metteva in burla anche se stesso rappresentando il suo schiavo che gli diceva in faccia che lui – che si atteggiava a moralista – era di natura focosa e servo delle sue passioni come tutti gli altri uomini.
Osservava la vita senza troppa profondità, ma lasciandoci quadretti vivaci e pervasi di ironia, come quando descriveva coloro che, per liberarsi da un vizio, cadevano nell’eccesso opposto:
«Sgualdrine a truppe, profumier, pitocchi,
stufaioli, buffon, questa genia
tutta in pena e affanno è per la morte
del musico Tigellio, e ciò perch’esso
donava a larga mano… Altri per tema
d’esser chiamato sprecator, neppure
a un meschinello amico un pane, un cencio
darebbe per cacciar la fame e il freddo.
Se chiedi a un altro, ond’è, che i ricchi fondi
dilapidando va per far contenta
l’ingrata gola, e denar prende a usura
per comperar tutti i boccon più ghiotti,
egli ti risponde che non vuol la taccia
d’uomo spilorcio, e di cuor gretto e vile.
[…]
Fusidio ricco di poderi e censi
teme di milenso e sciupatore
la brutta infamia, e però vuol di frutto
cinque per cento il mese anticipato,
e più s’accanisce addosso ai più spiantati.
[…]
Voglio dire che, fuggendo i pazzi un vizio,
a dar di petto van nel vizio opposto.
[…]
Rufillo è tutto odor, Gorgonio ammorba.
Insomma, nessun tien la via di mezzo» (Satire,
Libro I, Satira II, versi 1-14, 16-20, 32-33, 37-38).
Le Odi erano invece liriche brevi, delicate e possenti, modellate per la musica, in cui venivano dipinti i piaceri dell’amicizia, del mangiare, del bere, del fare all’amore mentre il tempo scorreva via inesorabile e la giovinezza andava goduta «sdraiati sotto i pini, con la chioma grigia inghirlandata di rose e profumata di nardo siriaco»; vi erano anche, frammischiate a descrizioni di amori peccaminosi con donne di facili costumi, lodi del Governo di Ottaviano, delle sue vittorie, dei suoi luogotenenti, delle sue riforme morali e della pace che aveva assicurato all’Impero. Leggendo le Odi, Ottaviano chiese a Orazio di scrivere il Carmen saeculare che fu cantato da 27 fanciulli e da altrettanti ragazzi ai giochi secolari che si tennero in Roma nel 17 avanti Cristo: «Alme Sol […] / Possis nihil urbe Roma / visere maius» («O Sole che generi la vita […] / Tu non possa mai vedere niente / più grande di Roma».
Non tutti i poeti di questo periodo ebbero vita difficile: Ovidio ottenne un successo rapido e facile. Era nato a Sulmona, in Abruzzo, in una bella valle rigogliosa di vigneti, boschetti di ulivi, campi di grano dissetati da numerosi ruscelli. Figlio di un ricco borghese, era stato eletto al posto di giudice in un tribunale pretorio (con la prospettiva di una brillante carriera che avrebbe potuto portarlo a sedere in Senato), ma la sua vera vocazione era scrivere versi d’amore (per incarico datogli personalmente dalla dea Venere, diceva); iniziò questa carriera poetica fin da giovinetto, deludendo il padre che sognava per lui guadagni concreti.
Lesse i suoi versi che era poco più di un adolescente ed estasiò un pubblico di giovani: «Roma può darti tali e tante donne che puoi ben dire: “Ciò che è bello al mondo è tutto qui”».
Intraprese viaggi di piacere ad Atene, nel Vicino Oriente, in Sicilia, per poi stabilirsi a Roma, ricco di fascino, di spirito, di cultura e di denaro. Non era soltanto un lirico, ma anche un pratico: si sposò per tre volte, ebbe due divorzi e nessuno ha potuto tenere la contabilità delle sue avventure; perse la testa per una graziosa cortigiana, che nei versi piccanti degli Amores prese il nome di Corinna. Le donne gli piacevano «alte e piccole, tutte sono secondo il desiderio del mio cuore: le une e le altre mi conquistano... Il mio amore è candidato ai favori di tutte»; sembra in questi versi di sentir riecheggiare il Don Giovanni di Mozart. Il suo capolavoro, il poema Ars amatoria (L’arte di amare), si presenta in superficie come una specie di manuale di consigli per conquistare il cuore di una ragazza (contiene anche un trattato di cosmetica), un equivalente di tutto quello che si vorrebbe sapere sul sesso: «Impossibile dirti i mille luoghi per la caccia alle femmine. Più facile sarebbe in mare numerar la rena»; «Bada soltanto di non farle male, di non ferire le sue molli labbra, quando i baci le rubi, e che non possa dire che sono i tuoi rozzi e maldestri».
L’Ars amatoria è stata portatrice di un cambiamento che è iniziato nel Medioevo e si protrae fino ai nostri giorni... a causa di un equivoco. Malgrado si tenda a leggere il poema come un manuale di seduzione, era in realtà un’opera umoristica: i Romani lo leggevano e scoppiavano a ridere. Anche noi non riusciamo a nascondere un sorriso di fronte a certe «prescrizioni» che ci appaiono ingenue, come la raccomandazione, quando si porta l’amata al circo, di sollevare il lembo della sua tunica se striscia al suolo, così si potrà dare anche una sbirciatina alle sue caviglie senza che lei possa aver nulla da ridire. Tutte queste futili galanterie erano ridicole per gli antichi Romani quasi come lo possono essere per noi. Nel Medioevo, con la scomparsa della cultura antica, scomparve anche il concetto di ironia, e l’Ars amatoria fu presa per ciò che non era – un libro serio: da qui nacque l’«amor cortese», l’idealizzazione della donna, il tema del cavaliere il cui compito è di essere il protettore delle fanciulle nobili (cosa che rimase confinata nelle pagine dei romanzi cavallereschi e non ebbe mai un corrispettivo nella realtà), fino alla figura del «cavalier servente» settecentesco e ai più melensi attori e cantanti dei nostri giorni. L’amore romantico, come lo conosciamo oggi, nasce... da un errore di lettura di un’opera scritta oltre 2.000 anni fa!
La passione di Ovidio per le donne decretò la sua rovina: aveva appena finito di comporre le Metamorfosi concludendole con un’affermazione piuttosto orgogliosa («vivrò nei secoli»), che l’Imperatore lo mandò al confino a nella fredda e barbara Tomi (Costanza) sul Mar Nero, forse per aver avuto una «storia» con Giulia, la sua nipotina, come testimone o come complice o come protagonista.
Ovidio non aveva il temperamento di chi sapeva accettare la sventura e da quelle tristi contrade invocò il soccorso degli amici e il perdono di Ottaviano; descrisse la sua dimora come una roccia senza alberi, dove il sole era nascosto dalle nebbie e la neve rimaneva tutta l’estate, dove la popolazione era formata da un miscuglio di Greci e di Geti armati di coltello. Quando pensava al cielo di Roma e alle campagne di Sulmona il suo cuore si spezzava e la sua poesia raggiungeva una profondità di sentimento che non aveva mai avuto prima di allora. Dopo nove anni di esilio, salutò la morte come una liberazione; le sue ossa, come aveva chiesto, furono portate in Italia e sepolte nelle vicinanze della capitale. «I soli carmi ignorano la morte» fu il suo epitaffio. Era vero!