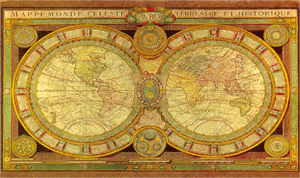Il Partito Comunista Italiano negli anni del
dopoguerra
Il grande partito della Sinistra italiana
seguiva ufficialmente una linea politica moderata e
contemporaneamente una linea favorevole alla lotta armata
per l’instaurazione di uno Stato di tipo sovietico
La questione è aperta, una parte del mondo della cultura riteneva il Partito Comunista Italiano un partito progressista e non particolarmente estremista, mentre altri parlavano della «doppiezza» di Togliatti e della sua linea politica. Effettivamente il Partito Comunista Italiano si distinse su molte questioni per la sua moderazione: prese l’iniziativa della amnistia per i reati commessi in tempo di guerra, votò a favore dei Patti Lateranensi, e in generale teneva un atteggiamento di collaborazione (fino al 1947) con gli altri partiti «democratici e popolari». Contemporaneamente il partito esaltava Stalin, si manteneva rigorosamente marxista-leninista, e non rinunciava alla dittatura del proletariato e al centralismo democratico.
La linea ufficiale del partito era quella espressa nel Congresso del dicembre 1945, la «democrazia progressiva». L’espressione appariva abbastanza sfuggente, non venivano abrogate le libertà politiche e civili, si richiedevano riforme sociali e una grande partecipazione popolare, come preparativo per la creazione di uno Stato socialista sul modello sovietico. In vari testi si affermava infatti che la forma più avanzata di democrazia era rappresentata proprio dallo Stato Russo. In quello stesso congresso i delegati si erano presentati armati con atteggiamenti di aperta sfida alle istituzioni. Il rapporto di polizia sull’evento parlava della impossibilità da parte delle forze dell’ordine di intervenire, e specificava: «Si notano elementi in uniforme con fazzoletto rosso e gradi, armati, che farebbero parte della “polizia del popolo”». Il Partito Comunista Italiano non rinunciava assolutamente all’idea di una conquista militare del potere, come riconosciuto dalla stessa ex dirigente del Partito Comunista Miriam Mafai, faceva ampio sfoggio delle armi nelle manifestazioni pubbliche.
La vita politica si era ripresa in Italia dopo il 25 luglio 1943, e molti antifascisti, dirigenti comunisti compresi, avevano espresso la loro totale contrarietà al governo Badoglio e alla Monarchia. Tale tendenza venne inaspettatamente contrastata da Togliatti quando nel marzo del 1944 rientrò in Italia, con le istruzioni di Mosca. Il messaggio di Stalin era chiaro, l’Unione Sovietica aveva ottenuto dei riconoscimenti dagli Angloamericani e pertanto il Partito Comunista doveva dar prova di moderazione sia verso il governo monarchico che verso gli altri partiti antifascisti. Ha scritto a tal proposito Renzo De Felice: «La disponibilità degli archivi russi non lascia più dubbi sul fatto che la politica del Partito Comunista Italiano – come quella del Partito Comunista Francese e degli altri partiti comunisti europei – fu concepita e diretta da Mosca».
Negli anni della guerra di liberazione il vertice del Partito Comunista si astenne da richieste eccessive anche se non mancarono delazioni e contrasti durissimi fra gruppi partigiani di cui la strage di Porzus (diciotto partigiani cattolici uccisi da un gruppo comunista) rappresentò l’evento più grave. Potrebbe essere utile ricordare che nel ’45 il Generale Cadorna comandante del CVL diede le dimissioni proprio per l’eccessiva indipendenza dei comandi partigiani. Anche sul problema sociale il Partito Comunista Italiano tenne posizioni piuttosto prudenti. Verso la fine del ’44 si ebbero occupazioni di terre e manifestazioni contro il carovita nel Meridione (trenta morti a Palermo) che non trovarono il sostegno del Partito Comunista. Nello stesso periodo si ebbero contrasti per la nomina del capo di governo, socialisti e azionisti si erano orientati sul conte Sforza, considerato un personaggio più innovatore, mentre i moderati preferivano Bonomi. Ottenuta la nomina di quest’ultimo, i due partiti di Sinistra si ritirarono dal governo, mentre il Partito Comunista Italiano si astenne dal fornire loro appoggio, e mantenne la sua presenza al governo. Anche successivamente il Partito Comunista Italiano, diversamente dagli altri partiti di Sinistra non mostrò particolare interesse per la nomina a capo del governo di Ferruccio Parri ritenuto l’uomo del cambiamento, espressione della nuova Italia partigiana, «il vento del Nord» come si diceva.
Terminata la guerra si aprì il dibattito sulla difficile situazione economica del nostro Paese. In una conferenza economica il Partito Comunista Italiano stabilì di privilegiare la ricostruzione economica sulla pianificazione e le riforme sociali, e non si oppose all’accordo fra CGIL e Confindustria per la eliminazione dei consigli di gestione che avevano esautorato i dirigenti aziendali, in cambio dell’introduzione della scala mobile. Nell’estate del ’46 si ebbe una nuova ondata di agitazioni per il carovita, a Mestre venne assaltato dalla folla un comando di polizia, mentre a Roma addirittura i disoccupati invasero il Viminale. Anche a seguito di ciò si ebbe un nuovo importante accordo fra sindacati e rappresentanti dell’industria che prevedeva cospicui aumenti salariali e altri miglioramenti, che contribuirono a ridurre almeno in parte la tensione nel Paese. Per quanto riguarda il clima politico, la pubblicistica del dopoguerra ha sempre messo in luce la grande adesione del Paese al mito resistenziale, tuttavia la questione non era così semplice ed esisteva una larga parte degli Italiani che avvertiva un notevole disagio verso di esso. Il grande successo giornalistico (quasi un milione di copie) e poi elettorale dell’«Uomo Qualunque», il giornale e il partito che irridevano alla retorica partigiana, metteva in luce una realtà molto più complessa.
Dove invece il Partito Comunista tenne una posizione gravemente contrastante con quella degli altri partiti, era sulla questione di Trieste, lì il Partito Comunista Italiano diede sostegno agli occupanti jugoslavi che si erano macchiati di orrendi delitti nei confronti della comunità italiana. Nonostante che fra il settembre e l’ottobre del ’43, al momento della dissoluzione del nostro esercito, fosse già avvenuta una terribile ondata di violenza contro gli Italiani, nell’ottobre dell’anno successivo Togliatti in una direttiva stabilì che «il nostro Partito deve partecipare attivamente, collaborando con i compagni jugoslavi nel modo più stretto, alla organizzazione di un potere popolare in tutte le regioni liberate dalle truppe di Tito (e anche prima di questa liberazione) e in cui esista una popolazione italiana. Questo vuol dire che i comunisti devono prendere posizione contro tutti quegli elementi italiani che si mantengono sul terreno e agiscono a favore dell’imperialismo e del nazionalismo italiano». La posizione sovietica era fortemente contraria agli interessi italiani, non solo Trieste, ma una parte notevole del Friuli doveva essere consegnata alla Jugoslavia. Tale politica diede vita a contrasti politici e ad una netta rottura con le altre formazioni partigiane che tentarono in qualche modo di prestare aiuto e difendere la popolazione italiana. Anche successivamente la posizione del Partito Comunista Italiano appariva ambigua, nel novembre del ’46 Togliatti si espresse a favore della inconsueta proposta di cedere Gorizia, città pienamente italiana, in cambio di Trieste, e contestò duramente Umberto Terracini per essersi espresso a favore dell’italianità di quella città. Il dirigente comunista, già precedentemente espulso dal Partito per aver criticato il Patto Molotov-Ribbentrop, subì una dura critica da parte del vertice del Partito per una precedente intervista con tale motivazione: «L’intervista esprime la tendenza falsa e pericolosa a mettere sullo stesso piano gli oppressori imperialisti… e gli Stati i quali, come l’Unione Sovietica, fanno una conseguente politica di difesa della pace». La vita interna del Partito di fatto non conobbe molte innovazioni, al di là del formale dibattito fra partito di quadri e partito di massa, vigeva uno stretto senso di subordinazione e disciplina. Venne ribadito il principio del centralismo democratico, la vita anche privata degli attivisti era sottoposta a controlli, e quando nel ’54 uno degli uomini di Secchia, Seniga, fuggì con il denaro del Partito, il suo superiore venne costretto ad una «lettera di autocritica» in pieno stile staliniano.
Nelle regioni del triangolo industriale, in Emilia Romagna e in alcune zone del Veneto all’indomani della fine della guerra si era creato un potere partigiano e comunista che sfuggiva completamente al governo di Roma. I prefetti erano di nomina del Comitato di Liberazione Nazionale, mentre molti gruppi partigiani erano stati inquadrati nella polizia. Migliaia di fascisti vennero passati sbrigativamente per le armi (15-18.000 complessivamente, 6.000 solo a Torino e Milano, 800 a Reggio Emilia, un numero quindi superiore alle uccisioni commesse dai nazisti durante la guerra che ammonterebbero a circa 9.000). Progressivamente si passò poi alla eliminazione dei nemici di classe. Già il 2 maggio il Generale Faldella parlò di tribunali di fabbrica che a Sesto San Giovanni avrebbero condannato a morte 110-120 persone (Gianni Oliva, La resa dei conti). D’altra parte le uccisioni di sacerdoti e proprietari terrieri che non avevano nulla a che vedere con la Repubblica Sociale erano iniziate già nella primavera del ’44. La mattanza dei fascisti, come è stata chiamata, non si esaurì nel giro di settimane ma proseguì specie nei centri di provincia nei mesi successivi (si trattava di fascisti liberati dai campi di concentramento che rientravano nelle loro case), per continuare in Emilia Romagna (anche come uccisioni di nemici di classe) a ritmo sostenuto fino al settembre dell’anno successivo, per concludersi nel 1949.
Gli Angloamericani arrivarono in tutte le città del Nord durante la prima settimana di maggio, tentarono di opporsi alla giustizia sommaria e di sequestrare le armi ma con poco successo. Contemporaneamente vennero istituite le Corti Straordinarie d’Assise formate da giudici ordinari e giudici popolari nominati dal Comitato di Liberazione Nazionale, ma i procedimenti avvennero in un clima di aperta intimidazione, complessivamente si ebbero 15.000 condanne di cui oltre 500 capitali, anche se poche (91) quelle effettivamente eseguite.
Alcuni di questi eccidi partigiani lasciano colpiti per l’alto numero delle vittime, Oderzo (Treviso) 1° maggio 113 morti, Valdobbiadene (Treviso) 4 maggio 45 morti, Valtellina (Sondrio) 4-7 maggio 107 morti, ospedale psichiatrico di Vercelli 12 maggio 75 morti, Cartiera di Carbonera (Treviso) primi di maggio 300-400 morti, Codevigo (Padova) 3-13 maggio 365 morti, carceri di Schio (Vicenza) 7 luglio 54 morti. In massima parte si trattava di militari e civili fascisti arresisi, e molte delle salme recuperate presentavano anche segni di torture. La maggior parte di questi eccidi non erano conseguenza della comune rabbia popolare, erano compiuti da squadre organizzate, e gli autori di molti di questi delitti e degli altri avvenuti negli anni successivi (466 persone) erano capi partigiani che una volta scoperti vennero fatti fuggire in Cecoslovacchia dai dirigenti del Partito Comunista.
Progressivamente nell’Emilia Romagna all’uccisione dei fascisti della Repubblica Sociale, subentrò l’uccisione di nemici di classe, religiosi, proprietari terrieri, dirigenti d’azienda, oltre a politici di partiti non comunisti o compagni caduti in disgrazia. In alcune zone si creò un vero regime del terrore, e molta gente benestante fu sottoposta a ricatto e costretta a pagare per non essere uccisa. A Castelfranco d’Emilia, nel modenese, si ebbero 42 persone uccise da una locale banda comunista nel periodo compreso fra aprile 1945 e ottobre 1946. Nello stesso periodo si ebbe l’uccisione di 27 proprietari terrieri in provincia di Ravenna, mentre in tutta la regione furono oltre 100. Altra categoria particolarmente presa di mira dai comunisti fu quella dei parroci e dei religiosi in genere, tutti registrati con regolarità dalle fonti ufficiali della Chiesa. Ammonterebbero a 130, dei quali 50 uccisi nelle zone controllate dai titini e 80 nel resto d’Italia. Anche nel resto del Nord si avevano situazioni estremamente gravi. A Milano operava la Volante Rossa che uccideva dirigenti d’azienda, esponenti politici non comunisti, e dava l’assalto alle sedi dei partiti moderati. In Piemonte nell’agosto del ’46 gruppi di ex partigiani riprendevano le armi e si arroccavano nelle valli dove avevano in precedenza combattuto per protestare contro la normalizzazione della vita politica. Altri episodi di violenza avvenivano anche a causa di gruppi dell’estrema Destra.
Contemporaneamente il Paese affrontava la questione dell’epurazione dei fascisti dalla Pubblica Amministrazione, la ricostruzione economica, e la questione istituzionale. A Sinistra tramontava rapidamente il Partito d’Azione e una profonda crisi colpiva il mondo socialista. Venne scoperto che molti attivisti del Partito Comunista avevano preso la tessera del Partito Socialista per condizionarne le scelte, in particolare per favorire la fusione o un impegnativo patto unitario. Nel novembre del ’46 Saragat parlò espressamente di una «quinta colonna» che lavorava per il predominio del Partito Comunista Italiano nella Sinistra, e di lì a poco decise l’uscita dal Partito Socialista e la creazione di un Partito Socialista Democratico filo occidentale.
I tristi eventi della Romagna erano solo un aspetto della questione, come riportato da molte fonti esisteva una struttura armata centralizzata comunista che faceva capo al numero due del Partito, Pietro Secchia, come egli stesso ammise nei suoi diari. Anche fonti americane e del nostro Ministero degli Interni parlavano di agenti jugoslavi che davano assistenza ai gruppi armati comunisti. Nel settembre del 1947 il vice di Togliatti, Longo, parlando alla conferenza del Cominform affermò: «Vi assicuro… che il nostro Partito dispone di un apparato clandestino di speciali squadre che sono dotate, per il momento in cui sarà necessario, di ottimi comandanti e di adeguato armamento». Miriam Mafai parlò di una manifestazione di partigiani a Roma che prima dell’arrivo avevano dato vita ad una intensa sparatoria. Non si ebbero ulteriori incidenti nella capitale. «Le armi erano rimaste sotto il giubbotto, anche se non c’era timore alcuno e ogni tanto si poteva vedere, con facilità, spuntare di sotto l’abito qualche manico di rivoltella e alla meno peggio gonfiori ben definiti sagomare certe giubbe». Nello stesso periodo in un incontro a Mosca (dicembre 1947) Stalin aveva dato sostegno alla linea più spregiudicata di Secchia rispetto a quella di Togliatti, tuttavia ricordava la ex dirigente comunista, che il dittatore si astenne dal garantire un pieno appoggio in caso di insurrezione. In quegli anni in Grecia i comunisti avevano dato vita ad una guerra civile particolarmente sanguinosa che aveva l’appoggio dei Paesi comunisti confinanti, se in Italia (e in Francia) non venne seguita la stessa strategia la ragione era probabilmente da ricercarsi nella difficoltà a prestare il medesimo tipo d’aiuto.
L’inverno 1946-1947 fu particolarmente duro in Italia come nel resto dell’Europa, la disoccupazione spingeva la popolazione a dure proteste, solo in parte contenute dalle concessioni di industriali e agrari che accettarono il cosiddetto imponibile di manodopera, l’obbligo dei proprietari terrieri ad assumere lavoratori anche oltre le reali necessità. Nel settembre del 1947 si tenne la conferenza per l’istituzione del Cominform, dove i rappresentanti di Mosca in seguito al peggioramento dei rapporti con gli Stati Uniti e la Gran Bretagna imposero ai partiti comunisti italiano e francese una politica più aggressiva. Togliatti si adeguò senza proteste, e accettò di nominare Secchia vice segretario del Partito su richiesta di Stalin senza la normale votazione del Comitato Centrale. Frutto di tale svolta fu uno dei più gravi atti nella vita politica del Paese, l’occupazione della Prefettura di Milano da parte di gruppi armati guidati da uno dei massimi dirigenti del Partito Comunista Italiano, Giancarlo Pajetta. Centinaia di ex partigiani armati e migliaia di operai per oltre ventiquattro ore bloccarono la città, imposero posti di blocco, occuparono gli uffici della Prefettura, la sede RAI, e assaltarono sedi di giornali e di partiti, finché su sollecitazione di Togliatti accettarono una trattativa col governo. Azioni in qualche modo simili si ebbero nelle settimane successive anche a Torino, a Roma e in altre città.
Nel periodo precedente alle elezioni del 18 aprile 1948, il Partito Comunista si impegnò su alcuni temi che determinarono la sua futura sconfitta: il rifiuto del Piano Marshall a cui andavano le speranze di tanti Italiani, e la valutazione positiva della soppressione della libertà in Cecoslovacchia. Leo Valiani ha scritto che i comunisti esaltavano quanto avvenuto a Praga come «una prova di democrazia politica… Chi li ascoltava traeva la conclusione che se Togliatti e Nenni avessero potuto disporre del 51% dei seggi nel futuro Parlamento Italiano, non avrebbero avuto scrupoli ad imitare la soppressione delle libertà democratiche avvenuta a Praga». A tali questioni si può aggiungere come ha scritto Paolo Emilio Taviani, la stanchezza anche da parte delle classi popolari per gli scioperi selvaggi inconcludenti e l’arrivo dei primi aiuti americani. La batosta elettorale fu molto pesante: il Fronte Popolare perse molti voti (9%) rispetto alle elezioni del ’46, e li perse proprio nel Nord dove aveva concentrato la sua azione politica. Sconfitto ma non domato, all’indomani dell’attentato a Togliatti il Partito Comunista si lanciava in una nuova confusa avventura con caratteristiche vicine a quella della insurrezione. Risultava evidente che l’attentatore non avesse alcun collegamento con i partiti di governo, tuttavia «L’Unità» gettava benzina sul fuoco. Le fabbriche del Nord venivano occupate dagli operai e presidiate con mitragliatrici, a Torino veniva fatto prigioniero nello stabilimento della FIAT Valletta con gli altri dirigenti, a Genova vennero circondate la Prefettura e la Questura, una situazione simile si ebbe a Venezia, in molte parti d’Italia vennero assaltate armerie, stazioni di polizia, sedi di partito, diversi carabinieri vennero uccisi o fatti prigionieri. Creò particolare tensione il blocco delle comunicazioni telefoniche che rafforzava l’idea di un imminente atto di forza. Al termine dell’insurrezione una nota della direzione di Pubblica Sicurezza affermava che erano stati sequestrati: «Cannoni, 28 – Mortai e lanciagranate, 202 – Mitragliatrici, 995 – Fucili mitragliatori, 6.200 – Fucili e moschetti da guerra, 27.123 – Pistole e rivoltelle, 9.945 – Bombe a mano, 49.460 – Esplosivi, Q/li 5,746». Gli storici si sono chiesti se tali eventi facessero pensare ad una precisa volontà di conquista militare del potere. Molti sono arrivati alla conclusione che non si possa escludere tale scelta. In particolare farebbe riflettere quanto affermato in quei giorni da Longo a un collega di Partito: «Se l’onda cresce lasciala montare, se cala soffocala del tutto». Anche da parte del governo, dei prefetti, e di De Gasperi risultava chiaramente l’idea che i comunisti si stessero preparando all’insurrezione. Il duplice insuccesso non spinse il Partito a seguire una nuova linea politica, il Partito Comunista Italiano immediatamente si allineò alla scomunica di Tito comminata da Stalin, e in generale tese ad irrigidirsi sulle sue posizioni.