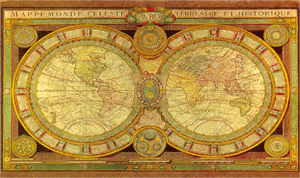Anatomia di un delitto
Esempi di giustizia slavo-comunista: la
condanna postuma di un ferroviere italiano
La grande tragedia del popolo giuliano, istriano e dalmata, protrattasi per i lunghi anni dell’Esodo e delle persecuzioni, si è tradotta in una serie interminabile di drammi personali e di efferatezze spesso allucinanti, ed ha coinvolto un numero assai elevato di cittadini italiani non autoctoni, che si trovavano nelle zone del confine orientale per ragioni del proprio ufficio: in primo luogo, tanti carabinieri, finanzieri e poliziotti, ma anche parecchi civili, con particolare riguardo a funzionari ed impiegati dello Stato. In effetti, secondo recenti valutazioni, oltre un quinto delle vittime «giustiziate» nelle foibe od altrimenti massacrate dai comunisti provenivano da altre regioni italiane, con priorità per quelle del Mezzogiorno.
Un caso per taluni aspetti surreale, anche sul piano strettamente giuridico, è quello del capostazione di Mattuglie-Abbazia, Giulio Tiribilli, che venne ucciso durante la «prima ondata» dell’autunno 1943, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre, a seguito di una non meglio specificata «condanna a morte del Tribunale Distrettuale di Fiume» che, come emerge da una comunicazione ufficiale del Ministero dei Trasporti (Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato) in data 6 maggio 1950, venne pronunciata addirittura nel 1948.
Le condanne «postume» da parte slava non costituiscono una novità: anzi, furono ricorrenti nei molti casi in cui si voleva promuovere un «fumus juris» idoneo a giustificare le esecuzioni sommarie, e soprattutto il sequestro dei beni personali delle vittime, come accadde ripetutamente, sia nella Venezia Giulia che in Dalmazia (a tale perverso «escamotage» si fece ricorso, fra gli altri, per la famiglia Luxardo, titolare dell’omonima azienda di Zara). La condanna di Tiribilli appare a più forte ragione immotivata e moralmente offensiva, sia per il tempo trascorso, sia perché il Capostazione di Mattuglie-Abbazia viveva del proprio lavoro e non poteva certo avere grandi ricchezze, anche se taluni partigiani particolarmente famelici non disdegnavano l’appropriazione dei beni più modesti.
Non è dato sapere quali colpe siano state addebitate a Giulio Tiribilli, nato nel 1896 in provincia di Firenze: un ottimo cittadino italiano che aveva la fedina penale totalmente pulita come risulta dall’attestato prodotto dall’Autorità competente prima dell’assunzione; che aveva compiuto il normale servizio militare di cui al foglio di congedo rilasciato dal Comando distrettuale; e che aveva ben meritato nel suo lavoro in ferrovia, dapprima presso la stazione di Villa del Nevoso, e poi, dopo essere stato promosso al grado superiore, presso quella di Mattuglie-Abbazia, dove aveva assunto l’incarico nell’aprile 1931.
La storiografia giuliana, istriana e dalmata non manca di sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi la sola colpa delle vittime fu quella di «essere Italiani». Per Giulio Tiribilli l’affermazione risulta a più forte ragione condivisibile, anche alla luce del suo curriculum: d’altra parte, non è forse vero che «l’odio degli Slavi» si rivolse, fra i tanti massacri, contro braccianti, messi comunali, minatori, ostetriche, spazzacamini, e via dicendo? Oggi, ad oltre 70 anni dai fatti, restano soltanto alcuni freddi documenti che attestano quanto accadde, nel linguaggio formale della burocrazia, ma pur sempre idonei a sottolineare che il delitto contro l’umanità perpetrato a danno degli Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia non ebbe attenuanti di sorta; e che ebbe, caso mai, l’aggravante di indicibili sevizie, talvolta documentate ma più spesso rimaste tristemente ignote.
La stessa indicazione secondo cui Giulio Tiribilli sarebbe stato fucilato deve essere presa con beneficio d’inventario, al pari di tutte le sentenze «postume» che, oltre a quelli citati, ebbero lo scopo di cancellare dalla memoria collettiva dei superstiti ogni riferimento al «trattamento» disumano riservato in tanti casi ai «nemici del popolo» condannati a morte da un’altrettanto fantomatica «giustizia popolare». Non è inverosimile che anche il capostazione sia stato oggetto di chissà quali angherie dopo la cattura, come accadde nello stesso distretto di Abbazia, fra i tanti, al Senatore Riccardo Gigante, proditoriamente massacrato a Castua, od al maestro Giuseppe Tosi, vilmente ucciso nelle acque dell’Adriatico.
Un’ultima considerazione deve essere formulata a proposito di questa singolare «giustizia postuma» e dei rarissimi processi «regolari» orditi a guerra finita contro qualche condannato di particolare rilevanza militare o politica, come Stefano Petris, Eroe della difesa di Cherso, o Vincenzo Serrentino, ultimo Prefetto di Zara italiana: ciò, onde accreditare nell’opinione pubblica l’immagine di un’improbabile quanto velleitaria conformità al nuovo «diritto proletario». In questi casi sarebbe davvero impensabile concedere che le condanne siano avvenute in ossequio alla ragione di Stato intesa quale «eccesso» giudiziario motivato dalla pubblica utilità; al contrario, bisogna ribadire che quei procedimenti furono sceneggiate non meno allucinanti delle esecuzioni sommarie a furor di popolo, in cui si fece strame del diritto e dell’ethos.