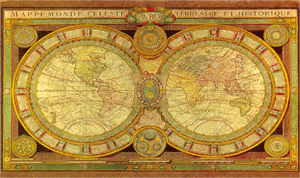La canapa, una semi-sconosciuta ricchezza di
Ferrara
Ciò che vale non muore mai
Le origini della canapa in Italia risalgono all’antichità; probabilmente si trovano fra il X e l’VIII secolo avanti Cristo e la canapa si espanse con continuità, come dimostrano documenti dell’epoca rinascimentale. Essa è stata un’importante protagonista dell’economia dello Stato e di alcune regioni d’Italia, fino a tutta la prima metà del XX secolo, facendo parte della vita quotidiana della gente di campagna e del paesaggio agrario. La coltivazione della canapa, fino agli inizi del Novecento, era a macchia di leopardo, un po’ di qua, un po’ di là, in tutto il territorio nazionale, con particolare sviluppo in Romagna, in Toscana, nelle Marche. A quei tempi serviva soprattutto a soddisfare i bisogni dei contadini, raramente usciva dal mercato locale. Agli inizi del Novecento, gli ettari di terreno agricolo coltivati a canapa in Italia erano circa 80.000; di questi, attorno alla metà, erano in Emilia Romagna.
La coltivazione della canapa era un’attività fiorente, pur se molto impegnativa e faticosa: basti pensare che nei primi trent’anni del Novecento l’Italia fu al secondo posto nella produzione della canapa dietro solamente all’Unione Sovietica, con lo sfruttamento di circa 80.000 ettari di suolo e poco meno di 800.000 quintali prodotti. È riportato che, nel 1914, Ferrara era al primo posto con 30.000 ettari di terreno occupati e 363.000 quintali prodotti, seguita nell’ordine dalla provincia di Caserta (157.000 quintali) e Bologna (145.000); nel Napoletano, la produzione fu di circa 89.000 quintali.
Subito dopo l’ultima guerra, fino al 1954, la canapa coltivata era quella di tipo industriale, la «Cannabis sativa», per chiarire. Era estesa e molto insediata e radicata fra le colture allora in grande espansione su una pianura piano piano strappata alla malaria degli acquitrini, grazie alle lunghe, faticose e dispendiose bonifiche che hanno interessato il Delta del Po. L’aspetto della pianura era di un’estensione territoriale ad andamento monotono, piatta e senza interruzioni, se si esclude qualche viale di altissimi pioppi usati per fare da cornice alle lunghissime carrarecce che portavano alle fattorie. A quei tempi, erano tre i tipi di colture che si alternavano e avvicendavano nel corso dell’anno: il grano, le barbabietole, la canapa. Altre colture, come quelle del mais, dell’erba medica, degli ortaggi, per ricordarne qualcuna, erano di importanza minore. Le tre colture in concreto segnavano il succedersi delle stagioni. Il grano da ottobre alla prima parte dell’estate, cioè a giugno, la barbabietola da primavera a luglio e la canapa dalla primavera a quando i semi iniziavano a cadere al suolo, pertanto in modo scalare, per non raccogliere le piante né troppo verdi né troppo secche; comunque verso la fine dell’estate.
A primavera si godeva (e naturalmente, si gode tuttora) la visione della successione di campi verdissimi con piantine filiformi come quelle dell’erba che piano piano s’allungavano, portando in cima le spighe piene di chicchi sempre più di un giallo dorato; a questi si alternavano estese coltivazioni caratterizzate dai ciuffi formati dalle grandi e verdi foglie delle barbabietole da zucchero, che poi, dopo essere sradicate e private della fronda e stese o ammucchiate al sole, si presentavano a terra in lunghi filari con il loro candore da ossa scarnificate, in attesa del compiersi del loro destino previsto dall’uomo negli zuccherifici. (Non so se altri la pensino alla stessa maniera, ma per me è stata del tutto incomprensibile l’eliminazione della coltivazione della barbabietola a favore dello zucchero di altri Stati Europei: in Italia, gli zuccherifici, se non ricordo male – allora facevo la «campagna» estiva quale chimico, in attesa della laurea – erano fra i 40 e i 50; ora ne sono rimasti 2, ma non so nemmeno se siano o meno ancora in attività). Ora, sono abbondanti le coltivazioni di mais, frutteti a mele, pesche e pere, erba medica, soia con più produzioni ogni anno, eccetera.
Scomparso il grano agli inizi dell’estate e la barbabietola poco più tardi, a svolgere il compito di riempire la campagna rimaneva la canapa, a parte qualche coltivazione particolare, come si è detto più sopra. Gli steli, lunghi, dritti e sottili, poiché erano talmente fitti che si allungavano per emergere in concorrenza fra loro a cercare quel sole che è indispensabile affinché avvenga la vitale fotosintesi clorofilliana, raggiungevano l’altezza di quattro o cinque metri. (D’altra parte, lo scopo dei canapicoltori era quello di ottenere fibre il più lunghe e il più regolari possibile, tutto a vantaggio della qualità e ovviamente del prezzo esigibile). La campagna acquistava la caratteristica connotazione del paesaggio torrido, afoso e appiccicoso della Pianura Padana, macchiata dal suo verde intenso, dando l’impressione di un’estensione di boschi formati da piante destinate al taglio a maturazione avvenuta, e caratterizzata dall’odore caratteristico che si diffondeva dai semi. In quel periodo, i lavoratori, uomini e donne, raggiungevano le canapaie a frotte, chi a piedi e chi in bicicletta, con cappelli di paglia in testa e grandi fazzoletti al collo per difendersi dalla polvere vegetale che cadeva dalla cima delle piante e che provocava prurito sulla pelle nuda, vestiti costituiti da protettivi panni di lana, che purtroppo facevano sudare per il caldo torrido e umido caratteristico del clima continentale del territorio, si inoltravano armati di falci e falcette lungo i filari di steli alti e fibrosi. Si diceva da noi: «Al canvìn l’andava su pr’al nas e al’s tacava al sudor» («Il canapino» – da «canva» = canapa in ferrarese – «saliva dentro il naso e si attaccava al sudore»).
Le piante erano tagliate e sistemate a formare mannelle e legate in grosse cataste; quindi erano messe a galleggiare nell’acqua delle centinaia di maceri esistenti nei territori di produzione, riempiti solo in occasione della macerazione della canapa. Per tutto il resto dell’anno, dopo lo svuotamento necessario per eliminare i cattivi odori, i maceri restavano asciutti oppure si riempivano di acqua nuova, magari per avere a disposizione acqua per innaffiare i campi vicini in caso di siccità o per allevare pesci gatto; qualcuno approfittava del fondo asciutto per fare orticelli dai quali produrre qualche verdura. I maceri si riconoscevano a distanza nei mesi lontani dalla macerazione (a riposo), perché sulle loro sponde facevano bella mostra di sé i grandi cumuli di grossi sassi di origine fluviale, prelevati dai torrenti montani, che servivano a tenere immersi completamente nell’acqua i fasci di canapa fresca. In quei periodi, le «maledizioni» erano fresche di giornata, dovute sia al puzzo prodotto dalla macerazione della canapa, sia agli sciami enormi di zanzare sloggiati dalla rimozione dei canapeti; e non mancavano i tafani che, però, preferivano accanirsi contro i bovini, perché non in possesso dei mezzi di difesa dell’uomo. Dopo una settimana, a macerazione avvenuta, si passava al lavaggio, fatto direttamente in acqua dai lavoratori immersi sino alla cintola nel putridume che si era formato. (Ciò creava non irrilevanti problemi di igiene personale e di vita in comune, che imponeva plurime abluzioni e uso di essenze profumate). Poi, messa in caselle (cumuli conici, vuoti all’interno come i «wigwam», le capanne degli Indiani d’America), la canapa si faceva seccare al sole. All’essiccamento seguiva la tiratura che, in base alla lunghezza delle piante, stabiliva la qualità della fibra vegetale, che è tanto più pregiata quanto più è lunga. Così, le mannelle in quantità erano appoggiate su una specie di cavalletto e battute dalla parte del taglio con una pala di legno piatta per ottenere una superficie pareggiata; quindi, si afferravano con le mani nude (i guanti da lavoro furono un’invenzione successiva) le cime delle piante più lunghe e si «tiravano» fuori dalla massa, facendo via via una selezione, fino a giungere alle piante pigmee che rappresentavano uno scarto. Queste ultime solitamente erano quelle di contorno alla piantagione, perché, essendo in piena luce, non avevano bisogno di allungarsi per ricevere il sole necessario alla fotosintesi clorofilliana. In seguito, toccava alla cilindratura (qualcuno la chiamava stigliatura o scavezzatura), che rompeva la parte legnosa delle piante al loro passaggio in mezzo a cilindri dentati azionati o da una locomobile a vapore (motore termico trainabile con ruote) o da un motore a scoppio monocilindrico a testa calda (Landini). Quindi, con la gramolatura eseguita a mano, si attuava la decanapolizzazione che separava la corteccia fibrosa dai canapoli frantumati. Dopo la pettinatura, si passava alla filatura per mezzo del fuso o del filatoio («al filarin»); in seguito, l’aspatura per ottenere matasse, la sbiancatura e infine la tessitura. Talora, i tessuti erano arricchiti da disegni ottenuti con stampi di legno con il metodo della xilografia.
I tessuti di canapa erano freschi, belli, resistenti, portabilissimi. Come sottoprodotto si avevano i «canapoli» («sticch» in ferrarese, cioè «stecchi»), che servivano per accendere o ravvivare il fuoco nel camino o nelle stufe, anche se produttori di un fumo acre. Qui, nella prima parte del Novecento, si diceva che costituivano il combustibile atto a fornire il vapore necessario alla piccola vaporiera che, con i suoi vagoncini, collegava la città con il Mare Adriatico, trasportando merci e vacanzieri «ante litteram».
La popolazione migliorò il suo tenore di vita con lo sviluppo economico che si ebbe alla ripresa dopo la Grande Guerra. Ma ciò, se fu un bene da un lato, dall’altro portò la coltivazione della canapa a una crisi devastante, che più nera di così non poteva essere. Infatti, se erano disponibili posti di lavoro meno pesanti, faticosi e impegnativi, nello stesso tempo il progresso tecnologico aveva messo in commercio fibre artificiali, che in breve ebbero un’affermazione invidiabile tale da mettere in ginocchio la produzione della canapa e del lino, altra fibra tessile vegetale veramente bella e valida. In sostanza, gli stabilimenti denominati «linificio» e «canapificio» erano diventati superati, obsoleti. La crisi della canapa aprì la strada alla preparazione di frutteti, che già avevano iniziato a dominare le campagne romagnole (Cesena) e modenesi (Vignola). Gli ultimi sussulti di vita della canapa si ebbero negli anni Sessanta in Campania, per sparire definitivamente dallo scenario agrario italiano. Infatti, la chimica delle fibre artificiali (l’ecologia era ancora lontana nel tempo) convinse il Governo a favorirle, dando così il colpo di grazia alla canapa.
Come l’araba fenice, nel 1997, essa fece la sua ricomparsa, anche se non dalle sue ceneri, quando a Ferrara si sono riprese operazioni di ricerca, studi, sperimentazioni che la riportarono a una rivalorizzazione. Il Comitato Promotore, costituito da diversi enti di Ferrara, Ostellato e Comacchio, s’interessò alla partita. Ci si propose di individuare i semi migliori e di avviare ricerche aventi lo scopo di migliorare le tecnologie produttive per ridurre i costi – sicuramente proibitivi –, per facilitare fra l’altro le operazioni sempre faticose e sicuramente poco igieniche, facendo riferimento ai maceri e al lavaggio dei fasci in putrefazione. In verità, chi pensava che la canapa non fosse del tutto finita si diede da fare per trovare soluzioni all’effettuazione della macerazione in una maniera meno pestilenziale per quanto riguarda le esalazioni fetide messe in circolazione e meno in contrasto con l’igiene personale. Tanto che le soluzioni prospettate, con un attento occhio alla tecnologia, sono state addirittura quattro, chiarite di seguito. La prima prevede la macerazione in acqua corrente, da compiere in piccoli corsi d’acqua o rigagnoli; infatti, l’acqua corrente non rende necessaria la presenza di gente in acqua che lavi le mannelle e porta via i cattivi odori; purtroppo, però, gli scarti organici risultano dannosi per gli abitanti dell’ambiente liquido. Un’altra si basa sull’uso di acqua calda addizionata a soda caustica; ma le esalazioni liberate mettono il metodo in notevole difficoltà. Una terza si fonda sulla macerazione biologica: prima di tutto è prevista la stigliatura, che rompe e in parte allontana i canapoli, cioè gli steli, poi si ricorre all’intervento di batteri capaci di degradare la materia cellulare. Il metodo è veloce e di pratica applicazione e, per di più, è poco impattante sull’ambiente. Ultima, ma non ultima per importanza, la macerazione con l’impiego di enzimi prodotti da batteri e da funghi. Soluzione interessante che non richiede tecnologie troppo avanzate, fornisce fibre forti e, inoltre, gli scarti di lavorazione sono biodegradabili.
La coltura fu avviata su 250 ettari di terreno a titolo sperimentale. Ci fu un interessante contatto con la moda: infatti, una ditta con il marchio Armani produsse jeans, maglie, scarpe, camicie, borse e accessori per uomo, donna e bambini, che entrarono a far parte della collezione primavera-estate 2000 «Armani Jeans». Grazie al successo ottenuto, l’anno successivo gli ettari coltivati a canapa divennero 1.500, anche perché una buona parte era richiesta dall’industria della carta con l’indicativo scopo di limitare l’abbattimento di alberi. La canapa, secondo qualcuno, fornisce non meno di 50.000 prodotti da utilizzare nei settori tessile, cartario, cosmetico (oli e saponi), alimentare, erboristico, farmaceutico, edilizio, biologico, nell’allevamento degli animali, nella preparazione di truciolati per la costruzione di mobili e in altro ancora.
Dunque, tutto bello, tutto facile? Eh, no, purtroppo! Bisogna ritornare a quando la Legge Jervolino-Vassalli, emanata contro il consumo della droga, v’inserì pure la canapa, facendo una barbina confusione fra le varietà di «Cannabis», che nelle loro infiorescenze femminili contengono un’elevata percentuale di THC (tetraidrocannabinolo), una sostanza allucinogena, che serve per ricavare hashish e marjuana, e quelle che lo contengono in percentuale trascurabile. La canapa ne è quasi del tutto priva, pertanto non ha nessun effetto psicotropo.
La canapa può servire in svariate occasioni. In effetti, si ritiene che dalla pianta si possano ricavare, naturalmente oltre alla fibra tessile, fino a più di 50.000 sostanze, che vanno dal campo tessile a quello cartario, dalla cosmesi (oli e saponi) all’industria alimentare, dall’erboristeria alla farmaceutica, dall’edilizia biologica all’allevamento degli animali, ai truciolati per mobili. A parte l’uso terapeutico della canapa con il grado di antidolorifico (che è diffuso non solo in Italia), le varietà sono diverse e fra queste molte sono con un contenuto in THC inferiore ai limiti di legge. Ma il Ministero delle Politiche Agricole autorizzò la coltivazione della canapa in modo molto costrittivo; infatti è un’assurdità che i campi a canapa debbano essere: a) recintati, b) illuminati di notte, c) assiduamente controllati (sic!). Chiaramente, tali notevoli condizioni, motivatissime nel caso di produzione di droga, non sono applicabili al coltivatore di canapa industriale perfettamente autorizzata, che corre il rischio che qualche pattuglia, non a conoscenza delle diversità esistenti fra le varietà di canapa, la sequestri e lo denunci per tale reato quale individuo malavitoso. In Francia, la legge è molto più conciliante: nei primi anni Novanta, si è avuta la produzione di circa 30.000 quintali di fibra. Le piante, contenenti più del 90% di cellulosa, aspettano di essere coltivate.
E in Italia, dal 2016, la sua coltivazione è ritornata legale.