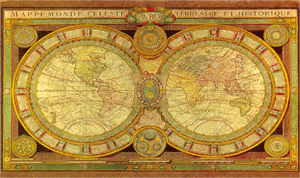Esodo e foibe
Consiglio Regionale della Toscana –
Firenze
Seduta solenne del 10 febbraio 2012 per il «Giorno del
Ricordo»
Seduta solenne del 10 febbraio 2012 per il «Giorno del Ricordo»
«Meminisse juvabit» (Virgilio).
Si compiono sessantacinque anni da quel triste 10 febbraio 1947 che vide la firma del Trattato di pace con le quattro Potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e con i loro diciassette Alleati. In tutta Italia, a mezzogiorno, furono osservati dieci minuti di silenzio in segno di civile ma ferma e generale protesta: il terzo governo De Gasperi, che era entrato in carica da pochi giorni, aveva deciso di prescindere dal parere dell’Assemblea Costituente cui sarebbe stato affidato un compito quasi notarile di successiva ratifica, e di procedere alla firma di una sostanziale imposizione. Non a caso, il documento è stato definito, sia nell’accezione corrente, sia in sede storiografica, col termine sintetico ma emblematico di «diktat».
Alcide De Gasperi, il Presidente del Consiglio che in sede di Conferenza della pace aveva iniziato il suo intervento in assemblea plenaria dicendosi certo di poter contare sulla semplice «cortesia personale» dei propri interlocutori e nulla più, ad onta dello «status» di Paese cobelligerante a fianco degli Alleati riconosciuto all’Italia già dall’ottobre 1943, si era trovato in condizioni difficili anche dal punto di vista diplomatico. Infatti, appena un mese prima, aveva compiuto un viaggio molto impegnativo negli Stati Uniti assieme al Ministro Campilli e ne era tornato con l’accredito di 150 milioni di dollari, un terzo dei quali a fondo perduto come «compenso» per la collaborazione prestata durante la permanenza delle truppe americane in Italia. Ne era scaturita una sovranità italiana a più forte ragione limitata.
Quella cifra, insomma, assumeva rilievo fondamentale per un’economia d’emergenza impegnata nel grande sforzo della lunga ricostruzione ma implicava l’amara necessità di firmare un Trattato particolarmente duro senza attendere la ratifica dell’Assemblea Costituente che sarebbe sopraggiunta soltanto il 31 luglio successivo, con 262 voti favorevoli, 80 astenuti e 68 contrari, tra cui quelli di Benedetto Croce e di Vittorio Emanuele Orlando, suffragati da motivazioni di alto spessore politico, e prima ancora, di sano patriottismo e di forte valenza morale. È il caso di sottolineare come due quinti dei Padri Costituenti, sia pure in condizioni di sovranità «affievolita», abbiano avuto il coraggio di non approvare il «diktat».
Del resto, il Trattato di pace era stato oggetto di immediata applicazione prima della ratifica italiana, a quel punto sostanzialmente pleonastica, eticamente opinabile, ma formalmente necessitata, visti i nuovi obblighi assunti con gli Alleati.
Con questo Trattato l’Italia perdeva le colonie, fatta eccezione per la Somalia che le venne affidata in amministrazione fiduciaria per dieci anni, le isole dell’Egeo trasferite alla Grecia ed i piccoli distretti alpini di Briga, Tenda e Moncenisio passati alla Francia, ma subiva un’amputazione di particolare ampiezza col trasferimento a favore della Jugoslavia della sovranità nazionale sulla Dalmazia, sull’Istria e su buona parte della Venezia Giulia, senza contare la stessa Trieste, per cui venne ipotizzata la costituzione di uno Stato indipendente, il cosiddetto Territorio Libero (ne sarebbe scaturita una serie di problemi a lungo termine, risolti dal Trattato di Osimo del 1975, quando l’Italia avrebbe rinunciato senza contropartite alla sovranità sulla cosiddetta Zona «B» del Territorio medesimo già affidata all’amministrazione civile jugoslava, chiudendo il contenzioso in un’ottica subordinata nonostante la forza contrattuale italiana, ben diversa dalle modeste condizioni del 1947 ed ormai oggettivamente superiore).
Non si tennero in alcun conto le attese del popolo giuliano, istriano e dalmata, nonostante la partecipazione dei suoi rappresentanti alla Conferenza della pace di Parigi e la pur lunga visita di una Delegazione Alleata da cui erano sorte motivate speranze, se non altro per conservare all’Italia, oltre a Trieste, la costa occidentale dell’Istria ed in particolare la città di Pola. In tale occasione quel popolo fu veramente «oggetto di storia», come avrebbe detto Machiavelli, perché i delegati non seppero o non vollero farsi protagonisti di un’indagine a tutto campo in chiave etnica, storica e culturale, e soprattutto, scevra da pregiudizi.
Le speranze erano improntate ad un elementare senso di giustizia perché non sembrava logico che il prezzo della guerra perduta fosse pagato con la cessione di tante città ad alta maggioranza italiana, e di due regioni pari al 3% del territorio nazionale, a favore di chi si era seduto al tavolo delle trattative di pace senza avere avuto alcun riconoscimento ufficiale per buona parte del conflitto: infatti, il Maresciallo Tito e le sue formazioni si videro accreditare la rappresentanza del proprio Paese soltanto negli ultimi sedici mesi di guerra, quando gli Alleati decisero di preferirlo al governo legittimo, in esilio a Londra sin dalla primavera del 1941 dopo il colpo di Stato con cui la Jugoslavia si era dissociata dall’Asse.
Sembrava inammissibile che le vittime designate fossero Giuliani, Istriani e Dalmati, costretti ad un Esodo plebiscitario che avrebbe coinvolto circa 350.000 persone, pari al 90% della popolazione, indotta a questa drammatica scelta per la civiltà e la giustizia, ma prima ancora, per la vita. Il disegno di pulizia etnica che in tempi successivi sarebbe stato ammesso senza reticenze dai maggiori luogotenenti di Tito, quali Milovan Gilas e Edvard Kardelj, aveva già assunto la dimensione di una grande tragedia collettiva nella prima ondata del settembre 1943 ed in quella più vasta del 1945, protrattasi ben oltre la fine della guerra, quando trovarono la morte nelle profondità delle foibe carsiche, nelle cave dell’Arsa, nelle acque dell’Adriatico e nei campi di prigionia jugoslavi decine di migliaia di Italiani, oltre a tanti Croati e Sloveni oppositori del nuovo regime.
Il metodo preferito per uccidere le vittime, talvolta dopo una farsa di processo davanti ai tribunali del popolo e molto più spesso in un’ottica indiscriminata, non senza torture, violenze e stupri, era quello dell’infoibamento, che aveva modo di farle scomparire per sempre, ma non mancarono frequenti fucilazioni sommarie, colpi di pistola alla nuca, lapidazioni ed altre particolari efferatezze. L’estremo sacrificio coinvolse, fra gli altri, centinaia di sacerdoti (tra i quali si deve ricordare l’esempio emblematico di Don Francesco Bonifacio, il parroco di Villa Gardossi in odore di santità) e tante donne, con un accanimento a più forte ragione gratuito. È inutile aggiungere che la massima parte di quelle vittime è rimasta senza una tomba su cui deporre un fiore, e che soltanto alcune centinaia furono recuperate nello scorcio conclusivo del 1943, dopo il momentaneo ripristino dell’autorità italiana: quanto basta per comprendere come spesso fossero vive quando venivano precipitate in foiba, talvolta legate tra di loro, o comunque immobilizzate, e per capire quale strazio allucinante ne accompagnasse una disperata agonia, in specie nelle foibe relativamente meno profonde (poche decine di metri contro centinaia di altre), dove la tragica sopravvivenza prima della morte liberatrice, testimoniata dalle urla provenienti dagli anfratti del sottosuolo, poteva durare persino qualche giorno.
Vale la pena di ricordare che le donne, infoibate a centinaia, erano state oggetto di ripetute violenze prima dell’ultimo oltraggio. Alcune delle loro storie sono diventate un emblema del martirologio giuliano, istriano e dalmata: è il caso di Norma Cossetto, giovane studentessa assassinata nella foiba di Villa Surani nell’ottobre 1943; di Bianca Ronzoni Luxardo, annegata assieme al marito nelle acque di Zara con addosso una pietra, nel settembre 1944; delle sorelle Albina, Caterina e Fosca Radecca (la prima delle quali in avanzate condizioni di gravidanza), infoibate a Terli; di Giulia Venezia, scomparsa a Gorizia nelle tragiche giornate del maggio 1945 ed uccisa in surreale spregio del suo nome, simbolo di italianità e di patriottismo anche in chiave semantica.
Caddero tanti bambini: in seguito si è voluto negarlo, ma l’evidenza dei fatti, come avrebbe detto Giusti, è «lì che parla a chi la vuol sentire». Basti citare la testimonianza giurata di Mario Maffi, un ufficiale piemontese degli Alpini che nel 1957 effettuò alcune prospezioni in diverse foibe tra cui quella di Monrupino, trovando anche uno scheletro infantile (ed un altro appoggiato alla parete rocciosa, a dimostrazione del fatto che in qualche caso la morte non era stata istantanea). Né si possono dimenticare (come si dirà diffusamente trattando dell’Esodo da Pola) i troppi bambini e minorenni scomparsi nella strage di Vergarolla del 18 agosto 1946.
Il numero esatto delle vittime, che in ampia maggioranza vennero uccise a guerra finita, è di ardua quantificazione. Secondo la ricerca più esauriente, effettuata da Luigi Papo de Montona, protrattasi per decenni e confortata da un esaustivo elenco di nomi, si colloca nell’ordine delle 16.500, comprensive di tutti coloro che scomparvero in mare o nei campi jugoslavi. In altri termini, non si è lontani dal vero affermando che in Venezia Giulia e Dalmazia un Italiano su venti perse la vita nel corso di quello che Italo Gabrielli, con felice sintesi, ha definito un vero e proprio «genocidio programmato».
In qualche caso, assieme alle vittime delle foibe veniva precipitato nell’abisso un cane nero, che intendeva esprimere, alla stregua di interpretazioni ricorrenti, motivi di ulteriore disprezzo. Secondo un mito balcanico l’animale avrebbe latrato in eterno, togliendo ai defunti anche la pace dell’aldilà.
La conoscenza di questi eventi altamente drammatici non aveva lasciato dubbi sul disegno in atto ed aveva fatto scegliere l’Esodo a quanti potevano contare su opzioni familiari convenienti, ma in molti casi il popolo istriano e giuliano non volle abbandonare la speranza perché confidava in una soluzione diplomatica che non penalizzasse oltre misura le sue attese. In effetti, Dalmati e Fiumani compresero subito, se non altro per naturali ragioni geografiche, che per le loro terre non si poteva prevedere salvezza e molti di loro partirono in massa, mentre a Pola e nell’Istria si volle coltivare l’illusione fino a quando la notizia del «diktat» fece svanire ogni residuo sogno.
Durante la Conferenza della pace l’atteggiamento delle Delegazioni Alleate non era stato univoco ed aveva alimentato le speranze, in specie dei Polesi, che avevano presunto di salvaguardare la loro città in una sorta di «enclave» simile a quella storica di Zara, che nel 1919 era diventata l’unico centro italiano in una Dalmazia trasferita integralmente alla nuova Jugoslavia (vanificando le promesse del Patto di Londra stipulato nell’aprile 1915), e subito abbandonata da una larga maggioranza della popolazione italiana. In effetti, quest’ultima era riuscita a resistere sotto il vecchio Impero Austro-Ungarico, nonostante parecchie vessazioni, ma non prese neppure in esame l’eventualità di restare in presenza del nuovo regime: chi fosse rimasto senza aderire al suo verbo si sarebbe candidato alla persecuzione ed alla foiba.
A Parigi, l’intransigenza sovietica, espressa incisivamente dal Ministro degli Esteri Molotov, si era trovata in netto contrasto con l’apertura americana mentre il prudente possibilismo inglese aveva trovato l’opposizione di pregiudiziali francesi non immemori del comportamento assunto dall’Italia nel giugno 1940 con la dichiarazione di guerra ad uno Stato ormai sconfitto dalle armate tedesche. Il Presidente De Gasperi ed il Ministro degli Esteri Sforza non seppero volgere a proprio favore quelle divisioni e trarre vantaggio dalla maggiore disponibilità statunitense: la storia della Venezia Giulia, al pari di quella italiana, è contraddistinta da una lunga serie di occasioni non colte.
Il grande Esodo ebbe luogo in tempi diversi. Dalmati e Fiumani, come si diceva, furono i primi, mentre buona parte degli Istriani e la quasi totalità dei Polesi concentrarono le partenze nel 1947, per lo più tra gennaio e marzo, e comunque non oltre il 15 settembre. Fu questa la data del trasferimento effettivo di sovranità e di consegna delle chiavi di Pola, una grande città quasi deserta dove erano rimaste non più di 2.000 persone, nelle mani di Ivan Motika: un personaggio che in tempi successivi sarebbe tornato alla ribalta quale imputato (assieme ad Oskar Piskulic ed Avjanka Margetic) nel processo contro gli infoibatori tenutosi a Roma e conclusosi con l’accertamento di precise responsabilità storiche ma senza condanne, per una presunta quanto infondata carenza di giurisdizione.
Le immagini di una tragedia più grande furono simbolicamente riassunte, agli occhi dei posteri, dai viaggi di un piroscafo carico di profughi polesi dolenti che salutavano per l’ultima volta la propria città cantando lo strazio dell’addio sulle note di Giuseppe Verdi: si trattava del famoso Toscana che durante la guerra era stato utilizzato come unità da trasporto e poi come nave ospedale, e che al momento costituiva quanto di meglio poteva essere messo a disposizione dalla Marina Italiana, ridotta ai minimi termini dagli affondamenti e dalla consegna delle migliori unità superstiti alle Potenze vincitrici.
La vigilia dell’Esodo da Pola fu resa più drammatica dal citato eccidio di Vergarolla del 18 agosto 1946, in cui persero la vita oltre cento vittime, in maggioranza donne, madri di famiglia e bambini (l’età media dei caduti che fu possibile identificare venne calcolata in ventisei anni). Fu la strage più cruenta di civili mai accaduta in Italia nel tempo di pace, per cause non naturali: in quella domenica di agosto tanti Polesi si erano concessi una gita al mare in concomitanza con le gare di nuoto della Coppa Scarioni, ma andarono incontro ad un destino davvero tragico. Ventotto bombe di profondità, residuato bellico posto in prossimità della spiaggia previa opera di sicuro disinnesco, vennero fatte scoppiare proditoriamente dando luogo ad una vera e propria ecatombe. Tutti percepirono subito quale fosse stata la matrice del delitto, nell’intento di spingere all’Esodo coloro che non si erano ancora rassegnati: ebbene, dopo 60 anni, l’apertura degli archivi inglesi di Kew Gardens (Foreign Office) ha confermato che la strage fu opera dell’OZNA, la polizia politica jugoslava, ed ha affidato i nomi di cinque responsabili alla memoria ed al giudizio dei posteri.
Gli esuli si dispersero in ben 114 campi di raccolta dislocati in tutte le regioni italiane, dove si viveva in condizioni allucinanti. Alcuni di questi campi, come quelli di Laterina (Arezzo) e Marina di Carrara, sarebbero rimasti in funzione sino alla fine degli anni Sessanta, costringendo molti esuli, pur di uscire da quell’inferno, all’ulteriore dramma dell’emigrazione. L’ipotesi di concentrarli in qualche macro-aggregato idoneo a meglio salvaguardarne l’unità (si erano valutate opzioni specifiche per il Gargano e la Sardegna) venne scartata «in alto loco» per ragioni di opportunità: si temeva, senza fondamento, che le delusioni potessero essere oggetto di qualche strumentalizzazione e si ignoravano le «tradizioni di civiltà e di aderenza ai valori di comprensione solidale, autenticamente cristiani, che costituivano carattere specifico di quel popolo». L’esperienza dei campi fu traumatica e massiccia: basti pensare che alla fine del 1948 ospitavano ben 45.000 esuli giuliani e dalmati.
Dopo quello che Don Luigi Stefani, il patriota zaratino e Cappellano della Misericordia che avrebbe lasciato a Firenze, dove si era stabilito dopo aver dovuto abbandonare la Dalmazia, il segno del suo ineguagliabile volontariato, volle chiamare con una pertinente espressione di sintesi lo «sradicamento» dell’esule, molti profughi ebbero l’amarezza di accoglienze inqualificabili ricevute da una patria matrigna. A Venezia vennero oltraggiati assieme alle spoglie mortali di Nazario Sauro, l’eroe dell’Italia irredenta, portate via dall’Istria per sottrarle all’usurpatore; ad Ancona si tentò di impedire lo sbarco dei profughi in mezzo ai fischi dei portuali; a Bologna fu impedita la distribuzione di qualche genere di conforto al passaggio del loro treno diretto al grande campo spezzino della Caserma Botti; ed in Liguria si giunse a paragonarli, durante un comizio nella campagna elettorale del 1948, al fuorilegge Salvatore Giuliano che nei tristi anni del dopoguerra infestava la Sicilia con la sua banda. Fu così che almeno un quarto degli esuli, alle prese con i problemi drammatici della casa e del lavoro, decise di lasciare l’Italia, il più delle volte per destinazioni oltremare (soprattutto Stati Uniti, Canada, Sudamerica ed Australia) dove furono costretti a confrontarsi con ulteriori incomprensioni, fame e miseria, ma dove riuscirono ad affermare una straordinaria dignità ed in alcuni casi a costruire importanti fortune.
L’ultima ondata, dopo uno stillicidio che era continuato di anno in anno, sopravvenne nello scorcio conclusivo del 1954, quando il ritorno di Trieste all’amministrazione italiana coincise con la conferma di quella jugoslava nella Zona «B» ed il conseguente esodo da Capodistria e dalle altre cittadine nord-occidentali dell’Istria: Buie, Cittanova, Pirano, Portorose, Umago. Del resto, le violenze erano proseguite per anni, ben oltre la fine della guerra, persino con uccisioni di vecchi, di donne e addirittura di invalidi, ed avevano trovato una triste espressione simbolica proprio a Capodistria, dove il Vescovo Monsignor Antonio Santin venne aggredito e picchiato a sangue.
Giova aggiungere che fra i martiri triestini del 1953, definiti «gli ultimi caduti del Risorgimento» perché avevano affrontato in uno scontro drammatico la polizia del governo militare alleato con la sola arma della fede nell’Italia, i giovanissimi Piero Addobbati e Leonardo Manzi appartenevano a famiglie originarie dell’Istria e di Fiume.
Per lunghi anni, il dramma giuliano e dalmata è stato pervicacemente ignorato, perché la Jugoslavia leader dei quarantaquattro Paesi «non allineati» (tutti extra-europei ad eccezione della Repubblica Federativa) era un’interlocutrice privilegiata dell’Occidente, ma nello stesso tempo perché si presumeva che la sua esperienza politica ed economica basata sull’autogestione potesse costituire una terza via praticabile con successo mentre avrebbe condotto al disastro, e si voleva ignorare che il clima di violenza era ben lungi dall’essere estirpato. Negli anni Ottanta, quando Tito era ormai scomparso, la denunzia delle torture figurava sempre all’ordine del giorno: un intellettuale dissidente come Mirko Vidovic, pur naturalizzato francese, era stato catturato con l’inganno e condannato a diversi anni di carcere per avere scritto poesie ritenute offensive per il regime, mentre un sacerdote di Lubiana era stato messo in prigione per avere dato alle stampe un libro di preghiere. Dal canto suo, l’Italia doveva piangere una nuova vittima, il pescatore Bruno Zerbin ucciso nel 1988 per la cosiddetta «guerra del pesce» nell’Alto Adriatico, mentre un esponente di spicco della Resistenza Slava, all’epoca assai popolare, Ljubiscia Veselinovic, si suicidava in segno di protesta contro la corruttela e le degenerazioni di un sistema alla vigilia della fine.
Gli esuli, dopo decenni di delusioni, offese ed ostracismi, culminati nel Trattato di Osimo del 1975 (quando il Presidente della Repubblica Giovanni Leone volle assicurare ad una Delegazione Triestina che non lo avrebbe controfirmato mentre qualche ora prima lo aveva già sottoscritto), ma elisi almeno moralmente dalla memorabile udienza collettiva che il Santo Padre Giovanni Paolo II volle concedere un decennio più tardi, hanno potuto fruire, dopo un sessantennio, di un atto pur tardivo di giustizia grazie all’istituzione del «Giorno del Ricordo» avvenuta con la Legge 30 marzo 2004 numero 92 che fu votata quasi all’unanimità dal Parlamento Italiano (alla Camera i contrari si fermarono a quindici). Se non altro, ne è derivata una conoscenza più diffusa di ciò che accadde «quando la Venezia Giulia e l’Istria furono sacrificate alla ragione di Stato». Molto, peraltro, resta da fare: per dirne una, la Legge 15 febbraio 1989 numero 54, che fa divieto di dichiarare «nati in Jugoslavia» coloro che avevano visto la luce prima del 15 settembre 1947 nei territori già appartenenti alla sovranità italiana, è rimasta sulla carta pur avendo una valenza esclusivamente morale e non comportando impegni finanziari specifici.
Diversamente da quanto afferma una «vulgata» tuttora in essere, l’Esodo non ebbe affatto carattere volontario, al pari di quelli non meno drammatici che interessarono i Finlandesi della Carelia, i profughi baltici ed i Tedeschi di Brandeburgo, Pomerania, Slesia e Sudeti, con la differenza non marginale di essersi protratto, sia pure con diversi livelli di flusso, per oltre un decennio, quasi a significare che le violenze non ebbero soluzione di continuità ma si protrassero ben oltre i fatti bellici e ben oltre l’affievolimento del diritto positivo che la guerra regolarmente e tristemente comporta.
È appena il caso di ricordare che non hanno fondamento condividibile le teorie negazioniste e giustificazioniste sostenute, con particolare riguardo alle seconde, da significative seppure minoritarie espressioni storiografiche. Quando si ode affermare che le foibe sarebbero state l’effetto di vessazioni compiute dagli Italiani a danno degli Slavi e si sente rammentare che la Jugoslavia, a norma dell’articolo 15 del Trattato di pace, chiese all’Italia la consegna di ben 447 criminali di guerra, non si può fare a meno di notare che l’Unione Sovietica ne chiese dodici, l’Etiopia dieci, la Grecia sei e l’Albania tre. Allora, delle due l’una: o il comportamento degli Italiani fu largamente discriminatorio in senso peggiorativo proprio nei confronti della Jugoslavia, cosa oggettivamente incomprensibile, o le accuse di Belgrado ebbero carattere strumentale. Del resto, non furono poche le vittime che operavano nelle file della Resistenza: a parte l’episodio ben noto di Porzus e la strage degli Osovani che vi fu consumata, diversi esponenti significativi della Sinistra Istriana e Giuliana come Pino Budicin o Lelio Zustovich pagarono con la vita la contrarietà all’annessione della propria terra da parte jugoslava.
In realtà, il progetto di Tito, pur salvaguardando una matrice collettivista, non fu alieno da ricorrenti suggestioni nazionali, assai diffuse a livello popolare quanto lontane dall’ortodossia marxista, tanto da incorrere già dal 1948 nella scomunica del Cominform. Avvicinando la Jugoslavia all’Occidente, questo fu un ulteriore ostacolo, certamente non marginale, al perseguimento delle attese giuliane, istriane e dalmate ed in primo luogo a quelle di natura morale come l’ammissione del trattamento inumano riservato agli Italiani, al pari di quanto avrebbe fatto il Cancelliere Tedesco Willy Brandt davanti al monumento dell’Olocausto. Lo stesso dicasi per la tutela delle tombe dislocate nei 300 cimiteri dei territori perduti: un’attesa prioritaria che coinvolge da sempre tutto il mondo dell’Esodo e non solo quello interessato alla pur legittima richiesta di indennizzo o restituzione dei beni.
L’equivoco secondo cui i profughi venivano considerati «fascisti della peggiore specie» è stato duro a morire perché si ignoravano le reali motivazioni dell’Esodo e si voleva credere che costoro, lasciando la Jugoslavia, avessero abbandonato un eldorado. Non a caso, quasi 2.000 illusi, i cosiddetti «Monfalconesi», fecero il percorso inverso, per lo più spontaneamente, emigrando nella Repubblica Federativa per lavorare nei cantieri e nelle fabbriche di Tito, soprattutto a Fiume, ma facendo una brutta fine dopo la svolta del 1948 quando pagarono duramente la fedeltà allo stalinismo, rinchiusi nei campi di prigionia e di «rieducazione» come quello davvero agghiacciante dell’Isola Calva e riuscendo a rientrare in Italia, nella migliore delle ipotesi, dopo anni di sofferenze e di stenti. Gli esuli, in realtà, erano Italiani tutti d’un pezzo che avevano dovuto coniugare sentimento e necessità per non cedere a violenze indiscriminate compiute, non è male ribadirlo, anche nei confronti degli Jugoslavi dissidenti, a loro volta emigrati in massa per mettersi in salvo.
Conviene ricordare che buona parte di costoro, al pari delle vittime infoibate od altrimenti assassinate, era nullatenente: accanto ad alcuni proprietari terrieri, esponenti del mondo economico, pubblici funzionari ed insegnanti, un’ampia maggioranza era costituita da medici, infermieri, impiegati, operai, agricoltori, ferrovieri, pescatori, studenti, pensionati e casalinghe. Basti dire che trovarono atroce morte nelle foibe, fra gli altri, i bidelli, le collaboratrici domestiche, i venditori ambulanti e persino gli spazzacamini: ulteriore dimostrazione, se per caso ve ne fosse bisogno, del disegno di pulizia etnica perseguito a carico di tutti coloro che non intendevano riconoscersi nel nuovo corso, a prescindere dall’appartenenza a questa o quella classe. Vennero infoibati persino alcuni contadini, incolpati di avere venduto ai carabinieri i prodotti della terra.
Per completare il panorama, è congruo aggiungere che i profughi non sono stati mai risarciti, nemmeno sul piano simbolico. Al di là del «Giorno del Ricordo» sono tuttora in essere incomprensioni e falsità che avrebbero potuto essere elise con un minimo di buona volontà: a parte la citata questione anagrafica, si pensi agli errori che si trovano in alcuni testi scolastici come quelli secondo cui nel 1947 la Venezia Giulia sarebbe stata «restituita» alla Jugoslavia senza che questo Paese, oltre tutto inesistente fino al 1919, l’avesse mai posseduta. Considerazioni analoghe valgono per la tutela delle tombe e dei monumenti italiani in Croazia e Slovenia: con le sparute disponibilità finanziarie finora concesse, i soli interventi di manutenzione ordinaria si potrebbero completare dopo oltre un secolo! Nel frattempo, i sepolcri espunti dai vecchi cimiteri in aderenza ad una legislazione miope, priva di quella «pietas» che ha caratterizzato tanti contesti civili anche in costanza di trasferimenti della sovranità, sono sempre all’ordine del giorno.
Non meno amara è la sorte dei beni nazionalizzati dal regime, che sono stati oggetto di indennizzi minimi da parte dell’Italia, assai lontani da quei valori «equi e definitivi» garantiti a più riprese da governi di varia estrazione politica ma rimasti regolarmente nel mondo delle idee: eppure, detti beni avevano «costituito una quota determinante dei pagamenti effettuati in conto danni di guerra corrisposti alla Jugoslavia». In altri termini, se l’Esodo istriano e giuliano si è concluso fisicamente da almeno mezzo secolo, i suoi effetti sono sempre vivi nella memoria e nella sensibilità dei profughi e dei loro eredi, che, pur consapevoli dell’importanza morale assunta dalla legge del 2004, si chiedono fino a quando dovrà continuare questa sorta di esilio civile, giuridico, umano: in una parola, etico-politico.
Il «Giorno del Ricordo» – per parecchi aspetti – costituisce un atto dovuto: ad esempio, per quanto concerne la concessione dei riconoscimenti (senza assegni) agli eredi delle vittime, prevista nei primi dieci anni di vigenza della legge istitutiva e quindi fino al 2014. È un attestato ufficiale, sia pure tardivo, delle sofferenze che i profughi hanno dovuto sopportare per compiere una scelta di civiltà e per rimanere fedeli alla Patria.
Invece, per il vasto mondo dell’Esodo, ed alla luce della Legge numero 92 per lo stesso legislatore italiano, non esistono termini di alcun genere posti all’obbligo di trasmettere, senza riserve dubitative od avversative che non possono avere diritto di cittadinanza, la memoria di tante vicende individuali e collettive appartenenti ad una grande tragedia umana.
Ciò, con l’intento di esorcizzarli per sempre e prevenirne iterazioni solo apparentemente improbabili: la storia è suffragata da documenti inoppugnabili, ma la realtà contemporanea dimostra che nel mondo continuano ad esistere tante sacche di violenza e di ripudio delle «alte non scritte ed inconcusse leggi» che trascendono il diritto positivo e vivono nel cuore dell’uomo.
È un ottimo motivo in più per concludere con un messaggio di fede nella giustizia e prima ancora, di permanente speranza nella maturazione delle coscienze.