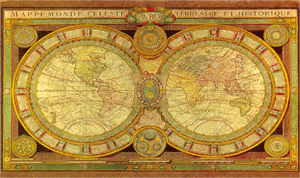Esodo giuliano-dalmata: foibe e diktat
Un dramma incancellabile del secolo breve
(1943-1947)
Riflessioni e auspici dopo tre quarti di secolo
Riflessioni e auspici dopo tre quarti di secolo
Con la Legge 30 marzo 2004 numero 92, approvata dal Parlamento Italiano quasi all’unanimità, il 10 Febbraio di ogni anno è stato consacrato al ricordo della grande tragedia collettiva giuliana e dalmata, tra le maggiori del secolo scorso. Non è un caso che la scelta sia caduta sull’anniversario del trattato di pace di Parigi firmato nel 1947, con cui si chiuse formalmente la Seconda Guerra Mondiale e con cui l’Italia perse la Dalmazia, buona parte della Venezia Giulia e quasi tutta l’Istria, trasferite alla Jugoslavia[1]. Le amputazioni territoriali, prescindendo dalle colonie e dalle cessioni in agro di Briga e Tenda a favore della Francia, interessarono esclusivamente il confine orientale, traducendosi nel passaggio di sovranità sul 3% del territorio metropolitano.
Eppure, la Jugoslavia del Maresciallo Tito, diversamente da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica, aveva «vinto» la guerra per modo di dire. Intanto, Belgrado era stata alleata dell’Asse sin dal patto d’amicizia del 1937 e fino al marzo 1941, quando cambiò campo a seguito del colpo di Stato militare che costrinse la Germania, l’Italia e i loro alleati bulgari e ungheresi a intervenire militarmente, 18 mesi dopo l’inizio del conflitto mondiale. Poi, va aggiunto che Tito, leader dei partigiani rossi (all’origine in posizione minoritaria), era riuscito a farsi riconoscere quale unica espressione della Jugoslavia soltanto verso la fine del 1944, quando Londra e Washington, per compiacere Mosca, gli sacrificarono il Governo Monarchico in esilio e le altre formazioni anticomuniste, a cominciare da quelle cetniche di Draza Mihajlovic, sebbene si fossero battute valorosamente contro le forze occupanti.
Tito perseguiva un disegno unitario che aveva uno dei maggiori punti di forza nella pulizia etnica della Dalmazia e dell’Istria a danno degli Italiani[2] e nella pulizia politica a danno di tutte le opposizioni, comprese quelle antifasciste. Del resto, aveva predisposto tutte le mosse con notevole oculatezza: a esempio, imponendo all’aeronautica anglo-americana bombardamenti indiscriminati privi di rilievo militare, vale a dire a carattere terroristico (sulla sola Zara se ne sarebbero contati 54) e facendo rinviare a tempo indeterminato lo sbarco in Istria che gli Alleati avevano già ipotizzato – ciò, in modo da non trovare interferenze nella conquista delle maggiori città costiere e soprattutto nella cosiddetta «corsa su Trieste», dove l’Armata Rossa giunse il 1° maggio 1945, con poche ore di vantaggio sulle forze neozelandesi che costituivano la prima avanguardia alleata. In proposito, non è un mistero che quest’ultima, per verosimili direttive superiori, avesse rallentato la marcia di avvicinamento a Trieste consentendo alle formazioni partigiane di arrivare per prime al traguardo, e di assicurarsi il vantaggio del fatto compiuto.
Forte della protezione determinante di Stalin che si sarebbe incrinata soltanto nel 1948, Tito seppe volgere a proprio vantaggio le divisioni emerse tra Potenze vincitrici durante la Conferenza della pace tenutasi a Parigi, con particolare riguardo all’atteggiamento punitivo assunto nei confronti dell’Italia (diversamente da qualche possibilismo degli Stati Uniti) da parte della Gran Bretagna e soprattutto della Francia che non aveva perdonato la dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940 ai danni di un Paese già sconfitto dalla guerra «lampo» tedesca: infatti, l’armistizio sarebbe stato definito nel giro di due settimane.
Per questi motivi, il trattato di pace assunse il carattere di un vero e proprio «diktat», come venne chiamato da allora in poi: fu perduta anche Pola, che si era confidato di poter salvare in quanto occupata militarmente dagli Alleati al pari di Trieste; venne deciso di costituire uno Stato cuscinetto, il Territorio Libero della medesima Trieste (TLT) che peraltro rimase una realtà di fatto divisa in due zone separate, non essendo stato possibile concordare almeno la nomina di un Governatore; fu statuito l’obbligo italiano di corrispondere pesanti riparazioni di guerra, assieme a quello di smilitarizzare un’ampia fascia territoriale nelle zone di confine; e venne chiesta la restituzione di oltre 700 presunti criminali di guerra, che peraltro non ebbe luogo per manifesta incongruenza delle pretese titoiste (la predetta cifra fu superiore a quella delle analoghe richieste presentate dal coacervo degli altri 20 Stati vincitori: fatto oggettivamente eloquente).
Diversamente da quanto sarebbe accaduto in altri Stati dell’Asse, il «diktat» venne prontamente ratificato dall’Assemblea Costituente uscita dalle elezioni del 2 giugno 1946 contestualmente al referendum istituzionale che aveva visto prevalere la Repubblica; ma va ricordato che in quella consultazione fu precluso il diritto di voto agli Istriani, Giuliani e Dalmati che risiedevano ancora nella propria terra, senza dire di quello agli 800.000 prigionieri di guerra che al momento non erano ancora rientrati (molti sarebbero scomparsi nei lager dei vincitori). Oltre 60 Costituenti votarono contro: tra gli altri, Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando, il Presidente della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale, che posero in evidenza con nobili parole la «cupidigia di servilismo» di cui l’Italia stava dando dimostrazione in quella triste circostanza.
Al trattato di pace si era giunti con effetti tanto più iniqui, se si pensa alle sorti del popolo giuliano, istriano e dalmata che finì per pagare – anche in termini di vite umane – la sconfitta militare dell’Italia in misura di gran lunga superiore a quella, pur pesante, delle altre Regioni. Sin dall’8 settembre 1943, la dissoluzione dell’esercito italiano a seguito dell’armistizio con gli Alleati aveva posto Venezia Giulia e Dalmazia alla mercé delle bande partigiane che per oltre un mese si abbandonarono a ogni sorta di violenze, in cui la morte in foiba ebbe un triste primato, con l’aggiunta degli annegamenti, in specie a Zara e nelle città costiere, delle fucilazioni e persino di lapidazioni e decapitazioni. Sono di questo periodo il martirio di Norma Cossetto, la giovane studentessa italiana di Santa Domenica di Visinada che preferì la morte (5 ottobre) al tradimento e al disonore, assurgendo a simbolo della grande tragedia istriana; e l’uccisione di tante persone di tutte le classi, esenti da qualsiasi colpa. Caddero anche moltissimi religiosi «in odium fidei»: fra i tanti, Don Francesco Bonifacio, il parroco di Villa Gardossi recentemente beatificato.
A proposito di Norma Cossetto, si deve ricordare che nel 1949 venne insignita della laurea «honoris causa» dall’Università di Padova, dove avrebbe dovuto discutere la tesi proprio nell’epoca del suo martirio, e che nel 2006 le fu conferita dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia d’Oro al Valor Civile per l’eroico comportamento tenuto davanti ai suoi aguzzini. Anche per questo, è diventata il simbolo del martirio di un intero popolo, e a più forte ragione, di tutte le donne che caddero a opera dei partigiani, spesso dopo sevizie e violenze di ogni genere, e che secondo le stime più attendibili, suffragate da elenchi dettagliati delle Vittime, non furono meno di 700[3].
Dopo la riconquista tedesca avvenuta nell’ottobre 1943, che permise il recupero pur difficoltoso di alcune centinaia di Vittime (le foibe sono voragini profonde e di accessibilità assai ardua) e diede vita all’effimera esperienza del Litorale Adriatico[4], alla fine della guerra e nei lunghi mesi successivi il disegno di pulizia etnica o genocidio che dir si voglia, divenne sistematico, a opera delle milizie jugoslave – con squallido contorno di collaboratori italiani – che si erano impadronite di tutto il territorio, comprese le città di Trieste, Gorizia e Pola, da dove si sarebbero allontanate nel giugno 1945 (ma non dal resto dell’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia) dopo 40 terribili giorni di occupazione: ciò, a seguito degli accordi di compromesso fra gli Alleati e Tito, siglati a Belgrado dal Generale Harold Alexander e dal Maresciallo medesimo. Scomparvero migliaia di persone, gran parte delle quali non fecero più ritorno: secondo testimonianze autorevoli e certamente prudenziali come quella di Luigi Papo[5], le Vittime non furono meno di 16.500.
Furono oltre 50 le foibe che vennero utilizzate per l’assassinio di massa, in gran parte rimaste in territorio jugoslavo e quindi senza alcuna possibilità di prospezioni[6]. La più importante in territorio italiano, e oggi Monumento Nazionale, è quella di Basovizza, nei pressi di Trieste: in realtà si tratta del pozzo di una vecchia miniera abbandonata, già adibita a discarica e profonda oltre 250 metri, dove venne tentato qualche recupero senza successo da parte del Governo Militare Alleato e dove fu calcolato che siano state sacrificate circa 2.000 Vittime. La morte in foiba, non sempre immediata, era fra le più terribili che si possano immaginare: talvolta si udivano per giorni grida disperate provenienti dalle voragini, e in qualche caso gli assassini, a titolo di suprema offesa, scagliavano nell’abisso un cane nero, che coi suoi latrati avrebbe dovuto negare la pace alle anime dei Defunti.
Nelle foibe non c’è stata salvezza, con la sola eccezione documentata di un esule recentemente scomparso, Graziano Udovisi, la cui caduta era stata bloccata dagli arbusti e dal fondo umido, con possibilità di risalire fino all’imbocco dopo un’attesa lunga e terrificante, resa più drammatica dalle ferite[7]. Quanto agli altri, non furono molti coloro che riuscirono a tornare dai campi di prigionia e di «rieducazione» del regime di Tito, talvolta dopo anni di angherie d’ogni genere, come quelle patite nel luogo di pena più noto e allucinante, l’Isola Calva, dove furono perseguitati, fra gli altri, alcuni dei cosiddetti «monfalconesi»: 2.000 comunisti italiani che erano emigrati in Jugoslavia nella fallace illusione di trovarvi il paradiso marxista, tanto più amara dopo la rottura fra il revisionismo di Belgrado e l’ortodossia di Mosca.
Nella moltitudine delle Vittime non mancarono coloro che si erano battuti a fianco dell’Armata Popolare ma non volevano l’annessione di terre italiane alla Repubblica Federativa – pur essendo di fede comunista – e che scomparvero al pari degli altri Italiani: basti pensare alla strage di Porzus, perpetrata da partigiani «rossi» a danno di quelli «bianchi», dove scomparve il fratello di Pier Paolo Pasolini, o a personaggi come Pino Budicin e Lelio Zustovich.
Non fu trascurato alcun mezzo per promuovere la pulizia etnica, come avrebbero dichiarato a cose fatte i massimi luogotenenti di Tito quali Milovan Gilas o Edvard Kardelj. In questa strategia rientrano le vessazioni e le torture: a Pola un ruolo di primo piano fu svolto dalla strage di Vergarolla del 18 agosto 1946 in cui persero la vita, a 16 mesi dalla fine della guerra, oltre 100 italiani, tra cui molti bambini (l’età media delle Vittime è stata calcolata in 26 anni) che erano convenuti sulla spiaggia per una giornata di vacanza, arricchita da contestuali gare natatorie[8]. Ne fu causa lo scoppio di 28 mine di profondità abbandonate sul posto e dichiarate innocue, ma fatte esplodere proditoriamente da agenti dell’OZNA, la polizia segreta jugoslava, come è stato confermato in tempi recenti dopo l’apertura degli archivi inglesi di Kew Gardens, a 60 anni dai fatti. Foibe ed eccidi costituivano un avvertimento ben preciso e un incentivo determinante all’esodo: non a caso, dopo Vergarolla, acquisita la certezza che anche Pola sarebbe stata sacrificata, il 92% della cittadinanza scelse la via dell’esilio. Incidenze non dissimili si registrarono a Fiume, a Zara e nelle altre maggiori città istriane.
In base alle testimonianze più documentate, fra cui quella di Padre Flaminio Rocchi, i profughi furono 350.000, un quarto dei quali scelse di trasferirsi all’estero, per lo più in Paesi lontani come le Americhe o l’Australia. In effetti, l’accoglienza della madre patria, catafratta dal disastro bellico e dalle difficoltà della ricostruzione, non fu delle migliori: chi non aveva altre opportunità personali trovò precario rifugio in ben 114 campi di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale. Non tanto per difficoltà logistiche quanto per l’intento di impedire la formazione di ampie comunità consapevoli dei propri diritti e capaci di proteste ritenute pregiudizievoli per il nuovo ordine istituzionale, si era ritenuta nettamente sconsigliabile la creazione di aggregati sociali capaci di conservare l’identità originaria: in tale ottica, decaddero le proposte «ad hoc» che erano state ipotizzate per il Gargano in agro di Vieste o per la Sardegna Nord-Occidentale in quello di Fertilia, dove si erano già insediati i pescatori esuli da Curzola. Alcuni di quei campi, dove la promiscuità e la mancanza dei servizi essenziali erano prassi ricorrente, rimasero aperti fino alla vigilia degli anni Settanta.
I primi tempi furono particolarmente duri: parecchi Italiani, in specie di sinistra, non intendevano comprendere le ragioni dei Giuliani, Istriani e Dalmati. Sono noti gli episodi dei vari treni di profughi che non vennero fatti fermare alla stazione di Bologna per rifocillare i bambini, perché non doveva essere concesso alcun aiuto ai «banditi fascisti», come vennero definiti nella campagna elettorale del 1948 da parte di qualche candidato comunista[9]. Ciò, senza dire dei fischi ricevuti allo sbarco dei profughi polesi nel porto di Ancona o in quello di Venezia, al termine dei tanti viaggi allucinanti compiuti dal piroscafo Toscana, l’ultimo dei quali con le spoglie mortali di Nazario Sauro, che non si erano volute lasciare alla mercé dell’usurpatore.
A proposito di questi viaggi è d’uopo aggiungere una postilla importante, come da testimonianza di Lino Vivoda che in anni successivi fu Sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio: una strage ancor più grave di quella di Vergarolla venne provvidenzialmente sventata prima della partenza quando una bomba ad alto potenziale fu scoperta a bordo della nave, pronta per deflagrare durante la traversata dell’Adriatico, con quali terribili effetti è facile immaginare. Nel caso di specie, i responsabili non vennero individuati ma la «vox populi» lasciò pochi spazi al dubbio.
Diversamente da altri grandi esodi degli anni Quaranta come quelli dalla Germania Orientale o dalla Finlandia che si erano concentrati in un periodo di tempo relativamente ristretto, le partenze da Venezia Giulia, Istria e Dalmazia furono più diluite: i primi Zaratini abbandonarono la propria città fra il 1943 e il 1944, mentre il comprensorio Nord-Occidentale dell’Istria con le città di Buie, Capodistria, Cittanova, Isola, Pirano, Portorose e Umago avrebbe conosciuto la punta maggiore dell’esodo soltanto nel 1954, quando fu chiara, nell’ambito delle intese per il ritorno di Trieste all’amministrazione italiana, la statuizione di quella jugoslava sulla Zona «B» seguita da ulteriori correzioni della linea di demarcazione a sfavore dell’Italia, con la cessione degli abitati di Albaro Vescovà e di Crevatini. In effetti, l’ultima significativa «ondata» di profughi ebbe luogo nel momento in cui si ebbe la certezza che per quel distretto non c’erano più speranze, quantunque labili come quelle cullate fino al medesimo 1954. Parecchio tempo dopo, ne sarebbe sopraggiunta un’ulteriore conferma formale con il surreale trattato di Osimo del 1975, quando sopravvenne il riconoscimento ufficiale della sovranità jugoslava sulla ex Zona «B» in luogo dell’amministrazione civile. Ma questa è un’altra storia.
In precedenza, non pochi Istriani e Fiumani avevano atteso l’aprile del 1948 prima di prendere la via dell’esilio: si temeva che le elezioni politiche italiane potessero portare alla vittoria del Fronte Popolare e si paventava di trovare anche in Italia condizioni analoghe a quelle jugoslave. Altri, infine, dovettero confrontarsi per anni con gli ostacoli frapposti dal regime di Tito che non voleva lasciar partire chi poteva essere utile a fini produttivi, senza contare alcuni casi di tristi discrasie occorse in famiglie miste come quello ben descritto dal film d’epoca La Città dolente (dedicato a Pola) nella cui sceneggiatura si distinse un giovane Federico Fellini.
Tratto comune a tutti gli esodi furono l’abbandono forzato delle case, dei beni mobili, e quello particolarmente triste delle tombe di famiglia che in molti casi, in deroga all’antica «pietas», non sarebbero state rispettate dal nuovo regime, pronto a espungerle per fare posto a quelle dei nuovi arrivati. Si tratta di un capitolo particolarmente doloroso oltre che iniquo, perché il Governo Italiano ha pagato buona parte dei debiti di guerra alla Jugoslavia con i beni degli esuli, senza avere mai provveduto a indennizzi o risarcimenti se non in misura assolutamente minima, tanto che diversi aventi causa li rifiutarono con motivato sdegno. Del resto, l’Italia è stata matrigna anche per altre legittime attese degli esuli in materia anagrafica e previdenziale, per non dire del lungo silenzio sulla tragedia delle Foibe e dell’Esodo che è durato per oltre 60 anni anche nei testi scolastici, e che nonostante il Giorno del Ricordo[10] per molti aspetti dura tuttora.
Nondimeno, maggiori sensibilità informative vanno diffondendosi sul territorio: nel nuovo millennio, oltre 700 città italiane hanno intitolato un luogo pubblico ai Caduti e Martiri delle Foibe ponendo le prime basi di una conoscenza più diffusa, mentre la storiografia, pur fra tante resipiscenze e non pochi «distinguo», ha prodotto un numero notevole di ricerche, documentazioni e memorie. Sono motivi di speranza in mezzo al dolore degli esuli e di gratitudine in mezzo all’indifferenza altrui: sentimenti tanto più forti perché la storia non finisce oggi né domani. In primo luogo, quella giuliana, istriana e dalmata, che parla soprattutto di Roma e di Venezia, ma prima ancora, del troppo sangue versato: non inutilmente, in quanto «le idee non si strozzano / ed anzi dal patibolo risorgono terribilmente feconde»[11].
Il legislatore italiano ha ufficializzato la consuetudine di destinare un giorno di ogni anno (il 10 Febbraio) alla comune riflessione sul grande esodo giuliano, fiumano e dalmata, sulla tragedia delle foibe e degli altri massacri indiscriminati, e sulle «complesse vicende del confine orientale». Le prime due questioni, in quanto suffragate da cifre su cui si continua a discutere ma in ogni caso di ampiezza elevata e di grande effetto mediatico, appartengono a una sensibilità ormai diffusa, sebbene tuttora approssimativa, mentre la terza ha finito per rimanere in penombra, sia per la maggiore disponibilità a commemorare il dramma storico delle Vittime, tradottosi in un vero e proprio genocidio, sia per le difficoltà di approfondire questioni dichiaratamente «complesse» in un’ottica oggettiva, lungi dall’ostracismo che nel sessantennio precedente aveva contraddistinto l’atteggiamento politico largamente maggioritario e buona parte della stessa storiografia.
Eppure, quelle vicende avrebbero potuto e dovuto spiegare con adeguata chiarezza il fatto (esodo e foibe) alla luce delle matrici che avevano dato origine a quella tragedia epocale e al corollario giuridico del trattato di pace, o meglio del «diktat» imposto all’Italia il 10 febbraio 1947. Non è stato così, dal momento che i precedenti paralogismi si sono ripetuti, talvolta in termini peggiorativi, attraverso la «vulgata» secondo cui l’esodo dei 350.000 e l’olocausto delle 20.000 Vittime infoibate o diversamente massacrate sarebbero stati la «giusta reazione» alle persecuzioni praticate nel Ventennio fascista a danno delle popolazioni slave, e segnatamente di quelle croate e slovene. In effetti, l’assimilazione era stata dura, in aderenza al «Volksgeist» dell’epoca, con aspetti significativi nell’anagrafe, nella toponomastica, nell’informazione e nella scuola, ma in termini assolutamente incomparabili col delitto contro l’umanità che fu compiuto a danno degli Italiani (e degli Slavi dissidenti) fra il 1943 e il 1947: c’erano state, intorno all’inizio degli anni Trenta, le condanne capitali a carico di Vladimir Gortan e dei «Quattro di Basovizza» ma si era trattato dei responsabili dichiarati di atti terroristici e giudicati come tali in un contesto caratterizzato – non soltanto in Italia – dalla frequente pronuncia di verdetti analoghi.
Necessariamente diverso fu il comportamento della giustizia militare italiana negli anni del conflitto con la Jugoslavia (1941-1943) ma anche a questo proposito giova rammentare che le commutazioni delle pene capitali furono maggioritarie, mentre nell’ultimo biennio (1943-1945) le forze dell’Asse furono costrette – loro malgrado – ad applicare il diritto di guerra, con utilizzo spesso indiscriminato della rappresaglia, nei confronti di chi, come i partigiani di Tito, «non prendeva prigionieri» e si produceva in un campionario di nefandezze e di torture ampiamente documentate[12]. In effetti, lo scorcio finale del conflitto si distinse per l’affievolimento, se non anche per la negazione di ogni norma e consuetudine, assumendo i sinistri contorni della guerra civile, tanto più che i partigiani medesimi non portavano divise ufficiali e non riconoscevano convenzioni.
Le violazioni dei diritti umani da parte jugoslava, a cominciare da quello fondamentale che con tutta evidenza è il diritto alla vita, sono state oggetto di rapporti ineccepibili anche a livello istituzionale, tra cui quello predisposto dal Governo Italiano nel 1946 in vista delle trattative di pace in procinto di aprirsi a Parigi, anche se non venne prodotto ufficialmente vista la preclusione aprioristica delle Potenze vincitrici e dei loro Alleati, ma pur sempre impressionante sia alla stregua dei documenti, sia alla luce di allucinanti allegati fotografici[13]. Considerazioni analoghe si possono fare per gli altri diritti prioritari negati, come quelli di culto, d’intrapresa e di proprietà, sacrificati al collettivismo forzato, e motivazioni non ultime dell’esodo in aggiunta al terrore della morte in foiba o nelle acque dell’Adriatico.
La sperequazione chiaramente ravvisabile, da una parte la durezza italiana del Ventennio bilanciata ampiamente da un progresso socio-economico senza precedenti e inquadrata in un contesto di «Realpolitik» ampiamente diffusa nell’agone internazionale del «secolo breve», e sull’altro fronte le persecuzioni jugoslave protrattesi per lungo termine ben oltre la fine della Seconda Guerra Mondiale, induce considerazioni oggettive circa l’insussistenza di motivazioni a favore dell’ostracismo alla piena operatività della Legge 92, tuttora in atto. D’altro canto, bisogna pur dire che la normativa in parola è sfornita di sanzioni per il caso di inosservanza, trattandosi di un provvedimento ad alto contenuto etico-politico, condiviso dalle forze politiche quasi all’unanimità, in guisa da escludere, al momento dell’approvazione, ogni ragionevole ipotesi fondatamente contraria.
Il Parlamento della Repubblica aveva peccato di soverchio ottimismo nella presunzione tutto sommato idealistica che le vecchie pregiudiziali fossero state superate, sia da parte del nazional-comunismo jugoslavo, sia da parte dei suoi estimatori italiani, anche perché – quasi contestualmente – si andava diffondendo la nuova «vulgata» secondo cui il fascismo avrebbe dato vita al «male assoluto». In realtà, ormai da tempo la critica storica più attenta non aveva mancato di mettere a fuoco le contraddizioni del sistema comunista, compreso quello jugoslavo (a onta delle discrasie in buona parte strumentali fra Tito e Stalin) per non dire della sua «marcia verso il nulla» se non altro per le violenze aggiuntive e gratuite anche nei confronti di donne, di bambini e persino di invalidi, e per una sostanziale alimentazione della cultura dell’odio, tipica espressione di un potere in totale antitesi ai valori umani della convivenza civile, se non anche demoniaco, come in talune interpretazioni della scienza politica moderna[14].
Conviene soggiungere che siffatto volto del potere non poteva ragionevolmente sorprendere quando esprimeva la vera essenza delle cosiddette democrazie popolari a cui la Repubblica Federativa Jugoslava non cessò mai di appartenere nemmeno dopo la morte di Tito, sino allo sfascio definitivo e alla costituzione dei nuovi Stati indipendenti.
Nondimeno, quel volto non fu alieno dal manifestarsi sia pure in misura più «soft» anche altrove, e più specificamente nei comportamenti delle Potenze Occidentali vincitrici della guerra assieme all’Unione Sovietica: ciò, con particolare riguardo proprio al «diktat» imposto all’Italia con clausole iugulatorie su cui sono stati versati fiumi d’inchiostro[15] ma che non impedirono, sia pure con una sessantina di voti contrari, la rapida ratifica da parte dell’Assemblea Costituente, quale esito di un’ulteriore sostanziale imposizione. Infatti, delle ricorrenti attese italiane e giuliane, se non altro per la conservazione di Pola e della fascia occidentale dell’Istria, si era fatto strame: come era stato anticipato due secoli prima da un fine pensatore illuminista quale Samuel Johnson, «gli eccessi di speranza si espiano col dolore, e le aspettazioni a cui si indulge inopportunamente finiscono con la delusione»[16]. Ecco una sacrosanta verità su cui riflettere, nell’ottica di un Ricordo che non sia semplice reminiscenza rituale, ma spunto di un nuovo impegno attivo, concreto e consapevole.
1 Il trattato di pace divenne esecutivo alla mezzanotte del 15 settembre 1947, quando il trasferimento di sovranità entrò ufficialmente in vigore con la partenza degli ultimi funzionari addetti all’amministrazione italiana: a Pola, il passaggio venne tristemente simboleggiato, con ulteriore spregio alla storia, nella consegna delle chiavi cittadine dalle mani del colonnello Alfred Bowman a quelle di Ivan Motika. Quest’ultimo sarebbe salito agli onori delle cronache giudiziarie quale imputato nel celebre processo contro gli infoibatori, chiuso per una surreale dichiarazione di non luogo a procedere motivata da inesistente incompetenza della Corte a giudicare reati antecedenti la data del trattato.
2 Quello commesso da Tito e dai suoi collaboratori nei confronti degli Italiani fu un vero e proprio genocidio, attestato dalle 20.000 Vittime infoibate o altrimenti massacrate e dai 350.000 Esuli. Per tale interpretazione, si fa riferimento alle interpretazioni e alle conclusioni del giurista polacco Raphael Lemkin, recepite nell’opera di Italo Gabrielli, Istria Fiume Dalmazia: Diritti negati – Genocidio programmato, Luglio Editore, Trieste 2018, 168 pagine.
3 Sull’argomento, un contributo importante è stato portato da Giuseppina Mellace, Una grande tragedia dimenticata: la vera storia delle foibe, Newton Compton Editori, Roma 2015, 338 pagine, con particolare riguardo al capitolo X (Le Vittime mute: le donne infoibate, pagine 97-109) e all’Appendice (Quadro riassuntivo delle donne cadute per mano degli Slavi nella regione giuliana con elenco nominativo di quelle identificate, pagine 239-261).
4 Il Litorale (Adriatisches Kustenland) comprendeva l’intera Venezia Giulia e la provincia di Belluno, affidate a un Governatore di espressione tedesca nella persona di Friedrich Rainer: ne conseguì un sostanziale affievolimento della sovranità italiana, ma non la sua cessazione, come si è sostenuto erroneamente da diverse fonti: in effetti, l’amministrazione civile (a differenza del governo militare) rimase italiana, con tanto di Prefetti e altre Autorità locali in ciascuna provincia. Del resto, nell’ultima difesa del confine orientale (aprile 1945) anche dopo la ritirata tedesca, si distinsero i Bersaglieri e i reparti della Decima, quasi a sottolineare la continuità dell’impegno italiano e della sovranità espressa all’insegna della Bandiera tricolore, fino all’estremo sacrificio.
5 Fra le tante opere di Luigi Papo dedicate alla tragedia giuliano-dalmata si veda, anche per un esaustivo elenco nominativo delle Vittime, il celebre Albo d’Oro, Unione degli Istriani, seconda edizione, Trieste 1989, 760 pagine; e per una prima sintesi informativa, Gli ultimi tremila anni dell’Istria, Unione degli Istriani, Trieste 2003, 64 pagine. Un contributo storico a carattere più sistematico è quello dello stesso Luigi Papo, L’Istria e le sue foibe: storia e tragedia senza la parola fine, volume I, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 1999, 270 pagine; L’Istria tradita, volume II, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 1999, 304 pagine. Per cifre di dettaglio anche in relazione alle varie provenienze e destinazioni un’ulteriore fonte esaustiva è quella di Padre Flaminio Rocchi, L’Esodo dei 350.000 Giuliani Fiumani e Dalmati, Difesa Adriatica, quarta edizione, Roma 1998, 718 pagine.
6 Un’eccezione significativa, anche per il rapporto che venne predisposto e pubblicato a seguito delle prospezioni, è quella descritta in: Mario Maffi, Un Alpino alla scoperta delle foibe, Edizioni Gaspari, Udine 2013, 128 pagine. Negli anni Cinquanta, l’Autore riuscì a scendere clandestinamente anche in alcune foibe situate in territorio jugoslavo, traendone impressioni spesso agghiaccianti, come quelle riguardanti uno scheletro appoggiato alla parete in angosciosa attesa della morte liberatrice, e ossa verosimilmente infantili. Va da sé che nella fattispecie non fu possibile procedere a recuperi: al riguardo, si ricorda che quelli attuati in dimensioni importanti (comunque largamente minoritarie) si ebbero solo dopo la «prima ondata» dell’autunno 1943 a opera dei Vigili del Fuoco di Pola e di Trieste, grazie al ripristino momentaneo della sovranità italiana. Di rilevanza prioritaria furono le esumazioni compiute in Istria dalla squadra del Maresciallo Arnaldo Harzarich con ripetuto rischio della vita, sia per le difficoltà tecniche delle discese in foiba, sia per la reiterata minaccia partigiana, indotta dalla conseguente documentazione, parziale ma ormai inoppugnabile, di quei delitti contro l’umanità (per maggiori ragguagli, confronta Guido Rumici, Infoibati (1943-1945): I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Editore Mursia, Milano 2002, 498 pagine.
7 Graziano Udovisi riuscì a salvarsi perché era stato gettato in una foiba molto bassa – diversamente da gran parte delle altre – situata in agro di Fianona, e con pareti atte a una pur ardua risalita. Il «miracolo» coinvolse anche un compagno di sventura, Giovanni Radeticchio, che non ha lasciato testimonianza del fatto: dopo la rocambolesca salvezza sarebbe stato coinvolto nella diaspora dell’esodo e nel caso specifico, della successiva emigrazione.
8 Sulla strage di Vergarolla esiste una bibliografia esaustiva, arricchita da parecchie testimonianze dirette e apporti giornalistici. Qui basti ricordare, fra le tante fonti, quella certamente più ampia e dotata di adeguata documentazione: Paolo Radivo, La strage di Vergarolla (18 agosto 1946) secondo i giornali giuliani dell’epoca e le acquisizioni successive, Libero Comune di Pola in Esilio, Trieste 2015, 648 pagine. Conviene aggiungere che l’elenco nominativo delle Vittime, a maggiore informazione pubblica, è riportato anche nella stele «ad memoriam» eretta nella Zona Sacra di San Giusto, presso la Cattedrale triestina, a iniziativa della Federazione Grigioverde e della Famiglia di Pola in Esilio.
9 Eros de Franceschini, candidato in Liguria, durante un comizio tenuto a Camogli in vista della consultazione che si concluse con la clamorosa sconfitta del blocco di sinistra costituito dal Partito Comunista Italiano e dal Partito Socialista Italiano (Fronte Democratico Popolare, con l’icona di Garibaldi quale simbolo elettorale) e la maggioranza assoluta conquistata dalla Democrazia Cristiana, si permise di inveire contro i «banditi» giuliani che avevano abbandonato il cosiddetto paradiso di Tito, utilizzando un gioco di parole per equipararli al celebre bandito Salvatore Giuliano che infestava la Sicilia Occidentale con le sue gesta criminali. Erano passati tre anni dalla fine del conflitto ma si faceva di tutto per infoibare anche la verità storica e il buon senso comune.
10 Il «Giorno del Ricordo» venne istituito a quasi 60 anni dai fatti con la citata Legge 30 marzo 2004 numero 92 (altrimenti nota come Legge Menia dal nome del primo proponente) che fu votata quasi all’unanimità, ma che nonostante tale approvazione plebiscitaria (si ebbero solo 15 deputati contrari) è tuttora oggetto di pervicaci opposizioni e di un ostracismo antagonista tanto più vivace in quanto la normativa è sostanzialmente priva di sanzioni per i casi di inadempienza.
11 L’affermazione è mutuata dall’occhiello della «Vedetta d’Italia» che fu il primo Organo del mondo esule da Fiume, e il cui primo numero porta la data del 1951. Nell’editoriale, il Direttore Giovanni Perini invocava giustizia e concludeva con l’augurio di «vedere ancora una volta la Patria fino al Carnaro» (Carlo Montani, La piccola Vedetta fiumana: storia di un periodico dell’Esilio, Edizioni ANVGD, Comitato provinciale di Firenze 1993, pagine 65-68).
12 Nell’ambito delle opere storiografiche citate in precedenza (e all’interminabile serie di testimonianze dirette) è congruo un ulteriore riferimento a quella di Italo Gabrielli, Istria Fiume Dalmazia: Diritti negati – Genocidio programmato, Trieste 2018. Ciò, sia con riguardo alla menzionata applicabilità della definizione giuridica di genocidio a esodo e foibe, sia con riferimento all’orchestrazione di una specifica strategia da parte dell’OZNA, la polizia politica del regime jugoslavo, «impegnata a creare il terrore in funzione del possesso del territorio» (Ibidem, pagina 37, pagina 152): tesi suffragata anche da storici come Elio Apih, orientato non certo a destra.
13 Treatment of the Italians by the Yugoslavs after September 8th 1943, Roma 1946, 128 pagine. Il testo si compone di due parti: la prima è dedicata al comportamento delle forze slave di occupazione, mentre la seconda riguarda la conduzione dei campi di prigionia jugoslavi in cui vennero rinchiusi, spesso fino alla morte, militari e civili italiani. Nel 2011 il documento è stato finalmente pubblicato nella versione italiana di Mila Mihajlovic a cura dell’Associazione Nazionale Dalmata e presentato a Roma, primo relatore il Senatore Ajmone Finestra.
14 Quella di «marcia verso il nulla» è pertinente ed efficace espressione di sintesi, mutuata dal pensiero di Jean François Revel, il politologo che fu Accademico di Francia, filosofo, storico e giornalista, nonché «ghost-writer» del Presidente della Repubblica François Mitterrand. Le contraddizioni del sistema comunista erano già state intuite sin dall’epoca in cui la sua catarsi sembrava impossibile: al riguardo, e a titolo esemplificativo ma significativo, è sempre attuale l’opera di James Burnham, L’inevitabile disfatta del comunismo, Mondadori Editore, Milano 1953, 316 pagine. Per la teoria di una volontà politica avulsa dai valori positivi della civiltà umana, di cui al successivo riferimento, confronta Gerhard Ritter, Il volto demoniaco del potere, Società Editrice il Mulino, Bologna 1958: nella fattispecie, con riferimento alle possibili conseguenze di una «Ragione di Stato» legata alla capacità di «serbare una fredda mente» prescindendo dalla «passionalità che acceca» nell’intento di governare in base a criteri razionali ma potenzialmente perversi (pagina 191) da cui discendono la negazione di quei valori ideali e il rischio di provocare la reazione della storia, capace di «reagire come un cane rabbioso» (come da pertinente affermazione di Georg Friedrich Hegel).
15 Confronta Carlo Montani, Echi, memorie e speranze del secolo breve, capitolo XIII: Diktat 1947 - Gli articoli dell’infamia, in «Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale», anno XVI numero 48, Casa Editrice Aracne, Roma 2014, pagine 147-182. Al riguardo, particolare attenzione viene attirata, fra gli altri, sugli articoli 15 e 16 del «trattato»: il primo, per avere statuito la consegna dei «criminali di guerra» su semplice richiesta di controparte (la Jugoslavia lo fece per una cifra di parecchie centinaia, superiore a quella complessiva degli altri 20 vincitori) e il secondo per avere imposto all’Italia di «non incriminare né perseguitare i suoi cittadini», compresi gli appartenenti alle Forze Armate che avessero agito o anche solo «simpatizzato» in favore degli Alleati (edulcorata definizione del tradimento).
16 Confronta Samuel Johnson, Esperienza e vita morale, con traduzione e introduzione di Ada Prospero, Editori Giuseppe Laterza & Figli, Bari 1939, pagina 10.