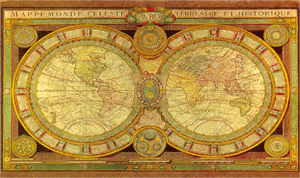Genova 60 anni dopo
L’insurrezione del capoluogo ligure per il
Congresso del Movimento Sociale Italiano all’epoca del
Governo Tambroni sostenuto dalla Destra Nazionale (30 giugno
1960)
Non sono molti coloro che dopo 60 anni ricordano con sufficiente consapevolezza storica quanto avvenne a Genova (e altrove) tra la fine di giugno e i primi di luglio del 1960, quando l’ordine pubblico venne messo a soqquadro e una trentina di poliziotti furono sfregiati dagli uncini dei camalli rischiando la vita, e in taluni casi riportando danni perenni, mentre un loro ufficiale fu salvato a stento dalla furia dei «rossi» che tentarono di annegarlo nella fontana di Piazza De Ferrari. La causa scatenante della violenza estremista, nel caso specifico chiaramente strumentale, era stata la decisione del Movimento Sociale Italiano di convocare proprio a Genova il suo sesto Congresso nazionale, che l’opposizione affermava costituire offesa intollerabile per una città insignita di Medaglia d’Oro della Resistenza: cosa piuttosto opinabile, se non altro perché quattro anni prima nulla era accaduto a Milano (1956) né sei anni prima a Viareggio (1954) in occasione dei precedenti Congressi missini.
Il fatto nuovo era un altro, che per taluni aspetti aveva assunto carattere rivoluzionario: il Movimento Sociale Italiano, dopo tanti anni di opposizione pregiudiziale, era diventato forza di governo grazie ai decisivi voti parlamentari in favore del Gabinetto presieduto da Fernando Tambroni, e prima ancora, alla formula trasversale varata in Sicilia dal Presidente della Regione Silvio Milazzo. Tutto ciò non poteva essere consentito da una Democrazia Cristiana che in maggioranza era già propensa ad aprire a sinistra, abbandonando un centrismo ormai precario, chiamando il Partito Socialista Italiano a nuova responsabilità governativa, e lasciando all’opposizione i liberali e i monarchici. A più forte ragione, non poteva essere ammesso da un Partito Comunista Italiano che avvertiva il pericolo di perdere l’alleanza socialista e intendeva sfruttare al massimo la sua organizzazione paramilitare, garantita da un movimento partigiano ancora molto forte, e certamente spregiudicato. Del resto, erano passati «appena» 15 anni dalla fine della guerra.
Il siluramento di Tambroni, che sarebbe caduto per una crisi extra parlamentare, fu ordito dagli stessi democristiani. Il Ministro dell’Interno Giuseppe Spataro ci mise del suo dando disposizione perché la polizia andasse disarmata in piazza e facendo in modo che i dimostranti ne fossero informati, mentre i carabinieri, che erano armati, ebbero l’ordine di non intervenire e non subirono aggressioni di sorta. Giova aggiungere che i «fatti di Genova» non furono isolati, perché il clima di forte opposizione si diffuse anche in altre Regioni, e segnatamente in Emilia, dove gli eventi più gravi ebbero luogo a Reggio, che il 7 luglio vide la polizia sparare ad altezza d’uomo durante una manifestazione sindacale uccidendo cinque dimostranti, che andarono ad aggiungersi al caduto di due giorni prima a Licata.
Queste vicende complesse, a distanza di 60 anni, sono state parzialmente dimenticate ma conservano una precisa valenza storica perché attestano la permanenza di un clima di tensione pregiudiziale, sostanzialmente avulsa dalle regole fondamentali di una democrazia basata sul confronto: oltre tutto, in un’epoca di ragguardevole progresso economico e di sostanziale superamento delle antinomie che avevano caratterizzato l’immediato dopoguerra, ma nello stesso tempo, di reazioni certamente emozionali da parte della forza pubblica.
Nel quindicennio compreso fra il 1945 e il 1960 il Movimento Sociale Italiano aveva dovuto confrontarsi con le diverse «anime» che ne distinsero la dialettica interna, non già in una logica correntizia, ma nell’esigenza di un impegno condiviso da tutti per la ricostruzione della Patria e dei suoi valori. Cambiavano la strategia e la tattica, a fronte di un obiettivo che era sostanzialmente lo stesso: c’era la cosiddetta «sinistra nazionale» che perseguiva scopi prioritari di equità socio-economica e non faceva mistero di preferire la logica della programmazione a quella della libera iniziativa; c’era la componente «spiritualista» che si richiamava agli insegnamenti di Julius Evola e di Giovanni Gentile; c’era una destra in cui la pur difficile catarsi non escludeva la progressiva accettazione del sistema parlamentare e della dialettica fra i partiti.
Queste differenze, che non di rado si traducevano in autentiche divergenze, pur superate nel tradizionale cameratismo, trovavano un punto d’incontro più convinto nel comune riconoscimento di una realtà etica dello Stato, in evidente antitesi rispetto alle concezioni altrui, a cominciare da quella cattolica e da quella comunista: due «fedi opposte», per dirla con Benedetto Croce, in cui l’idea di Stato veniva subordinata ad altri valori assumendo un carattere strumentale obiettivamente inaccettabile da parte di chi vi ravvisava, invece, una forma superiore di volontà della Nazione, e prima ancora, di superamento dell’individualismo e del «particulare» caro a Francesco Guicciardini, nell’ottica comunitaria.
Non a caso, dopo tanti anni di lungo e spesso sofferto confronto la mozione predisposta per il Congresso di Genova dal Segretario Arturo Michelini aveva raccolto le adesioni di tutte le componenti, in un quadro unitario ampiamente condiviso: tra gli altri, anche da Giorgio Almirante, che fino a quattro anni prima aveva mostrato di propendere per atteggiamenti pregiudiziali, poi riveduti alla luce dell’esperienza siciliana, e soprattutto di quella consentita a livello nazionale dalla breve stagione del Governo Tambroni.
Quella mozione costituisce una «summa» dell’impostazione politica che il Movimento Sociale intendeva assumere nella prospettiva degli anni Sessanta, accettando di misurarsi a tutto campo con le altre forze su tutte le questioni di massima rilevanza nella dialettica dei partiti: una politica estera atlantica ma estremamente attenta alla difesa dei valori nazionali, a cominciare dalle zone di confine come l’Alto Adige e la Venezia Giulia, per finire con la revisione del trattato di pace; una politica interna basata sulla realtà di uno Stato ragionevolmente forte che garantisse l’ordine e il rispetto della legge senza trascurare la riforma del bicameralismo e l’impegno a favore dell’unità; una strategia economica e sociale che prevedesse la partecipazione dei lavoratori alle gestioni aziendali, un sindacato indipendente dai partiti e giuridicamente riconosciuto, e la valorizzazione delle categorie.
Con Genova, e con le progressive aperture a sinistra che ne sarebbero scaturite, fu perduta, in primo luogo a causa della Democrazia Cristiana, un’occasione storica. Il Movimento Sociale Italiano fu estraniato nel ghetto predisposto dagli inventori del cosiddetto «arco costituzionale» (una formula quanto meno opinabile sul piano giuridico) ma ciò non gli avrebbe impedito di consolidare le proprie opzioni fondamentali in una sorta di fiume carsico destinato a tornare alla luce in tempi lontani e in modi all’epoca imprevedibili. Quello missino fu un elettorato fedele, al pari di quanto era accaduto prima del 1960: ciò, sin dai primi confronti nelle urne come quello del 18 aprile 1948 quando il nuovo partito, sebbene condizionato dall’antitesi epocale fra la Democrazia Cristiana e il blocco social-comunista, fu capace di eleggere i suoi primi parlamentari; ovvero, da quello del 7 giugno 1953, quando ottenne oltre un milione e mezzo di suffragi, contribuendo in modo determinante ad affossare la cosiddetta «legge truffa» voluta dal Governo De Gasperi, che avrebbe consentito alle forze governative (democristiani, socialdemocratici, repubblicani e liberali) di lucrare un significativo premio di maggioranza qualora avessero ottenuto oltre il 50% dei voti.
Del resto, la fedeltà dell’elettorato missino sarebbe stata confermata anche in tempi notevolmente successivi, quando la scissione di Democrazia Nazionale fu affossata dalle urne.
Resta da dire che quello promosso in occasione dei «fatti di Genova» del 1960 – aggravato dal comportamento delle forze dell’ordine sia nel capoluogo ligure che altrove – fu un clima di pesante intimidazione alimentato dai vertici della sinistra, a cominciare dallo stesso Sandro Pertini, esponente di punta del Partito Socialista Italiano, secondo cui il Movimento Sociale Italiano non sarebbe stato un partito ma «un’associazione a delinquere» nei cui confronti i partigiani avevano commesso nel 1945 l’errore di essere stati «troppo generosi» salvo manifestare una rinnovata disponibilità a scendere in piazza «per farla scomparire del tutto». Non c’è che dire: ecco una buona ragione per collocare nella giusta dimensione etico-politica coloro che scelsero di battersi, in condizioni oggettivamente assai difficili, per valori e riferimenti a cui diversi oppositori di quella stagione davvero calda si sarebbero avvicinati in tempi successivi.