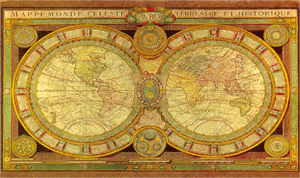Le più belle pagine sull’Italia
Dall’antichità ai giorni nostri, alcune
tra le più belle pagine scritte sul nostro Paese
Esiste, nel mondo, un luogo che sembra racchiudere in sé le innumerevoli bellezze della natura: sorgenti calde, dune di sabbia, paludi, monoliti naturali, crateri, canyon, gole e strapiombi scavati, modellati, rifiniti dall’incessante opera del sole, della pioggia e del vento. Questo luogo è l’Italia, la cui bellezza naturale, decantata fin dall’antichità, è oggi esaltata dalle innumerevoli opere d’arte che la ornano: nella Penisola si trovano il 50% dei beni artistici del mondo e il 72% di quelli europei – oltre 100.000 chiese e monumenti, 40.000 case storiche, più di 1.000 teatri e 2.500 siti archeologici. Nessun’altra Nazione può vantarsi di aver dato e di dare quanto l’Italia sul versante del pensiero e della cultura, della civiltà. Ha detto Orson Welles, attore e regista statunitense di primo livello, che «per trent’anni, sotto i Borgia, gli Italiani hanno avuto guerre, terrore, spargimento di sangue e morte, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. Gli Svizzeri hanno avuto cinquecento anni di democrazia e di pace, e che cos’hanno prodotto? L’orologio a cucù».
Ci si potrebbe chiedere perché il «genio» sia fiorito in Italia più che nelle altre Nazioni. Probabilmente non tanto per ragioni biologiche, quanto per ragioni storiche: l’essere stato per secoli diviso in tanti Stati in continua lotta fra loro e con le potenze straniere, ha forgiato il carattere di un popolo tenace, abituato a ricostruire con pazienza ciò che veniva periodicamente distrutto, e facendo della cultura non solo un valore, ma la forma stessa dell’identità nazionale.
Un’identità che è sempre stata riconosciuta da un popolo sì litigioso, indisciplinato, ipercritico, incapace di fare gioco di squadra, povero di educazione politica e civile, ma anche generoso, cordiale, pieno di buon gusto, creativo e capace di ridere. Un’identità che si è sempre dovuta confrontare con obiettive diversità, rivalità e differenti punti di vista.
È interessante ripercorrere questo tema leggendo alcune tra le più significative pagine scritte dall’antichità romana al recente passato.
«Già sotto i raggi il mare arrossava, e dall’alto del cielo
+ l’Aurora nel roseo carro splendeva dorata,
quando i venti posarono, all’improvviso ogni alito
cadde: nell’immobile piano si affaticano i remi.
E qui Enea grande, dal mare, un bosco divino
avvista. Nel mezzo, il Tevere con l’amena corrente,
a mulinelli rapidi, biondo di molta arena, prorompe
in mare. E sopra e all’intorno, variopinti, gli uccelli
avvezzi alle rive e al greto dei fiumi col canto
accarezzavano l’aria e per il bosco volavano.
Piegare il cammino, volgere a terra le prore, questo comanda
ai compagni, e nell’ombroso fiume entra, lieto» (VII, 25-36).
Enea, l’eroe troiano sopravvissuto alla distruzione della sua città, dopo infinite peripezie sbarca sulle coste del Lazio. Dopo aver sposato la figlia del Re Latino fonda la città di Lavinio, e alla sua morte il figlio fonda Alba Longa. La figlia di uno dei discendenti di questo, Rea Silvia, concepisce due gemelli, Romolo e Remo. Il resto è troppo noto per doverlo ricordare. Siamo alle soglie della fondazione di Roma, che il racconto virgiliano è volto a nobilitare. La descrizione dello sbarco alle foci del Tevere, che richiama la natura tanto cara al poeta, ci fa ricordare l’articolo 9 della nostra Costituzione: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
«Ma ricerchiamo perché (l’insieme delle lingue romanze) si sia in triplice maniera diversificato e perché ciascuna di queste varietà si diversifichi entro se stessa, per esempio la parlata della destra d’Italia da quella che è della sinistra (infatti in un modo parlano i Padovani, in un altro i Pisani); e perché quelli che abitano più vicino differiscano ancora nel parlare, come Milanesi e Veronesi, Romani e Fiorentini, ed inoltre quelli che s’accomunano nella stessa stirpe di popolo, come Napoletani e Gaetani, Ravennati e Faentini; e, ciò che fa più meraviglia, quelli che dimorano sotto uno stesso cittadino reggimento, come i Bolognesi del Borgo di San Felice ed i Bolognesi di Strada Maggiore» (I, 9).
Profeta dell’Italia unita, Dante è attento alle varietà regionali delle lingue, di cui dà vari esempi. Muovendo da un panorama della Penisola a volo d’uccello (simile a quelli della Commedia), e attribuendo all’Appennino una funzione distintiva tra dialetti dell’Est e dell’Ovest, arriva alle varietà più minute, come quelle interne al bolognese. Il poeta è consapevole dell’evoluzione dell’idioma, che rientra nella variabilità del costume e del gusto. Di molti dialetti darà esempi nel seguito del trattato, non per deprimerli, ma per dimostrare le maggiori possibilità espressive del volgare illustre che stava contribuendo a creare.
«Non si debba, dunque, lasciare passare questa occasione, acciò che la Italia, dopo tanto tempo, vegga uno suo redentore. Né posso esprimere con quale amore e’ fussi ricevuto in tutte quelle provincie che hanno patito per queste illuvioni esterne; con che sete di vendetta, con che ostinata fede, con che pietà, con che lacrime. Quali porte gli si serrerebbano? quali populi gli negherebbano la obedienzia? quale invidia se li opporrebbe? quale Italiano li negherebbe l’ossequio? A ognuno puzza questo barbaro dominio. Pigli, dunque, la illustre Casa Vostra questo assunto con quello animo e con quella speranza che si pigliano le imprese iuste…» (XXVI, 7).
Non bisogna cercare in questo celebre testo quello che esso non può dare: l’idea, cioè, che Machiavelli, mentre faceva appello a un principe di Casa Medici perché ponesse fine al «barbaro dominio» in Italia, pensasse ad una Nazione unita. Egli pensava piuttosto ad un forte Stato nell’Italia Centrale, caposaldo di una lega fra gli altri Sovrani italiani: la cultura del Cinquecento non conosceva il concetto e il sentimento di Nazione. E tuttavia il carattere ispirato dell’appello di Machiavelli affascinò eminenti personalità del nostro Risorgimento: così Francesco De Sanctis vi vide una commossa invocazione alla «patria», alla «Nazione autonoma e indipendente».
«Molte volte coloro che vanno in maschera, o son persone vili che sotto quell’abito voglion farsi stimar signori e gentiluomini… o talora son gentiluomini che deponendo, così sconosciuti, il rispettoso decoro richiesto a lor grado, si fanno lecito, come si costuma in molte città d’Italia, di poter d’ogni cosa parlare liberamente con ognuno, prendendosi insieme altrettanto diletto che ognuno, sia chi si voglia, possa con essi motteggiare e contender senza rispetto».
Non è che Galileo ce l’avesse con il Carnevale! Se la prendeva invece con tutti coloro che usano la maschera di uno pseudonimo, mostrando di non avere il coraggio di sostenere pubblicamente le loro opinioni. La loro «libertà» era solo una fuga dalla responsabilità, e questo «costume di molte città d’Italia» significava che il Paese era davvero poco più di un’espressione geografica. Sarà la scienza a plasmare la nuova fisionomia dell’Italia, non meno che le lettere e le arti. E gli spiriti veramente liberi d’Europa verranno a visitare la terra di Galileo per incontrare l’uomo che alla fine scontò la sua audacia con il processo e la condanna.
«I tuoi confini, o Italia, son questi! ma sono tutto dì sormontati d’ogni parte dalla pertinace avarizia delle Nazioni. Ove sono dunque i tuoi figli? Nulla ti manca se non la forza della concordia. Allora io spenderei gloriosamente la mia vita infelice per te: ma che può fare il solo mio braccio e la nuda mia voce? – Ov’è l’antico terrore della tua gloria? Miseri! noi andiamo ogni dì memorando la libertà e la gloria degli avi, le quali quanto più splendono tanto più scoprono la nostra abbietta schiavitù. Mentre invochiamo quelle ombre magnanime, i nostri nemici calpestano i loro sepolcri».
La riflessione sulla servitù dell’Italia rappresenta uno dei temi di fondo del romanzo foscoliano, costruito attorno a una doppia delusione, sentimentale e soprattutto politica. Accolto entusiasticamente da tanti giovani, il libro ne avrebbe stimolato l’impegno nelle battaglie risorgimentali. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, infatti, trasmettevano o confermavano l’idea che il sentimento, la fantasia, il sogno perfino, sono superiori alla ragione «fredda» e «calcolatrice». Sarebbe nata anche da questa nuova sensibilità romantica la disponibilità di tanti a combattere, spesso a morire, per l’indipendenza italiana.
«O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l’erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue!...».
La forza profetica della grande poesia illumina passato e presente. Sono trascorsi quasi due secoli da quando, nel 1818, Leopardi scrisse questa canzone. L’antica gloria non è riaffiorata, anche se alcuni momenti della storia hanno fatto onore alla Patria: il Risorgimento, i Mille e, nel Novecento, il Piave, la Costituzione. Gli scarponi degli eserciti stranieri non calpestano il nostro suolo, ma le mura sono spesso crollate, i paesaggi, le antiche città, l’arte e la cultura tenuti in poco conto; c’è chi mette in discussione l’Unità d’Italia costata sangue e dolore. La speranza? Un sussulto di dignità della Nazione.
«Cara Italia! dovunque il dolente
Grido uscì del tuo lungo servaggio;
Dove ancor dell’umano lignaggio
Ogni speme deserta non è;
Dove già libertade è fiorita,
Dove ancor nel segreto matura,
Dove ha lacrime un’alta sventura,
Non c’è cor che non batta per te.
Quante volte sull’Alpe spiasti
L’apparir d’un amico stendardo!
Quante volte intendesti lo sguardo
Ne’ deserti del duplice mar!
Ecco alfin dal tuo seno sbocciati,
Stretti intorno a’ tuoi santi colori,
Forti, armati de’ propri dolori,
I tuoi figli son sorti a pugnar.
Oggi, o forti, sui volti baleni
Il furor delle menti segrete:
Per l’Italia si pugna, vincete!
Il suo fato sui brandi vi sta.
O risorta per voi la vedremo
Al convito de’ popoli assisa,
O più serva, più vil, più derisa
Sotto l’orrida verga starà.
Oh giornate del nostro riscatto!
Oh dolente per sempre colui
Che da lunge, dal labbro d’altrui,
Come un uomo straniero, le udrà!
Che a’ suoi figli narrandole un giorno,
Dovrà dir sospirando: io non c’era;
Che la santa vittrice bandiera
Salutata quel dì non avrà».
È la più bella poesia del Risorgimento, che andrebbe letta per intero anziché nelle sole strofe finali. Benché scritta agli albori del riscatto nazionale, poté vedere la luce solo nel 1848, dopo le Cinque Giornate, non appena Milano si liberò dagli Austriaci. È un grido d’amore per l’Italia, e di battaglia contro lo stato di minorità civile e politica in cui essa era ridotta; un incitamento a porre fine all’umiliazione del dominio straniero. Una lotta che sarà combattuta dagli Italiani in prima persona, decisi a non contare più come in passato su alcun aiuto di qualche altra potenza europea. Ma insieme anima questi versi – significativamente dedicati a un patriota tedesco caduto nelle guerre di liberazione contro Napoleone – un empito che va oltre i confini della Penisola: la causa dell’Italia, sembra suggerire Manzoni, segna in qualche modo la fine degli egoismi nazionali, è la causa di tutti gli uomini che aspirano alla libertà.
«Io nacqui Veneziano al 18 ottobre del 1775, giorno dell’Evangelista Luca; e morrò per la grazia di Dio Italiano quando lo vorrà quella Provvidenza che governa misteriosamente il mondo.
Ecco la morale della mia vita… Ma in tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno di esser narrato, se la mia vita non correva a cavalcione di questi due secoli che resteranno un tempo assai memorabile, massime nella storia italiana. Infatti fu in questo mezzo che diedero primo frutto di fecondità reale quelle speculazioni politiche che dal milletrecento al millesettecento traspirarono dalle opere di Dante, di Macchiavello, di Vico e di tanti altri» (capitolo I).
La grande opera di Ippolito Nievo è un romanzo di formazione. Ha il taglio di un picaresco racconto d’avventure, ma è la storia del modo in cui il protagonista, nato in un angolo della Serenissima alla fine dell’Ancien Régime, diventa, dopo avere attraversato le principali fasi del Risorgimento, il cittadino di un nuovo Stato. Ma questo Stato non è soltanto il frutto di moti recenti, dovuti in buona parte alla Rivoluzione Francese e alla discesa di Bonaparte in Italia: è anche il risultato di un lungo processo storico anticipato da alcuni degli uomini più eminenti della cultura europea. Nasce così l’Italia moderna, troppo giovane per essere davvero una Nazione compiuta e forse troppo vecchia per diventare uno Stato moderno.
«Se domani io entrassi in lotta con Garibaldi, è possibile che avrei per me la maggior parte dei vecchi diplomatici, ma l’opinione pubblica europea sarebbe contro di me, e l’opinione pubblica avrebbe ragione. Poiché Garibaldi ha reso all’Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle: ha dato agli Italiani fiducia in se stessi; ha provato all’Europa che gli Italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una Patria» (9 agosto 1860).
Così Cavour scriveva – a Costantino Nigra, in francese – del suo grande nemico Garibaldi. La grandezza, l’intelligenza, la nobiltà d’animo del conte sono tali da fargli riconoscere che l’Italia aveva bisogno di entrambi: il genio diplomatico, e quello militare; lo statista, e il condottiero; le élites, e il popolo; la mente, e il cuore.
«Io vi proposi di fare un’inchiesta affinché una metà della Nazione conoscesse appieno l’altra metà, e le due parti della Penisola si unissero fraternamente; mi rispondeste essere l’inchiesta inutile, i mali passeggeri… Voi vedrete se il sangue stesso degli uomini giustamente sacrificati onori il giovane Regno, il quale sorge pure sulla terra dove Filangeri e Beccaria predicavano umanità, e dove sotto i migliori Governi napoletani si viaggiava sulle montagne coll’oro in mano. Fate voi stessi la vostra inchiesta: vedete se non avete permesso alla reazione di scoppiare, ai briganti di corrompere interi paesi, alle popolazioni di molti luoghi di turbarsi riflettendo all’avvenire promesso dalla nostra rivoluzione» (Atti parlamentari, seduta del 2 dicembre 1861).
Il deputato milanese Giuseppe Ferrari, quel 2 dicembre 1861, era furente mentre tuonava al Parlamento di Torino contro una scelta scellerata dell’Italia appena nata. Lui, patriota italiano ma indisponibile al patriottismo ottuso e cieco, aveva già chiaro tutto: era un errore stendere un velo di silenzio sul massacro degli abitanti di Pontelandolfo commesso dai bersaglieri. Un errore liquidare il brigantaggio come una questione di ordine pubblico. Un errore imporre lo Stato (sabaudo) con la forza e la violenza senza tentare di coinvolgere i cittadini nel processo unitario rispettoso delle diversità. Un secolo e mezzo dopo, chi ama l’Italia sospira: ah, se l’avessero ascoltato…
«Genova, 5 maggio…
Ieri sera arrivammo ad ora tarda, e non ci riusciva di trovar posto negli alberghi, zeppi di gioventù venuta di fuori. Sorte che, lungo i portici bui di Sottoripa, ci si fece vicino un giovane, che indovinando, senza tanti discorsi, ci condusse in questo albergo. La gran sala era tutta occupata. Si mangiava, si beveva, si chiacchierava in tutti i vernacoli d’Italia. Però si sentiva che quei giovani, i più, erano Lombardi. Fogge di vestire eleganti, geniali, strane; facce baldanzose; persone nate fatte per faticare in guerra, e corpi esili di giovanetti, che si romperanno forse alle prime marce. Ecco ciò che vidi in una guardata. Entravamo in famiglia».
Scegliamo le parole della vigilia, piene di aspettativa e di entusiasmo, in atmosfera di festa, quasi, perché straordinariamente somigliano a quelle che si possono leggere dall’altra parte, appartenenti a giovani sudditi dell’Impero Austro-Ungarico – Trentini, Tirolesi, ma anche Ungheresi, Cechi e Polacchi – che pochi anni dopo si sarebbero apprestati a salire volontari nelle valli trentine per tentar di fermare Garibaldi che avanzava. Stesso clima euforico, stessa sensazione di fratellanza, stessa ansia di prendere le armi. Citate soltanto di sfuggita e, quasi, con vergogna, le madri disperate che, qua come là, cercavano di riportarsi a casa i figli giovanissimi.
«I tempi sono oggimai sconsolati di bellezza e d’idealità; direbbesi che manchi nelle generazioni crescenti la conscienza nazionale.
Tanto più siano grazie a te, o nobile Reggio, che nell’oblio d’Italia commemori come nella sala di questo palazzo di città, il 7 gennaio del 1797, fu decretato nazionale lo stendardo dei tre colori.
L’Italia è risorta nel mondo per sé e per il mondo: ella, per vivere, dee avere idee e forze sue, deve esplicare un officio suo civile ed umano, un’espansione morale e politica. Tornate, o giovani, alla scienza e alla conscienza de’ padri, e riponetevi in cuore quello che fu il sentimento di vóto, il proposito di quei vecchi grandi che han fatto la patria: L’Italia avanti tutto! L’Italia sopra tutto!».
Il testo è tratto dal discorso pronunciato a Reggio Emilia da Giosuè Carducci il 7 gennaio 1897 per commemorare il centenario del Tricolore, adottato come proprio vessillo dalla Repubblica Cisalpina il 7 gennaio 1797. Il discorso rievoca il significato simbolico del Tricolore nel Risorgimento italiano – Risorgimento che appare già dimenticato («nomi e fatti dimenticati della storia recente») mentre è in atto una grave crisi politica alla quale fa cenno l’inizio del testo riportato; poi il discorso si chiude con un vibrato appello all’impegno dei giovani e alla missione dell’Italia.
«Il cosmopolitismo tradizionale italiano dovrebbe diventare un cosmopolitismo di tipo moderno, cioè tale da assicurare le condizioni migliori di sviluppo all’uomo-lavoro italiano, in qualsiasi parte del mondo egli si trovi. Non il cittadino del mondo in quanto civis romanus o in quanto cattolico, ma in quanto produttore di civiltà. Perciò si può sostenere che la tradizione italiana si continua dialetticamente nel popolo lavoratore e nei suoi intellettuali, non nel cittadino tradizionale e nell’intellettuale tradizionale. Il popolo italiano è quel popolo che “nazionalmente” è più interessato a una moderna forma di cosmopolitismo. Non solo l’operaio, ma il contadino e specialmente il contadino meridionale» (Quaderno 19, § 5).
Questo brano smentisce uno dei luoghi comuni vigenti intorno alla visione gramsciana della positività del processo unitario e della possibilità di coniugare tale processo non già con la devianza nazionalistica, ma con una visione rinnovata del cosmopolitismo. Ciò nasce dalla sua decisiva esperienza all’interno di un movimento politico, quello comunista dell’inizio degli anni Venti, intrinsecamente internazionalista. Pur dentro un orizzonte più vasto, Gramsci non smarrisce mai la necessaria percezione delle specificità nazionali, che áncora non già ad un presunto «carattere originario», ma al ruolo e allo scontro dialettico delle classi sociali.