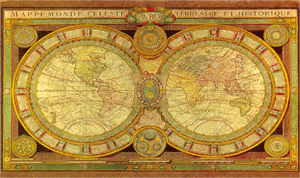Papa Gregorio VII
Un imperativo categorico per i valori non
negoziabili nella sintesi di fede ed azione
«Dilexi justitiam, odivi iniquitatem, propterea morior in exilio». Le celebri parole che secondo la tradizione vennero pronunciate in punto di morte (25 maggio 1085) sono scolpite sotto la teca che ospita nella Cattedrale di Salerno le spoglie mortali di Papa Gregorio VII, al secolo Ildebrando di Soana, passato alla storia per avere promulgato il cosiddetto Dictatus (1075) secondo cui il Sommo Pontefice è il «Vescovo universale» con poteri decisionali estesi a tutti i problemi della Cristianità, e per avere affermato a Canossa (1077) la supremazia dell’ordine spirituale su quello politico, accettando la sottomissione dell’Imperatore Enrico IV e revocando la scomunica che gli aveva comminato; salvo subire in tempi successivi la recrudescenza della lotta per le investiture culminata nella designazione dell’antipapa Clemente III (1084) e nella partenza di Gregorio VII per l’esilio di Salerno, dove scomparve dopo breve tempo.
Al di là delle complesse vicende che contraddistinsero il Pontificato di Ildebrando, e dell’eccezionale importanza di San Gregorio VII nella storia della Chiesa Cattolica, è congruo ricordare, nella frase affidata al marmo del sepolcro salernitano, il valore di una perenne attualità. Il messaggio è chiaro: si deve amare ciò che è buono e giusto, e conseguentemente bisogna esorcizzare il male, mettendolo al bando della prassi, ma nello stesso tempo è necessario affrontare virilmente le conseguenze di una temporanea sconfitta nella lotta contro l’iniquità, sempre possibile ed in qualche misura maieutica, accettando il calvario di un esilio che per il Papa ebbe ad assumere un carattere amarissimo, avendo comportato l’estromissione dal Soglio di San Pietro Apostolo.
Per il Papa Gregorio VII, in buona sostanza, si può e si deve amare la giustizia, ma si può e si deve odiare l’iniquità: in altri termini, nella deontologia cristiana non c’è spazio soltanto per l’amore, e quindi per la pazienza e la sopportazione, ma c’è spazio anche per un odio attivo e consapevole nei confronti di tutto ciò che si oppone all’amore ed agli altri valori positivi, a cominciare dalla giustizia. Lungi da ogni buonismo, come si direbbe oggi, ed a costo di dover affrontare, appunto, il grande dramma dell’esilio.
In chiave filosofica, non è azzardato ravvisare nel pensiero di Papa Ildebrando un imperativo categorico non dissimile da quello di Kant, che del resto appartiene ai grandi spiriti, senza differenze di tempi e di luoghi. Nello stesso tempo, è possibile scorgervi un riferimento dialettico, laddove l’accettazione dell’esilio costituisce la sintesi di una tesi (amare la giustizia) e di un’antitesi corrispondente (odiare l’iniquità). Più che un’anticipazione di Hegel, è un atto di fede e di speranza.
Sin dai tempi più remoti, la forte pena dell’esilio aveva assunto caratteri di particolare gravità, inferiori soltanto a quelli della morte. Oggi, pur avendo perduto la matrice giudiziaria che era stata tipica del diritto romano, è diventata tristemente frequente nella configurazione di cui fu vittima il Pontefice Gregorio VII: quella di una costrizione ineludibile ad opera di poteri forti che non esitano a negare i diritti umani, espungendo intere popolazioni dalle proprie terre avite, e costringendole ad un’anabasi spesso drammatica. Basti pensare alle grandi ondate di profughi che hanno segnato la storia del Novecento, ed alle tragedie individuali e collettive che ne sono scaturite, in misura quantitativa certamente superiore a quelle di epoche precedenti.
Non a caso, il giurista polacco Raphael Lemkin ha ravvisato gli estremi del genocidio in quell’autentico delitto contro l’umanità che si traduce nell’esilio forzato di interi popoli, anche quando non sia accompagnato, se non in parte minoritaria, dalla loro persecuzione fino all’estremo sacrificio della vita. Del resto, lo sradicamento del profugo dai propri contesti originari ha finito per diventare, in parecchie circostanze dolorose, una vera e propria morte civile, anticamera di quella fisica.
In questo senso, le parole di San Gregorio VII sono emblematiche, richiamandosi alla necessità permanente di battersi sotto la bandiera della verità e della giustizia. Non a caso, Papa Ildebrando sarebbe stato elevato alla gloria degli altari, sia pure a distanza di secoli, durante il grande Pontificato di Paolo V Borghese (1606) e senza dire che Giovanni Paolo II, ricorrendo il 900° anniversario della morte (1985), avrebbe detto proprio a Salerno che Gregorio «si era impegnato per la libertà dell’uomo» a cui aveva aspirato «in quanto libertà dal male e dal peccato».
Una libertà, giova ribadirlo, che non è offerta alla stregua di un dono, ma che costituisce una diuturna, sofferta conquista della volontà umana sorretta dalla fede.
«Dilexi justitiam, odivi iniquitatem, propterea morior in exilio». Le otto parole latine scolpite alla base del sepolcro papale debbono considerarsi un autentico testamento spirituale che invita a riflessioni non effimere, anche agli albori del terzo millennio. Breve nella dimensione materiale, diventa molto grande nel suo valore di forte altezza etica, che si allinea – con un’anticipazione di circa nove secoli – al pensiero del Vescovo di Trieste e Capodistria colpito «in odium fidei», Monsignor Antonio Santin, secondo cui le vie dell’iniquità non possono essere eterne: anche questa, professione di alta speranza cristiana, e nello stesso tempo di rinnovata certezza circa la vittoria finale dei valori non negoziabili.