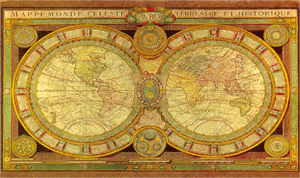La Peste Nera
Nel XIV secolo la peste, la cosiddetta
«peste nera», eliminò in Italia e in Europa almeno un terzo
della popolazione. Ma a tempi alterni fu presente dal XIII
al XVIII secolo
Nel Medioevo, il termine peste (traduzione dal latino di «pestis» con il significato di rovina, distruzione, epidemia) era attribuito a molte malattie, che quasi sempre avevano come esito finale la morte: fra queste erano maggiormente temute il vaiolo, il morbillo, il colera. L’epidemia del Trecento è stata definita «grande peste» o «grande pestilenza» ma, poiché il colorito della persona diventa bruno a causa della comparsa di macchie scure e bluastre sia sulla cute sia sulle mucose degli ammalati, tale circostanza ha giustificato il termine di «peste nera» o «morte nera» all’epidemia che colpì l’Europa nel XIV secolo, datole dall’astronomo belga Simon de Couvin, nel 1450.
La peste nera ebbe le sue origini in Asia. Naviganti che provenivano dalla Cina e gettavano l’ancora nei porti del Mediterraneo riportavano che si era riscontrato un aumento della mortalità da un certo tempo, il che aveva messo in allarme tutta la popolazione del mondo conosciuto. Quindi, anche nella Penisola si iniziò ad avere una certa inquietudine a proposito. Un cronista fiorentino, Matteo Villani, che pure lui morì appestato, scrisse: «Cominciossi nelle parti d’Oriente, nel detto anno [era il 1346], in verso il Cattai e l’India superiore, e nelle province circumstanti a quelle marine dell’oceano, una pestilenzia tra gli uomini d’ogni condizione di ciascuna età e sesso, che cominciavano a sputare sangue, e morivano chi subito, chi in due o in tre dì. Questa pestilenzia si venne di tempo in tempo, e di gente in gente apprendendo, infra il termine d’uno anno la terza parte del mondo che si chiama Asia. E nell’ultimo di questo tempo, s’aggiunge alle nazioni del Mare Maggiore [Mar Nero], e alle ripe del Mare Tirreno, nella Soria [Siria] e Turchia, e in verso lo Egitto e la riviera del Mar Rosso, e dalla parte settentrionale la Rossia [Russia] e la Grecia, e l’Erminia [Armenia] e l’altre conseguenti provincie…!»
Dell’origine di quella peste (perché furono tante, dal XIV al XVIII secolo, le epidemie che colpirono l’Europa) non si hanno notizie certe, anche se tanti sono coloro che hanno lasciato scritti in proposito. Forse, i primi contagi si sono verificati nell’Himalaya e risalgono al 1332; comunque, è certo che essa giunse dall’Asia, forse dal Catai, forse dal deserto di Gobi, come raccontavano i viaggiatori da là provenienti, che parlavano di tantissimi morti e delle possibili cause che erano più che altro frutto dell’ignoranza e della superstizione: realtà e fantasia andavano a braccetto. Sicuramente lo sviluppo commerciale, che si riscontrò sotto la dominazione mongola, fu una delle cause principali che fecero diffondere la peste verso l’Europa a causa della mobilità di uomini, di animali e, ovviamente, delle pulci al loro seguito. Nel 1347, la peste si era avvicinata, espandendosi alla Turchia e raggiungendo i porti del Mediterraneo Orientale. Ognuno di questi divenne l’origine per la diffusione della peste in Europa.
Nel periodo antecedente lo scoppio della peste, la popolazione europea era in seria difficoltà. Le carestie che l’avevano colpita, soprattutto per un anomalo abbassamento della temperatura, che aveva causato una drastica diminuzione di prodotti agricoli, comportarono malnutrizione e fame; l’indebolimento e le scarse risorse fisiche, associate alle scarse condizioni di igienicità, causarono una rapida e tragica diffusione dell’epidemia con il conseguente calo demografico.
Nel 1347, la città di Caffa (oggi Feodosia), importante scalo commerciale di Genova della penisola di Crimea, era sotto assedio da parte del Khan Tartaro Gani Bek, il quale, per porvi fine, fece gettare all’interno delle mura cadaveri di appestati: si trattò di un atto di guerra batteriologica «ante litteram». Nell’ottobre di quell’anno, diverse navi partite da quella città giunsero in Sicilia, nei cui porti gettarono le ancore; di queste, dodici galee veneziane attraccarono al porto di Messina. I loro marinai, pur avendo portato in salvo la pelle, erano stati contagiati, tanto è vero che le cronache del tempo riportano che, non appena essi misero piede a terra, gli isolani iniziarono a morire. Quei marinai, sicuramente di robusta costituzione essendo riusciti a giungere fino lì, forse vissero ancora solo per qualche giorno dopo il loro sbarco, ma questo lasso di tempo fu più che sufficiente per contagiare migliaia di persone. Insomma, l’epidemia colpì l’Italia nel secolo XIV e si espanse a macchia d’olio in tutta l’Europa. Con i giusti mezzi, la peste può essere affrontata e debellata, ma allora mancavano sia la conoscenza sia i conseguenti mezzi adeguati, per cui la mortalità possibile era compresa fra il 50 e il 100% per cento della popolazione.
Nel 1353, finalmente, la malattia che aveva infettato l’intera Europa spense piano piano tutti i suoi focolai e scomparve definitivamente, in attesa di ricomparire più tardi. L’amara e dolorosa conclusione fu che, sui circa 60 milioni di abitanti, almeno un terzo soccombette.
Oggi, con i mezzi che sono messi a disposizione della sanità, è possibile individuare le cause di tante malattie: secondo l’eziologia, cioè la scienza che si preoccupa di individuare le cause del verificarsi di un certo fenomeno, l’agente ritenuto il portatore della peste nera è il bacillo «Yersinia pestis», trasmesso all’uomo dai ratti e dai topi tramite le pulci. Questo bacillo è stato isolato già alla fine dell’Ottocento. Una volta giunto sull’uomo, penetra attraverso la cute e si insedia nei linfonodi, che si ingrossano formando i cosiddetti «bubboni», da cui «peste bubbonica», e talora raggiunge la circolazione del sangue e i polmoni; comunque i danni sono tanto gravi da causare la morte nel giro di pochi giorni. Non esiste un vaccino contro la peste, pertanto non è possibile agire preventivamente, però ci sono i mezzi per individuarne i sintomi e per agire immediatamente di conseguenza.
E come si opponevano i medici (gli istituti sanitari furono fondati in tempi successivi) alla tragica situazione? Nel XIV secolo, i medici erano digiuni delle conoscenze essenziali per identificare le cause delle malattie gravi, tanto che non di rado le attribuivano a significati religiosi, per cui i possibili rimedi alle malattie con esito quasi sempre letale erano del tutto aleatori. La peste era misteriosa, anche perché la loro formazione professionale si basava soprattutto su studi di carattere filosofico. Pertanto, l’unica possibilità disponibile di affrontare la malattia era quella di fare riferimento alle teorie mediche antiche, che risalivano a Ippocrate e Galeno. Allora non si pensava assolutamente che la malattia potesse essere trasmessa da animale a uomo o da uomo a uomo. Per giustificare sia la velocità di diffusione della malattia, sia il numero delle persone colpite, si rifugiavano nelle parole di Ippocrate: «Allorché molti uomini son cólti da una sola malattia nello stesso tempo, occorre imputarne la causa a ciò che v’è di più comune e di cui tutti in primo luogo ci serviamo: e questo è ciò che respiriamo». Quindi, considerato che nella primavera del 1348 l’aria era piuttosto fredda e umida, secondo alcuni a causa di una cattiva congiunzione planetaria, i medici decretarono che quella fosse l’origine della peste. Molti autorevoli studiosi furono d’accordo su questa ipotesi, maggiormente suffragata dall’Università di Parigi, tanto da diventare il «credo» nel mondo dell’epoca. Altri pensarono alle cause più diverse: ritennero che l’epidemia fosse dovuta a fenomeni terrestri, quali il terremoto, l’attività vulcanica, il maremoto, perché essi sono tali da sconvolgere i quattro elementi fondamentali che sono acqua, aria, fuoco, terra. Qualcuno pensava che si trattasse di un castigo divino. La malattia, che per la maggior parte della gente era rapida e spietata, diede luogo a condotte sconsiderate e nevrotiche. Un esempio di isterismo collettivo si deve ai cosiddetti flagellanti, bande di penitenti che si spostavano lungo le vie delle città, infliggendosi dolorose flagellazioni, allo scopo di placare l’ira divina con la mortificazione di corpo e anima. Non mancarono coloro che accusarono gli Ebrei della malattia, quali avvelenatori dei pozzi d’acqua. E pure i lebbrosi non sfuggirono alle accuse.
Non c’era abitazione senza appestati e non si è a conoscenza di sopravvissuti tra i famigliari di contagiati. Tanti frati e sacerdoti, che si erano prodigati a portare la parola del Signore e a confessare gli ammalati, ne seguirono la sorte. I morti restavano per strada, tutti coloro che potevano scappavano, lasciando parenti e amici nel loro morbo e nella loro disperazione: l’amore e il rispetto per il prossimo erano scomparsi dai sentimenti umani. E con la fuga, il contagio raggiungeva anche coloro che erano stati risparmiati dall’epidemia, tanto che in molti posti furono allestite sorveglianze armate che respingevano dai confini stranieri e pellegrini, giungendo talvolta alla loro soppressione, per impedire il diffondersi della peste. Non è possibile raccontare tutte le altre forme di mancanza di umanità che sono state trasmesse da storici, scrittori, saggisti ai posteri, ma la paura e il cinismo furono i protagonisti di quell’immane calamità che colpì l’Europa nel XIV secolo.
In sostanza, rimedi non esistevano. C’era chi consigliava di fuggire dalla malattia, magari rifugiandosi nell’isolamento delle campagna (Boccaccio «docet»), suggerimento seguito da medici, nobili e gente ricca, che poteva permetterselo. Altri davano consigli sull’alimentazione e altri ancora proponevano le cure di Galeno, cioè salassi (che si riteneva potessero allontanare dal corpo umano gli «umori corrotti e putridi», insieme con la malattia) e purghe. Spesso i medici consigliavano fumigazioni con erbe aromatiche. A questo proposito si può ricordare che il Papa Clemente VI rimase isolato nei suoi appartamenti ad Avignone per tutto il tempo dell’epidemia, sempre circondato da falò accesi, e riuscì a scampare al pericolo di ammalarsi di peste. Con ogni probabilità, lo scampato pericolo è da attribuire al fatto che le pulci non amano il fuoco. Insomma, la conclusione non può essere che amara: niente di concreto era disponibile.
Quasi tutte – forse il «quasi» è di troppo – le persone che contraevano la malattia non avevano scampo e morivano in brevissimo tempo, tra uno e cinque giorni dal contagio, però dopo aver patito dolori strazianti. I loro ultimi momenti di vita erano terribili, con sintomi quali febbre alta, vomito e sanguinamento dai polmoni, accompagnati da dolorosi bubboni (macchie scure e livide) alle ascelle, all’inguine e al collo. La medicina di quell’epoca non era ancora una scienza in grado di fronteggiare una simile epidemia, e i metodi utilizzati dai medici erano discutibili, controversi e improbabili. La gente, disperata, si sottopose a tutti i tipi di cura, con la speranza che la guarisse. Alcuni di questi rimedi sembrano peggiori della stessa malattia. Ecco qualche esempio di questi metodi.
Per cominciare, si può ricordare la Tiriaca, che era una specie di beveraggio abbastanza disgustoso, ottenuto da varie miscele di melassa, vino, miele con erbe e carne di vipera, catturata in primavera, quando il veleno è più potente, e altro ancora. Era un medicinale noto fin dall’antichità, che andava bene per tutte le malattie (era un po’ come gli elisir che nell’Ottocento circolavano nel Far West, propagandati da furboni privi di scrupoli). Alla fine, però, l’unico risultato positivo, per qualcuno naturalmente, era che la Tiriaca costava un occhio, per cui era riservata alle famiglie più abbienti. Un altro metodo, non doloroso bensì disgustoso, era il salasso, noto fin dall’VIII secolo avanti Cristo, attuato con l’intervento delle sanguisughe. È indolore e sicuro, tanto che ancora oggi è messo in pratica in particolari situazioni. Nel periodo della peste nera, però, era molto costoso e non era alla portata di tutti, così chi non poteva permetterselo, si tagliava le vene, facendo uscire il sangue ritenuto eccedente. Il dolore era lancinante, ma il guaio peggiore era dovuto al ridotto rispetto delle norme igieniche, che rendeva possibili pericolose infezioni. Altra chicca fu il ricorso alla cura con lo smeraldo (sì, proprio lo smeraldo, la pietra preziosa). Logicamente, era una cura che poteva essere seguita solamente da una parte molto limitata della popolazione. Bastava sminuzzare lo smeraldo in un mortaio e berlo in un bicchiere d’acqua oppure mangiarlo mischiato al cibo. Sicuramente il berlo o mangiarlo era come mettere in bocca dei pezzetti di vetro o di pietra, ma se almeno fosse servito a qualcosa, ci si poteva adattare. Una modalità che era indubbiamente disgustosa (consiglio a chi ha lo stomaco debole di passare oltre), si basava sul taglio dei bubboni, ovunque essi fossero, per fare «venire fuori», insieme con il contenuto formato da un accumulo di sostanza emorragica e necrotica, anche la malattia. Poi, si coprivano le ferite con un miscuglio costituito da radici di fiori, resina e, perché no?, escrementi umani, e si bendava il tutto. L’unico risultato possibile, a parte il fetore, era un ampliamento della diffusione della peste. Altra metodologia (da considerare come la precedente, per i deboli di stomaco) era basata sull’uso dell’urina, sostanza nel Medioevo considerata come il toccasana capace di debellare tutti i mali del mondo. Infatti, fare il bagno nelle urine un paio di volte al giorno si riteneva fosse utile per affrontare la terribile malattia; ma il massimo consisteva nel berne un bicchiere o due al giorno. Tutto questo aveva resa l’urina non infetta talmente preziosa che la si raccoglieva e la si dava alle persone ammalate oppure, meglio, la si vendeva.
Non avendo nessuna possibilità di fermare e far regredire l’epidemia, gli amministratori delle varie città della Penisola nominarono commissari addetti alla salute pubblica, come per esempio a Firenze, Pistoia, Venezia, i quali operarono secondo ciò che era suggerito dal buon senso. Furono chiusi i mercati, fra l’altro. Spesso le abitazioni degli appestati furono sprangate con gli stessi dentro, tanto che molti morirono per fame e sete. Si proibì l’ingresso in città di gente che proveniva da zone sicuramente appestate. Navi provenienti da aree infette non potevano entrare a Ragusa, se non fossero passati trenta giorni, mentre per chi proveniva da terra, i giorni dovevano essere quaranta, perché, secondo Ippocrate, se la malattia fosse scoppiata dopo tale periodo, non poteva essere peste. In tutte le città, si impose di non avere nessun contatto con i morti, che dovevano essere eliminati con il fuoco o con la sepoltura insieme con tutti i loro averi.
Come ricordato più sopra, nel 1353 finalmente la peste nera, che aveva infettato e messa in ginocchio l’intera Europa, scomparve. Il risultato fu che non meno di un terzo dell’intera popolazione soccombette; ma i numeri esatti non furono mai disponibili. Però, come si dice, non era finita lì, perché riapparve periodicamente fino al XVIII secolo.
Ma perché scoppia la peste nera e perché ricompare? Per concludere questa nota, sembra giusto fare qualche considerazione in merito. Dunque, la peste nera, secondo la documentazione tramandataci da scrittori, saggisti e osservatori dell’epoca e successivi, era causata dai ratti e dai topi, che la trasmettevano all’uomo, attraverso le pulci che alloggiavano sulle loro pellicce. Ebbene, studi eseguiti congiuntamente dalle Università di Ferrara e di Oslo, hanno portato alla conclusione che la peste nera non era dovuta ai parassiti infetti che popolavano le pellicce di topi e ratti, bensì alle pulci e ai pidocchi che si annidavano sul corpo umano, grazie alle scarse condizioni igieniche in cui da secoli vivevano le popolazioni. Del resto, basta vedere come era l’igiene nel passato per renderci conto che la supposizione non sia per nulla azzardata. Con ogni probabilità, l’attesa di vita della gente era molto limitata anche perché le condizioni igieniche non permettevano di evitare tantissime malattie che, se opportunamente affrontate, potevano essere non mortali.
Per quel che riguarda il cielo aperto, l’ambiente di vita era al di fuori di ogni possibile concetto di pulizia, con le reti fognarie sconosciute e le strade percorse da rivoli di acque, che oggi si definiscono nere per non usare termini più appropriati alla loro natura, spesso gettate dalle finestre con grande disappunto da parte degli sprovveduti passanti. Per superarle, si saltavano o si usavano stivali; chi poteva passava in carrozza, lasciando poi il compito della pulizia agli stallieri; qualcuno usava addirittura i trampoli. Se da un lato le città praticamente erano prive di cure igieniche, dall’altro l’igiene personale non godeva di alcuna considerazione. In effetti, i medici erano contrari al bagno perché, secondo loro, era causa di un indebolimento del fisico, mentre la religione era dell’avviso che il toccarsi poteva provocare un’eccitazione dei sensi: in definitiva, era meglio non lavarsi. La storia riporta che i Romani avessero delle bellissime terme (del resto ne sono la testimonianza i ruderi tuttora esistenti) dove ci si poteva ritemprare il fisico dalle fatiche del lavoro o della guerra. Ma ci pensarono le orde di barbari, con le loro scorrerie nel territorio nazionale, a far ritornare le condizioni igienico-sanitarie allo «statu quo ante»: quello che l’Impero Romano aveva faticosamente costruito era annientato, vilipeso, beffato e, come se ciò non bastasse, si aggiunse pure la Chiesa, che si opponeva al bagno, perché considerava la mescolanza dei sessi fonte di depravazione, mentre da parte dei medici la giustificazione a dir poco lascia perplessi: infatti, c’era la convinzione che i pori della pelle fossero le vie d’ingresso delle malattie nel corpo umano, per cui non solo non si doveva eliminare lo sporco, ma pure si doveva fare il possibile affinché esso otturasse i pori, magari incrementandolo. Parlando del Re Sole (e il Medioevo era già nel passato) si riporta che fece il bagno una o al massimo due volte nella sua vita, che durò 77 anni: il che è tutto dire. E i vestiti? Lavati no, anzi servivano per togliere di dosso parte dello sporco che ricopriva il corpo, strofinandolo. E gli odori che si mettevano in giro? Erano in circolazione certe essenze profumate di improbabile composizione per la loro scelta. Interessante il comportamento in mancanza di igiene orale: era consuetudine da parte delle dame quella di usare un ventaglio sia per non mandare miasmi contro la persona che era di fronte, sia per nascondere le dentature cariate che esibivano. A ultimo, non è male aggiungere una curiosità conclusiva, che vale un perù (cioè, un tesoro). Talvolta poteva essere possibile per le famiglie fare un bagno, usando, però, sempre la stessa acqua. Ebbene, la precedenza era riservata al capofamiglia, seguito dai figli maschi, poi dalle donne e, infine, dai bambini. Se c’erano neonati, questi erano gli ultimi. A quel punto l’acqua era talmente sozza, che se un neonato fosse finito completamente immerso, non vedendolo, si correva il rischio di «buttarlo insieme con l’acqua sporca». Ecco l’episodio che ha dato origine al detto che, si deve riconoscere, è ben appropriato.