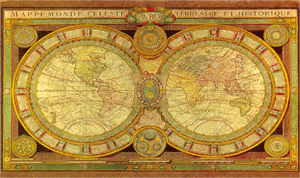Giuseppe Garibaldi era socialista?
Politici e studiosi hanno attribuito al
nostro eroe posizioni politiche diverse
Giuseppe Garibaldi, diversamente da altri grandi personaggi del Risorgimento non era di estrazione borghese ed è stato l’uomo che ha maggiormente coinvolto gli uomini delle classi popolari nell’azione politica senza comunque dare sostegno a movimenti politici in contrasto con le classi superiori. Garibaldi negli anni successivi alla sua morte è stato adoperato da gruppi politici diversi, in particolare possiamo ricordare il Fronte Popolare che nel 1948 lo scelse come proprio simbolo elettorale. La sua vita tumultuosa e le sue prese di posizione a volte atipiche hanno creato incertezza fra gli storici per la sua collocazione.
Lo storico socialista Giampiero Carocci riteneva che Garibaldi fosse monarchico popolare, altri fra i quali Giorgio Spini lo hanno ritenuto un socialista moderato, per l’ex partigiano, storico e giurista Alessandro Galante Garrone era un democratico liberale. Giuseppe Galasso sottolineava come Garibaldi avesse portato dalla sua parte i contadini ma anche i proprietari terrieri ed infatti Antonio Gramsci accuserà Garibaldi di aver favorito gli industriali del Nord e di aver trascurato la questione contadina al Sud. Garibaldi, secondo Francesco De Sanctis era un pragmatico, amava le idee semplici, ed agiva in maniera temeraria senza intraprendere particolari calcoli politici. La sua opinione è stata condivisa da molti altri studiosi che lo hanno definito semplicemente come un politico aperto alla questione sociale. Sicuramente Garibaldi interessato a migliorare la difficile questione sociale italiana lo era stato, ma tale impegno era condiviso anche da uomini della destra come il cavouriano Stefano Jacini, il deputato ed economista Leopoldo Franchetti, lo studioso e politico Pasquale Villari, il Ministro Sidney Sonnino, lo studioso meridionalista Giustino Fortunato.
La prima iniziativa politica intrapresa da Garibaldi fu l’adesione alla «Giovine Italia» e la partecipazione al moto antisabaudo del 1834 organizzato da Giuseppe Mazzini. Dopo il suo clamoroso fallimento, per sfuggire alla condanna riparò in America Latina dove combatté a favore del Rio Grande do Sul contro l’Impero del Brasile, iniziativa che non aveva un grande significato politico e successivamente a favore degli Uruguayani contro lo spietato dittatore Rosas. Nel 1848 (amnistiato) ritornò in Italia con alcuni volontari per partecipare alla Prima Guerra d’Indipendenza sebbene non avesse in simpatia Mazzini in quanto ritenuto un dottrinario illuso, né Carlo Alberto dal quale come egli stesso racconta, venne accolto freddamente. Partecipò quindi alla difesa della Repubblica Romana e successivamente cercò di prestare aiuto a Venezia, ultima città in guerra con l’Austria. Costretto a riparare in Liguria subì un arresto ma importanti personalità della sinistra e della destra parlamentare ottennero la sua liberazione. Per un certo periodo ritornò nelle Americhe, ma cinque anni dopo fu di nuovo nel nostro Paese, dove pubblicamente si allontanò dalle posizioni di sinistra, si oppose alla spedizione e alla sollevazione dei contadini in Calabria promossa dal socialista Carlo Pisacane, per aderire alla Società Nazionale di Cavour diventandone vice presidente. Partecipò alla Seconda Guerra d’Indipendenza e successivamente intraprese quella che fu la sua più grande iniziativa, l’Impresa dei Mille. Interessante notare che in Sicilia pur prendendo alcune iniziative a favore dei ceti popolari (abolizione della tassa sul macinato e concessione di alcune terre demaniali ai combattenti) condannò duramente i contadini a Bronte che attentavano alla proprietà privata e avevano ucciso diversi proprietari terrieri ed infine va ricordato che si oppose solo parzialmente alle assegnazioni a singole aziende dei cosiddetti terreni destinati ad uso comune, questione che successivamente divenne una delle cause del brigantaggio. La sua grande impresa avvenne in nome di Vittorio Emanuele II col quale ebbe un intenso scambio epistolare dal quale emerge la sua ammirazione verso il Sovrano. Quando Napoli venne liberata presentò il nuovo Sovrano alla folla per acclamarlo. Rinunciò a qualsiasi incarico o titolo e come era nel suo carattere impulsivo, si ritirò immediatamente a Caprera.
Negli anni successivi si allontanò dai moderati mostrando insofferenza verso la classe politica, mentre la sua fama si accresceva a livello internazionale, apprezzato dal liberale Lord Palmerston, mentre il Presidente della Repubblica Abraham Lincoln richiese la sua partecipazione come generale nella lotta ai sudisti. Non meno importanti furono le numerose richieste dei circoli operai che richiedevano al generale di assumerne la presidenza. Subito dopo l’unificazione del Paese venne eletto deputato ma per un tempo brevissimo, contestò la cessione della sua città Nizza alla Francia, il mancato incorporamento dei suoi combattenti nell’esercito regolare e diede immediatamente le dimissioni. Nel 1862 si ebbe la riunificazione delle associazioni mazziniane e di quelle garibaldine nella Società Emancipatrice Italiana, il nuovo raggruppamento politico intendeva promuovere il suffragio universale e la liberazione di Roma e Venezia. Garibaldi ebbe un colloquio con il Re e il nuovo capo di governo Urbano Rattazzi il cui esatto contenuto non è noto ma si suppone che l’eroe ritenesse di essere autorizzato a intraprendere un’iniziativa per la liberazione di Roma. Nello stesso anno raccolse un certo numero di volontari in Sicilia, fra i quali vi furono numerosi preti, studenti, pittori, letterati, ma venne fermato dall’esercito regolare sull’Aspromonte, dove diede immediatamente ordine di cedere e non rispondere al fuoco. Fu ferito, arrestato e liberato poco dopo per l’intervento del Re.
Nel 1864 Garibaldi partecipò con Mazzini alla Associazione Internazionale dei Lavoratori, meglio conosciuta come Prima Internazionale. Mazzini e proudhoniani vennero immediatamente esclusi dal congresso per le loro posizioni contrarie alla lotta di classe violenta, Garibaldi non subì la stessa fine, ma non mostrò segni di simpatia verso i due leader emersi in quel consesso, Karl Marx e Michail Bakunin.
Successivamente riprese la sua attività all’interno della Massoneria, venne nominato nel 1864 grazie anche all’intervento di Francesco Crispi Gran Maestro del Grande Oriente Italia in un periodo in cui i socialisti non erano rappresentati nell’associazione. In tale veste cercò di riunificare la fratellanza che si era divisa in numerosi raggruppamenti. Nonostante il triste episodio dell’Aspromonte, nel maggio 1866 organizzò disciplinatamente il corpo volontari per la Terza Guerra di Indipendenza.
Molto interessanti per definire la personalità politica di Garibaldi, le sue proposte presentate nel settembre 1867 al Congresso internazionale di Ginevra per la Pace e la Libertà, un incontro in cui parteciparono grandi personalità come lo scrittore Victor Hugo e il filosofo liberale John Stuart Mill:
1. Tutte le nazioni sono sorelle.
2. La guerra tra di loro è impossibile.
3. Tutte le contese che sorgeranno tra le nazioni dovranno essere giudicate da un congresso.
4. I membri del congresso saranno nominati dalle società democratiche dei popoli.
5. Ciascun popolo avrà diritto di voto al congresso, qualunque sia il numero dei suoi membri.
6. Il Papato, essendo la più nociva delle sette, è dichiarato decaduto.
7. La religione di Dio è adottata dal congresso e ciascuno dei suoi membri si obbliga a propagarla.
8. Supplire il sacerdozio delle rivelazioni e della ignoranza col sacerdozio della scienza e della intelligenza.
9. Propaganda della religione di Dio, attraverso l’istruzione, l’educazione e la virtù.
10. La repubblica è la sola forma di governo degna di un popolo libero.
11. La democrazia sola può rimediare ai flagelli della guerra.
12. Lo schiavo solo ha il diritto di far la guerra al tiranno.
La partecipazione al Congresso non distrasse l’eroe dal proposito, realizzato subito dopo la sua conclusione, ad una azione armata per la liberazione di Roma. Venne arrestato una prima volta a Sinalunga (nonostante le proteste di 25 deputati), riprese il tentativo, ma vedendo che i Romani non avevano dato vita ad un’insurrezione interna dovette desistere.
Nel 1871 il Generale partecipò alla sua ultima azione militare, prendendo parte alla guerra franco-prussiana, in difesa della neonata Repubblica Francese, sorta dopo la sconfitta di Napoleone III. Non partecipò alla Comune di Parigi (duramente condannata da Mazzini), ma espresse stima per l’ardore dei Parigini. Venne eletto all’Assemblea Francese nella lista dei radicali dove si espresse a favore del ritorno di Nizza all’Italia, respinta la richiesta diede immediatamente le dimissioni.
Negli anni successivi alla costituzione dell’Internazionale, la principale organizzazione operaia nel nostro Paese era data dal Patto di fratellanza tra le Società operaie di mutuo soccorso costituito da Mazzini, ma si profilava la nascita di movimenti più estremisti. Nel 1872 alla Conferenza di Rimini delle associazioni italiane che partecipavano all’Internazionale, Garibaldi contestò le posizioni bakuniniane di una parte dei presenti senza ovviamente manifestare una qualche simpatia per il socialismo autoritario di Karl Marx che in precedenza si era espresso verso di lui con disprezzo.
Nello stesso anno Garibaldi partecipò al Congresso di Roma del gruppo che successivamente diede vita al partito radicale che si era posto come principale scopo il suffragio universale, l’istruzione laica e gratuita, il decentramento amministrativo, l’abolizione della tassa sul macinato, l’abolizione della pena di morte. Due anni dopo il nostro eroe venne rieletto alla Camera dove espose un progetto per la bonifica delle paludi dell’Agro Pontino e addirittura lo spostamento del corso del Tevere per evitare i periodici allagamenti della città di Roma, alla fine si concorderà per la realizzazione degli alti muraglioni per impedire lo straripamento del fiume.
Nonostante l’evidente spostamento verso la sinistra radicale parlamentare, il governo di destra Minghetti nel 1874 propose per i grandissimi servigi resi alla nazione una rendita annua di 50.000 lire a favore di Garibaldi, che con alcune titubanze accettò dichiarando che sarebbero serviti a migliorare la situazione del Tevere.
Nel 1879 Garibaldi, ormai gravemente infermo, partecipò alla costituzione della Lega della Democrazia insieme con altri esponenti democratici radicali come Felice Cavallotti e Agostino Bertani. Tale movimento riprendeva il programma del 1872 ma con alcuni punti più estremisti, l’abolizione del giuramento di fedeltà dei deputati alla monarchia, la laicizzazione dello Stato, la confisca e la distribuzione dei beni ecclesiastici. Fu il suo ultimo atto politico, tre anni dopo sopraggiunse la morte nell’«eremo» di Caprera.
Garibaldi, come egli stesso scrisse, non era un grande amante degli studi, ci ha lasciato comunque alcune opere letterarie, interessanti per la comprensione della sua personalità. Nelle sue Memorie si definisce «repubblicano quindi, essendo questo il sistema della gente onesta, sistema normale voluto dai più, e per conseguenza non imposto colla violenza e coll’impostura. Tollerante, non esclusivista, non capace d’imporre per forza il mio repubblicanesimo». In un’altra sua opera, Ricordi e Pensieri, l’autore si esprime a favore dei governi liberali: «La Repubblica Svizzera — e la Monarchia Inglese — rappresentano il bene — non il bene perfetto — perché questo pare non conciliarsi colla natura umana — ma quel tanto di bene che tiene l’individuo nella sua dignità — e che lo mette in caso di dire: — Il Governo è cosa mia — non io cosa del Governo», tuttavia nella stessa opera afferma: «Il mio convincimento circa al bene d’una Dittatura elettiva, data da molto più tempo... ma per Dittatore si vuole un uomo onesto». In altri scritti minori, sempre molto coloriti, insiste molto sull’opera nefasta del clero in generale e mostra attenzione alla situazione degli operai senza comunque esprimersi contro le classi borghesi. In una lettera diretta alla Società Operaia di Genova del 1863, scrive: «Lavoro, Patria, Libertà: ecco il programma vostro, operai, e di tutti gli uomini che non credono creato il mondo per satollare la loro ingordigia e la loro ambizione» e in due missive del 1871 si espresse sulla Comune di Parigi e sulla Prima Internazionale, nella prima diretta al direttore del giornale «La Roma del Popolo» Giuseppe Petroni scrisse: «Io desidero non succeda all’Internazionale, come al popolo di Parigi, cioè di lasciarsi sopraffare dagli spacciatori di dottrine onde essere spinti a delle esagerazioni, e finalmente al ridicolo; ma che studi essa bene gli uomini, che devono condurla sul sentiero del miglioramento morale e materiale, prima d’affidarvisi... Si contenti l’Internazionale di ciò che è diritto per lei, senza toccare alla proprietà e alla eredità degli altri», nella seconda lettera diretta al marchese Giorgio Pallavicino afferma: «E se avessi saputo in febbraio, quando lasciai l’Assemblea di Bordeaux, ciocché in marzo doveva aver luogo a Parigi, io certamente mi sarei recato in quella capitale per propugnarvi la causa della giustizia traviata dai soliti dottrinari... Io non tollero all’Internazionale, come non tollero alla monarchia, le sue velleità antropofaghe. E così come manderei in galera chi studia tutta la vita il modo di estorcere la sussistenza agli affamati per pascere grassamente i Vescovi, io vi manderei pure gli archimandriti [capi congregazione, nota dell’Autore] della Società in quistione, quando questi si ostinassero nei precetti: guerra al capitale; la proprietà è un furto; l’eredità è un altro furto, e via dicendo».