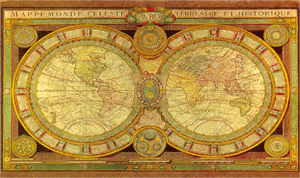Le vicende della Terza Guerra d’Indipendenza
Cronaca di una vittoria mancata, e delle
ragioni per cui non arrise all’Italia
Nel 1866, ancora una volta, l’Italia si trovò in guerra contro l’Austria: obiettivo erano le tre Venezie, oltre ai territori istriani e dalmati già colonizzati dalla Serenissima e in cui vivevano significative aliquote di Italiani (che in Istria, per esempio, superavano il 75% della popolazione). Non potendo affrontare da solo l’imperiale esercito austriaco, il Regno d’Italia si alleò con la Prussia: questo Stato era in disaccordo con gli Asburgo d’Austria, ai quali ambiva strappare il predominio sulla Confederazione Germanica. Il patto d’amicizia italo-prussiano fu concluso l’8 aprile 1866: si stabiliva che Italia e Prussia avrebbero combattuto insieme contro l’Austria e, in caso di vittoria, all’Italia sarebbe spettato il Veneto.
Saputo di questa manovra, l’Austria tentò di mandare a monte l’alleanza offrendo il Veneto all’Italia, con la mediazione di Napoleone III, purché questa annullasse gli accordi con la Prussia. Ma il Governo di Roma, per mantenersi fedele ai patti conclusi, rigettò l’offerta e il 20 giugno scese in armi contro l’Austria a fianco dell’alleato, che aveva dichiarato la guerra quattro giorni prima. L’esercito italiano comprendeva 200.000 uomini (di cui solo la metà aveva ricevuto un addestramento adeguato), quello austriaco ne aveva schierati sul fronte italiano 75.000.
La mattina del 24 giugno 1866 la campana della parrocchia di Villafranca, in quel di Custoza, aveva da poco scandito le sette e mezzo quando si alzò dalla strada, fra i filari di gelso, un fittissimo polverone. Era l’annuncio che un forte contingente di soldati austriaci stava avanzando: ben quattro squadroni di Ulani, i famosi lanceri polacchi, al comando del colonnello Rodakowski, galoppavano a briglia sciolta contro le truppe italiane, comandate da Umberto, figlio del Re Vittorio Emanuele II. Il principe di Savoia non si perse d’animo: ordinò ai suoi uomini di disporsi in quadrato per opporre una selva di baionette che arrestasse l’impeto della cavalleria nemica. Gli Ulani erano sempre più vicini; non frenavano la loro corsa né i filari degli alberi, né gli ampi fossati, né il fuoco dei bersaglieri stesi a catena sui fianchi.
L’urto fra le schiere fu tremendo e subito i morti si accumularono gli uni sugli altri; anche il principe venne ferito, ma continuò a dirigere il combattimento ed il suo coraggio riempì d’entusiasmo gli Italiani, che resistettero a pie’ fermo all’impeto della cavalleria.

Juliusz Kossak, Il 13° Reggimento degli Ulani Austro-Ungarici del Colonnello Rodakowski attacca i Bersaglieri Italiani alla Battaglia di Custoza del 1866,
1868
Dopo due di queste cariche gli Ulani, da 600 che erano, si ridussero a soli 200. Allora compresero che non sarebbero mai riusciti ad infrangere quel quadrato di uomini comandati dal figlio del Re, rinunciarono all’impresa e si ritirarono inseguiti da due squadroni della cavalleria italiana.
Tuttavia, nonostante questo ed altri episodi di valore, la battaglia di Custoza fu sfavorevole nei confronti dell’esercito d’Italia, non per la viltà dei soldati (che si batterono benissimo), ma per la mancanza di organizzazione e per l’imperizia mostrata dallo Stato Maggiore. L’esercito era stato infatti diviso in due parti, una affidata al capo di Stato Maggiore Alfonso Lamarmora (sul Mincio), l’altra al Generale Cialdini (sul basso Po), due uomini che si detestavano a vicenda: il risultato fu che questi due contingenti di forze non riuscirono mai ad agire con un comune piano d’azione, ed oltretutto l’esercito del Lamarmora non costituì un corpo unico col quale opporsi al nemico, ma si frantumò in piccoli nuclei ognuno dei quali combatté una battaglia isolata. Gli Austriaci ebbero 1.200 morti, gli Italiani poco più della metà, ma furono questi ultimi ad abbandonare il campo.
Dopo i fatti di Custoza, l’Italia passò un momento drammatico. L’Austria aveva disposto di ritirare tutte le sue truppe dal Veneto per bloccare l’esercito prussiano che scendeva dal Settentrione e gli Italiani, se non volevano essere considerati dall’alleato degli inetti o addirittura dei traditori, dovevano assolutamente impedire al nemico questa manovra tagliandogli la ritirata e costringendolo ad un secondo scontro.
Il capo del Governo, Ricasoli, telegrafò al Generale Cialdini per informarlo della situazione diplomatica in cui si trovava il Paese:
«FIRENZE 1° LUGLIO 1866
AL GENERALE CIALDINI.
LE COMUNICO COSA DI GRANDE RILIEVO E CHE MI TIENE AGITATISSIMO. GLI AUSTRIACI ABBANDONANO L’ITALIA E VANNO A RINFORZARE L’ARMATA DEL NORD PER RESISTERE CONTRO I PRUSSIANI. SE NON SI IMPEDISCE A QUALUNQUE COSTO E SUBITO UNA TAL COSA, L’ITALIA SARÀ CHIAMATA IN MALA FEDE E DISONORATA, E INFINE LE CONDIZIONI DI PACE SARANNO PEGGIORI. PREGOLA PENETRARSI DI QUESTO FATTO E FARE OGNI POSSIBILE PER TAGLIARE LA RITIRATA AGLI AUSTRIACI».
Un altro telegramma venne inviato con lo stesso scopo all’Ammiraglio Carlo Persano, capo della flotta sull’Adriatico:
«FIRENZE 15 LUGLIO 1866
ALL’AMMIRAGLIO.
È FATALE CHE ENTRO UNA SETTIMANA SIA DISTRUTTA LA FLOTTA NEMICA O OCCUPATA L’ISTRIA».
Così il 18 luglio la flotta italiana salpò dal porto di Ancona per attaccare di sorpresa l’isola di Lissa, che gli Austriaci avevano munito di formidabili fortezze ed attrezzato con un centinaio di cannoni. L’incarico del primo attacco venne affidato al Saint-Bon, un abile e coraggioso ufficiale di marina. Al comando della corazzata Formidabile, si diresse decisamente verso il porto di Lissa; alla vista della nave italiana, gli Austriaci aprirono immediatamente il fuoco, ma Saint-Bon rimase a dirigere il combattimento ritto sul ponte di comando, incurante dei colpi nemici. La battaglia tra le batterie austriache del porto e la corazzata italiana infuriò per tutta la giornata; verso sera, sebbene danneggiata in modo grave, la Formidabile poteva riunirsi al grosso della flotta, dopo aver messo fuori combattimento molte batterie nemiche. La mattina del 20 luglio, mentre l’attacco all’isola era in pieno sviluppo, sopraggiunse la flotta austriaca comandata dall’abile ed audace Ammiraglio Guglielmo Tegetthoff.
Di Persano si è parlato molto, e male: aveva fatto carriera per convenienze politiche anziché per meriti reali, era aspro coi sottoposti, arrendevole fino al servilismo coi superiori, irresoluto, riteneva che possedere una flotta fosse di per sé sufficiente per tenere in soggezione il nemico, non sapeva nuotare e perciò teneva sempre accanto a sé due nerboruti marinai col compito di tenerlo a galla qualora la nave sulla quale era imbarcato fosse colata a picco. Però bisogna dire anche che fu lui a dotare la flotta di moderne navi in ferro e ad istituire l’Accademia Navale di Livorno, rimasta ancora oggi la più seria scuola militare italiana (ed una delle migliori al mondo). Il Tegetthoff era l’esatto contrario: del tutto digiuno di politica, aveva trascorso l’intera sua vita sul mare e tra i marinai, sui quali esercitava un indiscusso prestigio; i suoi equipaggi erano formati da uomini della Serenissima, Italiani del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia, ai quali gli ordini venivano impartiti in lingua veneta. La stessa flotta austriaca aveva il nome di «Imperial Veneta Marina».
Le prime ad attaccare battaglia furono le corazzate italiane Principe di Carignano, Castelfidardo ed Ancona comandate dall’Ammiraglio Vacca: il loro compito era quello di scompaginare lo schieramento delle navi nemiche. Queste però, sotto la direzione di Tegetthoff, schierandosi a cuneo non solo sfuggirono facilmente ai colpi avversari, ma riuscirono persino a superare le prima linea dello schieramento italiano. In poco tempo la situazione si era capovolta: con una manovra impeccabile, erano ora le navi austriache a muovere all’assalto. L’Ammiraglio Tegetthoff aveva in mente un piano ben preciso: porre fuori combattimento le migliori corazzate italiane. La nave ammiraglia Re d’Italia venne assalita da tre corazzate nemiche; il suo comandante, Emilio Faà di Bruno, si difese strenuamente e per parecchie ore riuscì a far fronte all’incessante fuoco nemico; infine, colpita in più parti e speronata dalla nave ammiraglia austriaca Ferdinando Max, la Re d’Italia cominciò ad affondare. Il comandante Faà di Bruno non volle sopravvivere alla sua nave e, prima ancora che la corazzata s’inabissasse, si uccise con un colpo di pistola.

Carl Frederik Sørensen, Battaglia navale a Lissa, 1868, Museo di Storia Militare, Vienna (Austria)
La battaglia continuava ad infuriare: la San Martino e la Palestro, altre due grosse corazzate italiane, vennero assalite da quattro navi nemiche. Ad un certo momento, tre di queste concentrarono i loro colpi sulla Palestro; lo scoppio di una granata nemica provocò un incendio a poppa della nave, ma il comandante Alfredo Cappellini continuò a difendersi con coraggio, mentre le navi austriache non cessavano di tempestare di colpi la corazzata italiana.
«Presto, salvatevi!» gridò Alfredo Cappellini ai suoi marinai. «Io voglio inabissarmi con la mia nave in fiamme!».
«E noi vi seguiremo!» rispose urlando l’intero equipaggio.
«Avanti, allora! Viva l’Italia!» rispose il comandante, dando ordine di dirigere la nave a tutta velocità contro il nemico. Ma con un tremendo boato l’incendio, giunto ormai alle polveri, fece saltare in aria la nave col suo equipaggio di 300 uomini.
Alle tre del pomeriggio la battaglia volse al termine: l’Ammiraglio Tegetthoff, soddisfatto dell’esito del combattimento, ritirò la sua flotta nel canale di Lesina. Gli equipaggi lanciarono in aria i cappelli levando il grido d’esultanza della Serenissima, «Viva San Marco!», mentre il Tegetthoff commentò che «uomini di ferro su navi di legno avevano avuto ragione di uomini di legno su navi di ferro». I più animosi comandanti italiani chiesero di tentare subito una rivincita: possedevano tuttora un numero superiore di forze. Ma l’Ammiraglio Persano non era di questa idea ed ordinò alla flotta di far ritorno nelle acque di Ancona: in seguito, ritenuto colpevole di essersi lasciata sfuggire l’occasione della rivincita, fu deposto dal comando per inettitudine.
Nel frattempo l’esercito prussiano, comandato dal Generale Bernhard von Moltke, aveva sbaragliato quello austriaco a Sadowa, in Boemia, con una memorabile battaglia manovrata (3 luglio 1866), impressionando il mondo con una dimostrazione di grande potenza. Moltke si spinse fino a 15 chilometri da Vienna; dopo una tale vittoria il Governo Prussiano, senza interpellare l’Italia, concluse a Nikolsburg un armistizio con l’Austria.
Tutta un’altra musica sul fronte alpino, dove operava Giuseppe Garibaldi, a cui era stato affidato dal Re un corpo di volontari male armati e poco addestrati: egli affrontò l’esercito imperiale che era formato dalle migliori truppe austriache, i Kaiserjaeger, comandate dal miglior Generale, il Kühn. Dopo aver strappato al nemico alcune importanti posizioni come Monte Suello e il ponte sul Caffaro con aspri assalti all’arma bianca, Garibaldi colse la vittoria decisiva a Bezzecca (21 luglio), e mosse direttamente verso Trento. Per appoggiare la sua azione era stata distaccata in Val Sugana la 15a divisione agli ordini del Generale Medici, mentre il Generale Raffaele Cadorna (padre di Luigi), col V Corpo, avanzava verso Trieste. Giunto a 10 chilometri da Trento, Garibaldi ricevette il telegramma che lo avvertiva che le ostilità con l’Austria erano cessate. La giornalista inglese Jessie White scrisse di aver visto «rompere spade, spezzare baionette, molti gettarsi a terra e ravvoltarsi nelle zolle ancora inzuppate del sangue dei fratelli», mentre Garibaldi con molto dolore, ma con altrettanto senso di disciplina, telegrafò laconico al Re: «Ho ricevuto dispaccio 1072. Obbedisco».

Felice Zennaro, Battaglia di Bezzeca, 21 Luglio 1866, circa 1867
Cadorna aveva intanto raggiunto il Tagliamento, l’aveva attraversato su ponti di barche e si era spinto fino all’Isonzo. Era passato da poco il mezzogiorno del 26 luglio 1866, quando nei pressi del vecchio ponte in legno sul torrente Torre, a Versa (oggi frazione di Romans d’Isonzo), veniva combattuta l’ultima battaglia tra Italiani (guidati dal Generale La Forest-Divonne) ed Austriaci. Nello scontro furono coinvolti, da parte italiana, cinque squadroni del Reggimento Lancieri di Firenze (circa 400 cavalieri), 14 compagnie di bersaglieri (1.600 uomini), e la 5a batteria dell’8° Reggimento d’artiglieria con sei pezzi, mentre da parte austriaca due squadroni e mezzo del reggimento Ussari Wurttemberg (300 cavalieri), 18 compagnie dei Reggimenti Arciduca Luigi Vittorio, Nagy e Granduca di Toscana (2.500 uomini) e una sezione della 7a batteria del 7° Reggimento d’artiglieria con due pezzi. Quando cessò il fuoco si contarono 7 morti e 29 feriti da parte italiana, 30 morti e 51 feriti da parte austriaca. Più a Nord, folle esultanti accoglievano la 14a Divisione italiana che entrava in Udine.
La pace definitiva venne siglata a Vienna il 3 ottobre 1866: essa concedeva alla Prussia il predominio sugli Stati Germanici e stabiliva che il Veneto fosse ceduto a Napoleone, che l’avrebbe poi gentilmente donato all’Italia. Invece il Trentino, la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia rimanevano ancora in possesso dell’Austria; da qualsiasi parte della pianura veneta gli Italiani avessero sollevato lo sguardo, avrebbero scorto i soldati asburgici in posizione dominante.

L'entrata di Vittorio Emanuele II a Venezia avvenuta il 7 novembre 1866 in un quadro dell'epoca