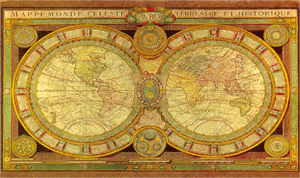Pasqua, l’isola dei misteri
Storia di una terra affascinante e
misteriosa, sede di un’antica civiltà che non ha eguali nel
resto del mondo
Situata nell’immensità dell’Oceano Pacifico, 3.750 chilometri al largo delle coste cilene, minuscola e solitaria si trova Rapa Nui, più conosciuta come Isola di Pasqua. Un arido lembo di terra a forma di mandorla lungo 25 chilometri e largo 10 nel punto di maggior ampiezza, con la superficie di 164 chilometri quadrati, spazzato da forti venti, con coste scoscese; sembra uno scoglio lasciato cadere nel mare da una divinità annoiata, all’inizio della Creazione. Attorno si trovano poche altre isolette, del tutto disabitate. Eppure, questa terra lontanissima da tutto e da tutti, rimasta isolata per secoli, dal giorno della sua scoperta a opera degli Europei ha costituito, per etnologi e archeologi, un appassionante intrico di misteri, che soltanto di recente hanno in parte cominciato a svelarsi.
L’isola nacque mezzo milione di anni fa nella lava ribollente di tre vulcani, ormai spenti e occupati da tre laghi (uniche fonti d’acqua potabile). Uno di questi raggiunge i 538 metri sul livello del mare.
Le radici del suo popolo affondano nelle ere dei miti e delle leggende; sarebbe stata occupata, tra il X e il XIII secolo, da un tale Hotu-Matua e dalla sua gente, provenienti dalle Isole Marchesi o da Mangareva; si trattava di poche decine di individui, che avevano navigato per settimane in canoe scoperte. Da loro, questa terra di sassi bruciati dal sole, fresca di giorno e fredda di notte, fu chiamata Rapa Nui o anche Te Pito, o Te Henua («Ombelico del Mondo»). Gli Europei avvistarono Rapa Nui la prima volta nel 1686 o nel 1687 per merito del bucaniere inglese Edward Davis; l’Olandese J. Roggeveen vi approdò nella domenica di Pasqua del 1722, dandole così il nome di Isola di Pasqua con cui è universalmente conosciuta.
Roggeveen trovò in quella minuscola terra due diversi popoli: l’uno era formato da individui di statura alta e pelle chiara; uomini e donne si allungavano stranamente i lobi delle orecchie forandoli e introducendovi dei grossi pesi, ed erano perciò chiamati «orecchie lunghe». L’altro popolo era più basso e aveva la pelle bruna; era chiamato «orecchie corte». Ma quello che stupì gli Olandesi fu l’incredibile vista di centinaia di gigantesche sculture di pietra, i moai, sparse ovunque per l’isola, con le spalle al Pacifico: erano alte da uno a 10 metri, pesanti anche più di 80 tonnellate e ritraevano figure umane, dalla cintola in su, con testa allungata, naso lungo e appuntito, lobi auricolari allungati, braccia lungo i fianchi; per renderle più vive, nelle orbite vuote erano applicati occhi di corallo bianco e pupille di ossidiana o di scoria vulcanica rossa; sul capo delle più grandi era posto, quasi in equilibrio, un enorme masso di scoria vulcanica rossa, raffigurante un alto cappello («pukao»). Davanti a quelle statue il popolo delle «orecchie lunghe» accendeva dei fuochi e si inchinava in adorazione. Poiché gli abitanti dell’isola non disponevano che di piccoli e semplici attrezzi di pietra, simili a quelli degli uomini primitivi, senza animali da tiro né ruote, agli Olandesi riuscì inspiegabile come gli indigeni avessero potuto scolpire ed erigere quelle enormi statue.

Moai sul Rano Raraku, Isola di Pasqua (Cile)
Nel 1770 sbarcarono sull’isola gli Spagnoli, trovandola fittamente popolata; ma solo quattro anni più tardi, quando vi giunse Cook, essa era semideserta, e la venerazione per i giganti di pietra quasi del tutto scomparsa. Nel 1786, i Francesi di J.-F. La Pérouse la trovarono di nuovo popolosa, ma tutte le statue erano state abbattute e lasciate in abbandono. Che cosa era accaduto? Questo fu uno dei misteri che affascinarono il mondo. Un mistero alla cui soluzione non possono contribuire le uniche testimonianze di scrittura locale, delle tavolette lignee coperte di segni pittografici affini alle scritture di epoca eneolitica (3.000 avanti Cristo) di Mohenjo Daro e di Harappa, nella valle dell’Indo, cosa che ha fatto pensare a un’immigrazione anche da lì: perché questi segni, i rongo rongo, unico esempio di scrittura fra tutti i popoli dell’Oceania, rimangono tuttora indecifrati.
Le vicende dell’isola furono in parte chiarite nel 1955 dall’etnologo e avventuriero norvegese Thor Heyerdahl, il quale, recatosi laggiù, vi soggiornò a lungo interrogando gli indigeni ed esaminando minuziosamente i monumenti. Ecco come egli ha ricostruito la storia dell’isola.
I primi abitatori dell’Isola di Pasqua furono le «orecchie lunghe» giunte, secondo Heyerdahl (ma fu poi smentito), dal continente americano. Più tardi, forse solo un secolo prima dell’arrivo degli Europei, approdarono sull’isola le «orecchie corte» provenienti dalle isole della Polinesia. Le «orecchie lunghe» assoggettarono i nuovi arrivati, riducendoli al ruolo di schiavi. Poi li costrinsero al lavoro di scavo delle gigantesche statue, i moai, connesse al culto degli antenati. Heyerdahl pensava che i moai fossero un prodotto della civiltà preincaica peruviana, mentre oggi sappiamo che sono di origine polinesiana (lo scrittore svizzero Erich von Däniken era invece sicuro che le statue fossero state costruite da extraterrestri rimasti bloccati sulla Terra!). La roccia del vulcano Rano Raraku veniva tagliata e modellata battendola con asce di pietra dura, e la statua era staccata dalla roccia soltanto quando era ultimata in tutti i particolari, cosa a cui si giungeva dopo molti mesi di lavoro. Quando la statua era separata dal monte, veniva portata sul luogo ove doveva essere innalzata (distante a volte 18 chilometri) facendola «camminare»: la grossa pancia proiettava il peso in avanti e la base curva, a forma di D, permetteva l’oscillazione da una parte all’altra. Gli archeologi Terry Hunt e Carl Lipo, nel 2011, hanno mostrato che tre gruppi di uomini sarebbero stati sufficienti a far avanzare un moai, due muovendolo in avanti facendolo oscillare sulla base e un terzo tenendolo in equilibrio; quell’anno, 18 persone fecero camminare per qualche centinaio di metri una copia alta tre metri e pesante cinque tonnellate. Nella tradizione orale, i moai sarebbero animati dal «mana», il potente spirito infuso dagli antenati. In queste ingegnose e febbrili attività trascorse il periodo più fiorente della civiltà dell’Isola di Pasqua.
Vi sono anche statuette più piccole, soprattutto di legno, che riproducono uomini dal corpo scheletrico e dal volto scarnificato dalla naturale denutrizione, con pendenti alle orecchie e barbette a punta; sono ritratti con le costole inferiori che sporgono sopra il ventre rientrante, le ampie occhiaie e alcuni hanno la testa di uccello o di lucertola. Le figure femminili sono più rare e schematiche, con volti più realistici e meno grotteschi di quelle maschili, e ce ne sono talune che mostrano nell’atteggiamento e nella postura delle incredibili affinità con la Nascita di Venere del Botticelli, sebbene non vi possa essere stata una conoscenza dell’opera.
Torniamo al racconto di Thor Heyerdahl. A un certo punto le «orecchie corte», stanche d’essere tenute in schiavitù e sottoposte a tali fatiche, si ribellarono ai dominatori. In una lunga guerra, combattuta con estrema ferocia nel breve spazio dell’isola, le «orecchie lunghe» furono tutte sterminate, tranne un unico superstite. Queste vicende sono raccontate in un bel film del 1994, Rapa Nui, diretto da Kevin Reynolds e tratto dal romanzo omonimo di Leonore Fleischer. Le «orecchie corte» abbatterono tutte le opere a cui avevano lavorato in schiavitù; tutte le statue che erano in lavorazione, centinaia, rimasero incompiute, ancora unite alla montagna, oppure abbandonate lungo il percorso: queste, col trascorrere dei secoli, rimasero semisepolte, cosicché oggi ne vediamo sporgere dal terreno solamente la testa.
All’uccisione delle «orecchie lunghe» non seguì la pace. Cominciò una guerriglia, durata per secoli, fra le diverse famiglie dei vincitori; poiché, date le ridotte dimensioni dell’isola, vivere all’aperto durante le guerre era troppo pericoloso, ogni famiglia si scavò un rifugio sotterraneo segreto nel quale trascorreva buona parte dell’esistenza. In queste condizioni era difficilissimo procurarsi il cibo, e si diffuse la pratica del cannibalismo. Queste caverne, formate da corridoi lunghi anche centinaia di metri, sono quindi oggi dei ricchi giacimenti di resti umani, sculture e graffiti; purtroppo, della maggioranza di esse nessuno può conoscere l’entrata, che gli antichi abitatori nascondevano con grandissima cura. L’esistenza di questi rifugi sotterranei ha spiegato perché, ad alcuni navigatori, l’isola apparisse quasi disabitata.
La storia dell’Isola di Pasqua e dei suoi moai è entrata di recente a far parte di un dibattito che riguarda non solo il suo passato ma l’intera umanità, la sua storia e soprattutto il suo futuro. Sono sorte quindi due teorie contrapposte e inconciliabili.
La prima è stata esposta dal premio Pulitzer Jared Diamond nel suo libro Collasso, ed è la parabola di una società che distrugge se stessa senza motivo, saccheggiando il proprio habitat, come rischia di fare l’uomo odierno. Diamond parte dalle scoperte fatte, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, dallo studioso di biogeografia John Flenley della Massey University, in Nuova Zelanda: il ritrovamento di pollini nei sedimenti lacustri dimostrava che l’isola era stata ricoperta per migliaia di anni da foreste lussureggianti, con milioni di palme giganti. Solo dopo l’arrivo dei Polinesiani, attorno all’800 dopo Cristo, queste foreste scomparvero del tutto per lasciare il posto ai prati. Attualmente la vegetazione è ridotta a pochi eucalipti, ad alcuni giunchi, specie attorno ai laghi, e ai pascoli.
Il fatto è che la popolazione dell’Isola di Pasqua avrebbe commesso un involontario ecocidio: l’isola era estremamente fragile – secca, fresca e remota. La lontananza da altre terre aveva reso il suolo poco fertile per la carenza di semi e ceneri vulcaniche portati dal vento: una volta tagliata per ricavare legna da ardere e per l’agricoltura, la foresta non è più ricresciuta; mentre la legna iniziava a scarseggiare e non potevano più essere costruite le canoe per andare a pesca, gli isolani cominciarono a mangiare gli uccelli. I moai accelerarono l’autodistruzione: i megaliti, secondo Diamond, erano simboli di potenza esibiti dai capitribù che, intrappolati su quest’isoletta sperduta, non avevano altri mezzi per dimostrare la propria forza all’avversario se non costruendo statue sempre più grandi, che per esser mosse avevano bisogno di un sempre maggior numero di persone. Col passare del tempo, la deforestazione e l’erosione del suolo resero meno abbondanti i raccolti, e i Rapanui piombarono nella guerra civile e nel cannibalismo ancora prima dell’arrivo degli Europei. Fu allora che vennero abbattuti i moai. Nel XIX secolo il paesaggio dell’Isola di Pasqua aveva acquisito un’aura tragica che, per alcuni aspetti, dura tutt’oggi. Il collasso di questa isolata civiltà, scrive Diamond, «è il più chiaro esempio di una società che annienta se stessa sfruttando fino all’esaurimento le proprie risorse», «l’ipotesi più pessimistica del futuro che ci aspetta».
I già citati Terry Hunt e Carl Lipo, invece, vedono negli antichi Rapanui un emblema della determinazione e dell’ingegno umani: l’immagine che danno, basata sulle ricerche loro e di altri ma molto contestata, è di un’isola popolata da pacifici costruttori di moai ed esperti agricoltori. I due archeologi ritengono che i Polinesiani sbarcarono su Rapa Nui nel 1200 dopo Cristo e non nell’800 dopo Cristo come comunemente si crede. Ma non erano soli: le noci delle ormai estinte palme dell’isola, dissotterrate durante le ricerche, mostrano spesso minuscoli solchi opera dei denti affilati dei ratti. I primi coloni portarono con sé polli e ratti per cibarsene. Purtroppo, non avendo altri predatori all’infuori dell’uomo, in pochi anni i ratti infestarono l’isola: banchettando a noci di cocco, i ratti impedirono la naturale diffusione dei semi di questi alberi a crescita lenta, causando la scomparsa delle foreste di Rapa Nui; e sicuramente i ratti mangiavano anche le uova degli uccelli. Anche dopo la scomparsa delle foreste i Rapanui prosperarono, arrivando rapidamente a una popolazione di circa 3.000 individui rimasta più o meno stabile fino all’arrivo degli Europei.
Per i Rapanui, continuano Hunt e Lipo, i campi avevano più valore delle foreste di palme. Ma si trattava di terre aride, frustate dal vento e bagnate da una pioggia incostante, dove la sopravvivenza era dura e richiedeva sforzi eroici. Nell’agricoltura, così come nel trasporto dei moai, gli isolani spostarono enormi quantità di pietre per metterle ai bordi dei loro campi. Costruirono migliaia di barriere frangivento circolari, i «manavai», coltivando poi al loro interno. Cosparsero interi campi di frammenti di roccia vulcanica per mantenere il terreno umido e lo concimarono con sostanze nutritive che i loro vulcani non diffondevano più: furono quindi i pionieri dell’agricoltura sostenibile. Scrivono Hunt e Lipo nel libro Le Statue Che Camminavano che «Rapa Nui rappresenta la storia di un insperato successo, non quella di un miserabile fallimento». Persino i moai, sostengono, contribuivano a mantenere la pace, non solo perché rappresentavano simbolicamente il potere dei loro artefici, ma anche perché limitavano l’aumento della popolazione: la gente impiegava le proprie energie crescendo statue invece di figli. E ritengono anche che le schegge affilate di ossidiana ritrovate siano state utensili agricoli e non armi: non credono affatto alle storie di violenti conflitti fra i Rapanui, anche se ciò è stato provato dalle ricerche e dagli studi di altri archeologi e persino dai racconti tramandati oralmente dai discendenti degli isolani.
Poi arrivarono gli Europei e, con loro, la decadenza: gli esploratori portarono malattie letali nei confronti delle quali gli isolani non avevano difese immunitarie e anche manufatti che sostituirono, per valore simbolico, i moai. Prendere i cappelli agli Europei diventò più interessante che issare un «pukao» di varie tonnellate sulla testa di un moai. Nell’Ottocento il commercio degli schiavi decimò la popolazione, che nel 1877 era ridotta a soli 111 individui. Un genocidio e insieme l’annientamento di una cultura unica al mondo.
Il resto è storia recente. Il Cile ha annesso Rapa Nui nel 1888 e vi ha stabilito un governatorato, ma ha concesso a una compagnia scozzese di utilizzare l’isola fino al 1953 come un gigantesco pascolo per le pecore, che vagavano liberamente mentre gli abitanti erano confinati ad Hanga Roa, che era – e che è tuttora – l’unica città; il forte vento e le verdi colline ricordavano gli altipiani di Scozia. Del resto, per i discendenti degli isolani Rapa Nui era il mondo: la vita che c’era al di là del mare non era vita ma solo quanto, al massimo, gli uomini avrebbero potuto trovare dopo la morte; credenza, questa, che spiega l’attuale attaccamento degli indigeni alla loro terra. Nel 1964 i Rapanui si sono ribellati al governatore, ottenendo in seguito la cittadinanza cilena e il diritto a eleggere il proprio sindaco.
Ormai, l’Isola di Pasqua non è più riconoscibile come lo scoglio dei moai: non viene più nominato il Makemake, il dio-uccello personificato da colui che riusciva a trovare ogni anno il primo uovo deposto dalle rondini marine sullo scoglio di Motonui, che veniva raggiunto dopo una lunga corsa sul mare di tutti gli uomini imbarcati sui leggeri battelli di giunco intrecciato; gli uomini hanno smesso i loro costumi di «tapa» e i variopinti ornamenti di foglie sono stati sostituiti dalle camicie e dai pantaloni di tela, ricomparendo solo in qualche serata, quando le ragazze danzano al suono delle più antiche melodie polinesiane. La terra che per secoli era rimasta isolata dal mondo vede arrivare ogni settimana 12 voli dal Cile, dal Perù e da Tahiti: nel 2011 questi aerei hanno portato 50.000 turisti, dieci volte la popolazione dell’isola. Quarant’anni fa le macchine, l’elettricità e il telefono erano poco diffusi: oggi Hanga Roa brulica di Internet caffè, bar e discoteche; autovetture e pick-up intasano le strade il sabato sera, mentre turisti facoltosi spendono mille dollari a notte nei vari alberghi di lusso. Sono circa 2.000 i Rapanui discendenti degli indigeni che vivono sull’isola: parlano spagnolo, frequentano le Università e le scuole del continente, ma poi tornano a casa; si rifiutano di fare lavori considerati umili («Un Rapanui non si mette a lavare i piatti»), che vengono svolti da emigranti cileni attratti anche dall’esenzione dalle tasse sul reddito. Molti Rapanui si sono sposati con immigrati cileni, ma altri temono che la cultura dell’isola si stia perdendo. «Il nostro patrimonio culturale è la base della nostra economia» ha spiegato il sindaco Luz Zasso Paoa; «non si viene qui per noi, ma per quello che abbiamo». Cioè per i moai, per una natura splendida, soprattutto per il senso di mistero di un’isola che non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti. E che forse non li rivelerà mai, custodendoli dentro di sé.