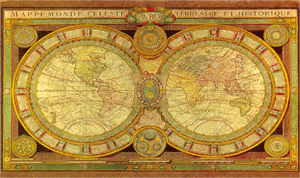Perché il Castello Estense?
Come la rivolta del 1385, uno dei fatti
più brutali della storia di Ferrara, portò alla costruzione
di una fortezza, poi divenuta un palazzo principesco
Le vicende umane non sono come il terremoto che, senza preavviso, giunge e combina i guai che tutti conosciamo. Qualsiasi azione o reazione ha sempre un presupposto che deriva da lontano. Sicuramente, lo stato di libero Comune, in atto in molte città italiane, raggiunto da Ferrara dopo essere stato feudo dei Canossa, influì notevolmente sulla mentalità della popolazione. In effetti, era ormai abitudine consolidata che, quando si doveva decidere qualcosa di importante, le campane chiamavano a raccolta i Ferraresi, che accorrevano a frotte e si accalcavano nella piazza, perché tutti avevano la possibilità di esprimere il loro parere, partecipando in prima persona a tutto quanto c’era di importante per governare il Comune, così come dovrebbe avvenire in una democrazia nel vero senso della parola. Se poi il problema era complesso e non si poteva decidere sul momento, ma era opportuno approfondirlo, allora il popolo eleggeva un consiglio formato da appartenenti alla nobiltà di tutti i gradi e da suoi rappresentanti. Studiosi moderni sono dell’avviso che le norme e i regolamenti deliberati in materia amministrativa, finanziaria e commerciale possono essere presi ancora oggi come esempi di saggezza.
Si viveva in serenità, finché nel corso del tempo iniziarono a esistere i dissensi fra due grosse famiglie ferraresi: da una parte si trovava il partito dei Guelfi guidato dalla famiglia Adelardi, e dall’altra quello dei Ghibellini capitanato dalla famiglia Torelli-Salinguerra. Nel Basso Medioevo questi due partiti rappresentavano due fazioni politiche contrapposte, che dominarono finché nel secolo XIV non nacquero le Signorie. Le controversie fra questi due grandi gruppi consentirono agli Estensi di farsi spazio: sicché – come si dice – fra i due litiganti, con quel che segue.
Però, spesso si sente parlare di queste due fazioni, senza sapere a che cosa si debbano i loro nomi. La loro origine si deve a un fatto importante che successe nel 1125. Infatti dopo la morte di Enrico V di Franconia (un territorio della Baviera del Nord), che non aveva lasciato eredi, ci fu una asperrima lotta fra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (da qui Guelfi, favorevoli alla Chiesa) e quella sveva degli Hohenstaufen, che vivevano nel castello di Waiblingen, un tempo Wibeling (da qui Ghibellini, rigidi nei confronti di qualsiasi interferenza politica dello Stato Vaticano). Secondo molti cronisti, i due nomi derivano dalle grida di battaglia degli appartenenti alla fazione dei sostenitori della casa bavarese e di quelli che parteggiavano per i Duchi di Svevia che, in occasione della battaglia del 1140 sotto le mura del castello di Weisberg, dal quale prese il nome, nei pressi della città di Heilbronn, urlavano «Hye Welff» e «Hye Wibelingen», corrispondenti più tardi a «Heil Welf» e «Heil Waiblingen». Per la cronaca, gli Svevi sconfissero i Bavaresi, che non riuscirono a opporsi all’assedio del Re Corrado III di Hohenstaufen.
La prima mazzata al potere del popolo fu data da Azzo VI d’Este, del Ducato di Modena, il quale, sposata l’erede degli Adelardi, si trasferì con la sua Corte a Ferrara, iniziando un luminoso periodo di grandezza. Ma ecco dove cade l’asino: secondo lui la città, così com’era, non era adatta sia a rappresentare la propria grandezza, sia a far valere il proprio dominio sul territorio. Così, i Marchesi iniziarono tutta una politica basata sul lusso, sulla sontuosità, sulle spese incontrollate per le feste, sui pantagruelici banchetti, sugli abbellimenti delle dimore secondo la cittadinanza non sempre giustificabili, sull’arricchimento della città con splendidi monumenti e così via via elencando. Come conclusione, il popolo, abituato a partecipare senza intermediari alla vita cittadina, non solo se ne sentì amaramente escluso, ma per di più, comprese di essere sull’orlo della più nera miseria. E non aveva tutti i torti, in verità, giacché – come si legge in una cronaca dell’epoca – il Marchesato aveva introdotto tasse, tributi, imposte, dogane, dazi, balzelli e... chi più ne ha più ne metta, che erano tutti sulle spalle della gente e a suo detrimento; e tutto ciò avvenne senza interpellarla, com’era consuetudine, o senza coinvolgere i suoi rappresentanti, rimasti senza il diritto di voto.
Il Marchese Niccolò II d’Este, figlio di Obizzo III, Signore di Ferrara, Modena e Parma, assumendo la sovranità nel 1361, confermò definitivamente lo strapotere della dinastia, che raggiunse il massimo nel 1385. Egli era soprannominato «lo Zoppo», a causa della gotta che fu il tormento di tutta la vita. Come i suoi predecessori, spendeva e spandeva senza limiti e, quando vedeva che le sue riserve auree e di moneta sonante andavano rapidamente esaurendosi, ordinava ai suoi collaboratori non solo di obbligare i cittadini a pagare tasse, soprattasse e quant’altro, ma anche di adoperarsi con decisione e violenza contro coloro che non intendevano contribuire a soddisfare le sue spese sfarzose.
Il popolo affamato, che già da tempo era ridotto a uno stato pietoso a causa di precedenti devastanti inondazioni, che avevano trasformato il suo territorio in una palude puzzolente e malarica, mettendo in grave difficoltà la produzione agricola, e di una micidiale epidemia di peste, che lo aveva decimato, si trovò addosso pure la gogna dei prelievi tributari sempre più esosi. Si era giunti ai limiti della sopportazione.
Infatti, si narra che nella notte fra il 2 e il 3 marzo 1385, nella casa del notaio Montelini fu organizzata una riunione segreta alla quale parteciparono rappresentanti del popolo, del clero e della borghesia; e lì, dopo aver appurato che si poteva contare su 700 uomini (fra quelli di città e quelli di campagna) e 300 cavalli, ritenendosi sufficientemente forti, fissarono le modalità per avviare la tanto vagheggiata rivolta.
Stando al parere della gente, la colpa della situazione tragica in cui viveva non si doveva al Signore, che era il vero responsabile delle sue sofferenze, e lo riteneva semplicemente un ingenuo, che lasciava che il suo consigliere e giudice dei savi Tommasino da Tortona decidesse, «sua sponte», come mungere denaro dalle sue tasche. Infatti, la folla inferocita – secondo quanto si narra – avanzava al grido di: «Viva Niccolò e muoia Tommasin traditore». A quel punto, vista la mala parata, Tommasino si rifugiò nel palazzo della cancelleria della Corte, convinto che il corpo dei gendarmi del Marchesato lo avrebbe protetto. La folla inferocita, dopo aver abbattuta la porta, entrò senza trovare quel poveretto che, grazie ai familiari di Niccolò, era stato sollevato con una fune nel piano superiore attraverso un buco praticato appositamente nel soffitto. Allora, una parte dell’orda di vandali mise a soqquadro la cancelleria, asportando tutti i libri contabili, accatastandoli presso San Romano e incendiandoli, un’altra parte si recò alla casa del Tortona, depredando e facendo il disastro, mentre un’altra ancora visitò le case dei gabellieri, incendiandole. Niccolò, sporgendosi dalla finestra, invano tentò di calmare gli animi e di sedare la rivolta; e analogamente i tentativi del fratello Alberto, che coraggiosamente era sceso in piazza, fallirono. A complicare tragicamente la situazione fu la cattura da parte degli insorti di un figlio del Marchese; essi proposero uno scambio alla pari: il figlio per quel giudice dei savi che, secondo loro, era l’unico responsabile di tutti il loro problemi. Naturalmente, il Marchese si trovò a un bivio veramente penoso: sacrificare il figlio oppure abbandonare al suo destino chi poteva ritenere la causa di tutti i suoi guai? Non c’era tempo da perdere: l’Estense, seppur a malincuore, decise di abbandonare al suo destino il suo collaboratore. Questi, conscio che non se la sarebbe cavata, si confessò, chiese remissione dei suoi peccati a Dio e si lasciò consegnare alla folla inferocita.
L’odio nei confronti di quella persona che, secondo la popolazione, era la causa di tutti i suoi mali, era tale che, non appena fu nelle sue mani, in pochi istanti fu uccisa e squartata. Di questi resti, una parte fu rosolata sulle ceneri ancora fumanti dei libri contabili presso San Romano, una parte fu portata sul Po, a Francolino, per metterla in mostra sull’argine del fiume, mentre il cuore e il fegato furono mangiati: più che la fame, l’odio immagazzinato dai rivoltosi li aveva trasformati nei più feroci antropofagi. I Ferraresi, un tempo normali e tranquilli, erano diventati delle belve, dei bruti della peggiore specie, che avevano umiliato in tal modo quell’essere per loro immondo.
Alla fine del giorno, la rivolta fu finalmente sedata. L’uccisione e l’umiliazione riservate al Tortona riuscirono a calmare anche gli animi più violenti e così la Signoria e la vita di Niccolò furono salvate grazie al versamento del sangue di quel povero uomo. Il giorno successivo, per tastare il polso della situazione, il Marchese uscì a cavallo insieme con il fratello Alberto e con la scorta di dodici uomini ed ebbe la soddisfazione di vedere nei cittadini segni di rispetto e soggezione. Egli, per dimostrare la sua clemenza, ma anche – si direbbe oggi – che la lezione gli era servita, tolse alcune imposte, ma non volle lasciare impunita quella sanguinosa presa di posizione da parte dei suoi sudditi. Così, procedendo in maniera segreta e con promesse di impunità e di soldi, volle conoscere i nomi di coloro che avevano ordito il complotto. Ed è qui che fa bella mostra di sé l’individuo più viscido, vigliacco e perfido di tutta la faccenda: quel Montelini, che fu uno degli organizzatori della rivolta e che la capeggiò, per salvare il proprio collo, senza ritegno alcuno consegnò i compagni all’ira del Marchese, che nel giro di pochi mesi li giustiziò, esponendone i corpi e le teste mozzate sulle forche nelle piazze della città.
Con quella reazione, l’Estense fece un bel repulisti fra i più facinorosi dei suoi sudditi, ma sicuramente non riuscì a eliminare del tutto chi mal subiva il suo governo. Era riuscito a normalizzare la situazione, riportando la calma, ma non si sentiva del tutto tranquillo, per cui giunse alla decisione di far costruire una fortezza che fosse la residenza della Corte Estense e, nello stesso tempo, il fortilizio nel quale rifugiarsi con tutta la sua famiglia, qualora fossero scoppiati ulteriori pericolosi tumulti popolari. Per questo, si rivolse all’architetto Bartolino Ploti da Novara, che già da qualche tempo risiedeva a Ferrara, dandogli l’incarico di progettare e far costruire un castello fortificato dentro le mura.

Il castello fotografato da Paolo Monti nel 1965, Fondo Paolo Monti, BEIC (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura), Milano (Italia)
Allora Ferrara era estesa meno della metà di oggi. Sulla cinta muraria, che si estendeva sulla sponda sinistra del ramo del Po, che serviva come valida difesa contro potenziali nemici, si trovava una vecchia torre, chiamata Torre dei Leoni, che serviva come difesa per la porta cittadina e che l’architetto inserì nel suo progetto, costruendo un’opera fortificata, a base quadrata, aggiungendo altre tre torri e con avancorpi, il tutto protetto da un profondo fossato ricolmo di acqua, che costituiva una buona sicurezza per chi vivesse all’interno. Il castello di San Michele (così era stato denominato) era una vera e propria fortezza con sopra le bertesche. Le merlature potevano essere raggiunte attraverso una rampa, posta su tre lati, dagli animali da soma che trasportavano armi e munizioni. La fortezza divenne l’emblema di una tale forza politica e militare da togliere ogni ambizione o voglia di andare contro il Duca alle più litigiose famiglie ferraresi.
Considerato poi che i rapporti fra il Signore, diventato col tempo Duca, e i suoi sudditi erano notevolmente migliorati, quando all’inizio del XVI secolo ci fu la cosiddetta «Addizione Erculea», che in pratica raddoppiò la città verso Nord, il castello, da fortezza di difesa delle mura, si trovò nel bel mezzo della città, si sentì la necessità di alleggerirne la severità. L’occasione arrivò quando, nel 1554, un furioso incendio devastò il castello (ormai definito Castello Estense). Il Duca, che allora era Ercole II, incaricò Gerolamo da Carpi, piano piano divenuto il più importante artista della Corte, di rimetterlo in sesto. Egli ne approfittò per togliere alla costruzione quell’aspetto austero, militaresco e difensivo che fino ad allora l’aveva accompagnata, trasformandola in un palazzo principesco, provvedendo all’abolizione delle merlature medievali con balaustre di marmo e intervenendo su molti particolari, alleggerendo l’intera struttura. Nel 1570, infine, per ordine del Duca Alfonso II, l’architetto Alberto Schiatti provvide a elevare le torri, completandole con edicola finale, conferendo al castello quell’aspetto che tutti i giorni i Ferraresi e i turisti possono ammirare.

Il castello estense di Ferrara (Italia), la facciata rivolta a Nord-Ovest