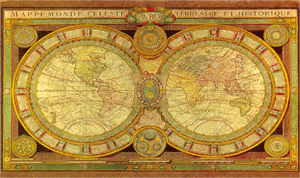Marcantonio Bragadin
La storia dell’eroico difensore di Cipro
Verso la seconda metà del Cinquecento, l’Impero Ottomano poteva finalmente godere della pace con tutti i popoli confinanti, e specialmente con il suo più pericoloso nemico, la Persia.
Al Gran Sultano Selim II, soprannominato l’«Ubriacone», rimaneva una sola preoccupazione: l’ancor viva potenza della Repubblica di Venezia che, pur colpita dalla sconfitta di Prevesa e dalla perdita di numerosi possedimenti nell’Egeo, occupava territori strategici nel Mediterraneo – le Isole Ionie, la Dalmazia e, più grave ancora, le due isole di Candia e Cipro che rendevano poco sicure le coste turche della Morea, della Siria, dell’Asia Minore, dell’Egitto. Per risolvere in modo definitivo il problema, veniva deciso alla Corte di Costantinopoli di riprendere la guerra ad Occidente attaccando Venezia nel suo possesso di Cipro.
Brutto, piccolo, corpulento e beone, di scarsa intelligenza, il Sultano era propugnatore di una politica di amicizia verso la Serenissima, intendendo colpire prima Filippo II e poi gettarsi in grande stile contro l’Italia: fu convinto a cambiare obiettivo da un lato dai vezzi cortigiani di un Giudeo immigrato dal Portogallo, José Miquez, creato duca di Nizza ma che ambiva a diventare signore di Cipro; e dall’altro lato dall’incendio dell’arsenale di Venezia, già provata dalla carestia e dalla pestilenza.
Nel marzo del 1570, Selim II inviò alla città lagunare un ambasciatore con l’incarico di consegnare al Consiglio dei Dieci della Repubblica questo messaggio: «Vi domandiamo Cipro, che ci darete per amore o per forza. E guardatevi di irritare la nostra terribile spada, perché vi muoveremo guerra crudelissima in ogni parte».
Il Senato Veneziano accettò senza esitare la guerra, cominciò ad assoldare uomini d’arme, fabbricare navi, cannoni e munizioni. Il 3 luglio dello stesso anno, una flotta turca di 348 navi guidate da Pialì Pascià giunse davanti all’isola di Cipro e vi sbarcò 240.000 soldati. Il 22 luglio, i Turchi già assediavano Nicosia, la capitale dell’isola, dove Palazzo da Fano e Nicolò Dandolo con poco più di 3.000 uomini di presidio avevano preparato la resistenza.
Il 9 settembre, stremata di guarnigione e di popolo, Nicosia venne espugnata. Mustafà Pascià, comandante in capo delle truppe nemiche, fece passare a fil di spada 15.000 Cristiani e trasse gli altri sulle galee come schiavi. Poi l’esercito turco si diresse su Famagosta, città protetta da un robusto sistema di fortezze, nella parte orientale dell’isola: un centro sontuoso di palazzi eleganti, di giardini, di aranceti e di fontane, abitato da un’orgogliosa società cosmopolita che aveva saputo trasformare in arte la dolcezza del vivere.
I Turchi intimarono immediatamente la resa, ma i Veneziani la respinsero e si prepararono alla difesa. La disparità di forze era impressionante: a sbarrare il passo ai guerrieri ottomani stavano 3.700 soldati italiani e 4.000 Greci, armati di alabarde, balestre, cannoncini e colubrine; il loro comandante era Marcantonio Bragadin. Nato a Venezia il 21 aprile 1523 da una nobile famiglia dalmata, figlio di Marco di Giovanni Alvise e di Adriana figlia di Giovanni Bembo, Marcantonio seguì la carriera delle armi fino al termine dei suoi giorni con coraggio, energia ed un altissimo senso del dovere (un giorno trasse la spada dal fianco a un capitano di compagnia e con questa lo ammazzò di sua mano, probabilmente per qualche grave atto d’insubordinazione): la sua storia è soprattutto la storia dell’assedio di Famagosta, una lotta asperrima e tenacissima.
Tiziano Aspetti, Busto di Marcantonio Bragadin, circa 1571, Palazzo del Doge, Venezia (Italia)
Già da tempo Marcantonio Bragadin aveva munito la città di opere fortificate, l’aveva provveduta di viveri, aveva ridotto le polveri in depositi sicuri, aveva arruolato milizie pagate con una moneta di rame che faceva battere nella zecca locale, imponendone il corso forzoso con la minaccia della pena di morte per chi la rifiutasse, sicché, racconta un cronista, «la detta moneta correva come fusse stato oro et argento». Rintanati nelle gallerie e nei forti, gli assediati ricorsero ad ogni mezzo per indebolire la pressione del numeroso esercito nemico: furono fatte esplodere mine, avvelenate le acque, cosparso il terreno di chiodi, sparati innumerevoli colpi di artiglieria. I Turchi risposero ricorrendo ad ogni astuzia: scavarono trincee, eressero fortificazioni e torri mobili davanti alle mura della città, bombardarono le case e gettarono al di là delle mura materie incendiarie. Uno storico dell’epoca, nel riferire gli avvenimenti, scrisse che fu tale lo «strepito da una parte e l’altra ed i fulgori terreni, che pareva che ’l mondo rovinasse». Ogni giorno, i Veneziani scrutavano ansiosamente l’orizzonte, per scorgere se si avvicinasse la flotta di soccorso che attendevano dalla capitale: ma nessuna vela amica appariva ad increspare la piatta distesa del mare.

Giacomo (Jacomo) Franco, Mappa di Famagosta nel libro Viaggio da Venetia a Constantinopoli per Mare, 1597
L’artiglieria di Famagosta era di una precisione formidabile: tutti i cannoni e le torri dei Turchi venivano inesorabilmente colpiti e diverse migliaia di soldati rimasero uccisi. Purtroppo, nel mese di maggio dell’anno successivo, il 1571, cominciarono a scarseggiare le munizioni: venne ordinato che ogni pezzo non sparasse più di 30 colpi al giorno. I Turchi se ne accorsero ed assediarono la città ancor più da vicino.
Il 9 luglio, i Turchi prepararono l’attacco generale. Per ben sette volte in sette ore si combatté all’arma bianca, ed ogni volta gli assedianti vennero ricacciati indietro mentre i cannoni veneziani bersagliavano gli assalitori.
Famagosta era però allo stremo, senza più munizioni, senza vino, senza pane, la popolazione ridotta alla fame, le strade e le case piene di feriti, malati, morenti, senza più alcuna speranza di soccorsi: si decise perciò di venire a patti col nemico.
Del tutto inaspettatamente, il 29 luglio, dopo aver fallito un nuovo attacco generale, furono i Turchi a chiedere di parlamentare coi Veneziani, trattando una resa ad onorate condizioni: veniva garantita la vita ai difensori superstiti, l’uscita libera a chiunque con armi e bagagli, cinque cannoni e tre cavalli (uno per ciascuno) a Marcantonio Bragadin, ad Astorre Baglioni provveditore generale della piazza e a Querini provveditore in sottordine, e il passaggio sulle galee sino a Candia. La conquista di Famagosta era costata la vita a 6.000 Veneziani e 80.000 Turchi (questo la dice lunga sulla leggenda che vuole gli Italiani privi di doti militari!). Conclusa la pace il 1° agosto, Mustafà Pascià chiese di poter vedere il valoroso difensore di Famagosta e i suoi principali collaboratori.
Marcantonio Bragadin si recò al padiglione di Mustafà con un seguito di 300 uomini. Il comandante musulmano li accolse dapprima con molta cortesia, ma poi, d’improvviso, ad un cenno convenuto da ogni parte irruppero soldati turchi che si scagliarono sui Veneziani tagliandoli a pezzi o decapitandoli a colpi di scimitarra.
Marcantonio Bragadin venne risparmiato: fu legato e gli vennero mozzate le orecchie. I Turchi lo accusarono di aver fatto trucidare la notte precedente una cinquantina di prigionieri; non sappiamo se la notizia del massacro – raccontata da alcuni prigionieri turchi fuggiti da Famagosta – fosse vera; il fatto è che i nemici cercavano semplicemente un pretesto per rompere i patti e sfogare la loro collera contro i difensori di Famagosta, che per quasi un anno avevano inchiodato l’esercito turco sotto le mura cittadine, infliggendogli gravissime perdite.
Otto giorni dopo, Mustafà Pascià, dopo aver schernito Marcantonio Bragadin, gli chiese se voleva convertirsi all’Islam, ma il comandante veneziano rifiutò, rimproverando al Turco la sua malafede e crudeltà.
Il 15 agosto, Marcantonio Bragadin, con la testa piagata in seguito al taglio delle orecchie, venne condotto sulla piazza di Famagosta. I Turchi lo deridevano, invitandolo a guardare un’ultima volta il mare per vedere se arrivavano i soccorsi da Venezia; in una relazione di quei fatti si legge che, un’ora dopo, Marcantonio Bragadin «crudelissimamente scorticato vivo con tanta sua constantia e fede, che mai si perde d’animo, anzi con core costantissimo li rimproverava la rotta fede e sempre senza smarrirsi si raccomandava a Dio; e, spirato questo in grazia di Sua Divina Maestà, fu presa quella pelle et empita di paglia l’han fatta veder per tutte le riviere della Sona [Siria] portata da una galeotta attaccata all’antenna». Il corpo fu poi inviato a Costantinopoli.
Selim II non ebbe il tempo di rallegrarsi: il 7 ottobre la flotta tanto attesa dai difensori di Famagosta (che radunava Spagnoli, Italiani e Cavalieri di Malta) incrociò quella turca, numericamente superiore, presso Lepanto. Al termine dello scontro, i Turchi avevano perso 30.000 uomini ed oltre metà della flotta tra galere colate a picco o catturate (una delle sei galeazze veneziane che con la loro potenza di fuoco avevano svolto una parte decisiva nella battaglia era governata da Antonio, uno dei fratelli di Marcantonio Bragadin). Invece delle fanfare della vittoria, il Sultano udì il pianto delle donne, la disperazione degli uomini; l’Impero Ottomano perdeva il controllo del Mediterraneo e cominciava il suo lento, ma inarrestabile declino.
Sedici anni dopo, un Italiano riusciva a trafugare i miseri resti di Marcantonio Bragadin e a riportarli a Venezia, dove tuttora si trovano, nella chiesa di San Giovanni e Paolo.