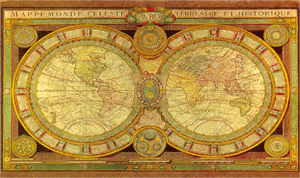Storia della Palestina e dei Palestinesi
Un popolo e una terra oppressi, o
un’identità creata a tavolino? Una difficile indagine
storica, libera da condizionamenti ideologici
Insegnanti che invitano a rimuovere dai «social» l’amicizia ai propri amici ebrei perché accusati di essere collusi col Governo Israeliano di Netanyahu (compresa Stefania Mazzone, docente di Storia delle Dottrine Politiche all’Università di Catania, che in passato ha fatto da scudo umano in un villaggio palestinese contro il fuoco dell’esercito israeliano e che ha contatti con colleghi israeliani che protestano contro il loro Governo ancora prima del massacro del 7 ottobre 2023). Docenti e studenti universitari insultati e pestati perché ritengono che nelle aule universitarie si debba studiare, e non fare propaganda politica (oltretutto di nessun livello culturale) impedendo lo svolgimento delle lezioni. Boicottaggio di artisti israeliani (a quando il rogo dei loro libri?). Cartelli che vietano l’ingresso agli Ebrei nei negozi.
Non stiamo parlando dell’Europa degli anni Trenta, ma di quella attuale, di queste settimane. Un’Europa dove il virus dell’antisemitismo ha trovato nuova linfa nelle persone che – in buona o in malafede – tentano di fermare l’attacco al popolo palestinese, spesso ricorrendo a una violenza simile a quella che rinfacciano al «nemico».
Abbiamo parlato di «popolo palestinese». Sarebbe ora da chiedersi quale sia questo popolo.
Oggi vengono definiti col termine di «Palestinesi» quattro gruppi principali di persone, per un totale di poco più di 14 milioni di individui:
1) gli abitanti di Cisgiordania e Gaza, i cosiddetti «territori palestinesi»;
2) i profughi delle guerre del 1948 e del 1967 e i loro discendenti che vivono in Giordania, in Siria e in Libano;
3) i cittadini arabi di Israele;
4) gli emigrati non riconosciuti come profughi.
Geograficamente, la Palestina è delimitata a Ovest dal Mar Mediterraneo e a Nord dai contrafforti meridionali del Libano e dell’Antilibano; i confini naturali lungo gli altri lati sono assai vaghi. Nei tempi più antichi la regione era denominata Terra di Canaan ed era occupata da un agglomerato di città-stato cananee indipendenti.
Questa era la situazione quando nel 1250 avanti Cristo circa vi giunsero gli Ebrei, tornati nella loro terra di origine dopo la terribile esperienza della cattività in Egitto (e del primo tentativo di genocidio riportato nella Storia, quando i Faraoni decretarono che i figli maschi degli schiavi ebrei avrebbero dovuto essere uccisi al momento della nascita, mentre le femmine avrebbero potuto vivere).
Nella regione vi erano varie popolazioni tra le quali i Filistei, popolo poco studiato, che erano giunti via mare da Creta. Il loro nome, Peleset, viene citato tra i Popoli del Mare sconfitti dal Faraone Ramesse III. I Filistei, rimasti sulle coste della Siria col beneplacito egizio (che mirava a usarli per mantenere il controllo della zona), erano divisi in cinque principali città-stato, ognuna delle quali era governata da un Sovrano autonomo (Gaza, Ascalona, Ashdod, Gat e Akkaron o Ekron); esse operavano in modo unitario solo nelle questioni di comune interesse e nei rapporti con i popoli vicini. Probabilmente la maggior parte della popolazione era di stirpe cananea e i Filistei costituivano la ristretta classe dominante, grazie all’utilizzo dei carri da guerra e delle truppe mercenarie, oltre alle armi di ferro la cui lavorazione avevano appreso dagli Hittiti.
Di loro non si hanno fonti dirette; nonostante l’abilità nella lavorazione dei metalli e alcune pregevoli opere di artigianato, il loro apporto alla civiltà umana è stato praticamente nullo. Dopo alcune vittorie militari sia sui Regni teocratici delle Dodici Tribù di Israele sia sul Regno di Israele sotto il Re Saul, furono definitivamente sconfitti dal Re Davide e ricacciati nelle loro città costiere. In seguito queste città filistee furono annesse all’Impero Assiro (VII secolo avanti Cristo) e poi a quello Babilonese. Solo Gaza rimase autonoma fino alla conquista persiana, come terminale delle piste carovaniere arabe sulla costa del Mediterraneo. Col tempo, la loro gente si fuse con le altre popolazioni della regione e scomparve dalla Storia; non vi è alcun tipo di «parentela», neppure lontana, tra gli antichi Filistei e i Palestinesi odierni, nonostante i secondi abbiano preso il nome dai primi.
Lo stesso termine «Palestina» ha un’origine particolare: «Palashtu» è il nome con il quale gli scribi assiri dei secoli IX-VII avanti Cristo indicavano il territorio meridionale della costa palestinese occupato dai Filistei; nel V secolo avanti Cristo Erodoto usava il termine «Palaistinoi» per indicare le popolazioni della costa palestinese. Ma nessun popolo locale indicava la sua terra con il nome «Palestina» o con un nome analogo.
Facciamo un passo indietro. Alla morte del Re Davide, il trono passò a Salomone. Gli ultimi anni del suo governo furono caratterizzati da disordini, e dopo di lui il Regno si divise in Regno di Israele a Nord e Regno di Giuda a Sud. Due Nazioni separate e spesso in conflitto fra loro, che furono preda di popoli più numerosi e meglio organizzati: gli Assiri si impadronirono del Regno di Israele, dove insediarono alcune popolazioni di coloni che diedero origine ai Samaritani; successivamente, i Babilonesi di Nabucodonosor II occuparono sia i territori assiri che il Regno di Giuda.
La Palestina passò in seguito sotto i Persiani, poi sotto i Macedoni di Alessandro Magno.
Quando Alessandro morì, scoppiò una guerra tra i suoi successori e la regione entrò a far parte dell’Impero Seleucide (dal nome del Generale Seleuco), che comprendeva quasi tutti i territori asiatici dell’Impero di Alessandro, ma la cui unità durò molto poco.
Il governo dispotico e crudele dei Re Seleucidi portò gli Ebrei a numerose rivolte e a chiedere l’aiuto della potenza emergente dei Romani. Questi appoggiarono a Gerusalemme la famiglia degli Asmonei, che governò lo Stato fino a quando Pompeo entrò in Gerusalemme e ne fece un Regno cliente o protettorato romano sotto l’amministrazione di Re locali.
Le rivolte antiromane del 70 e del 132-135 dopo Cristo portarono l’Imperatore Adriano a creare la provincia romana di «Syria et Palaestina», quest’ultimo nome scelto per scherno e «punizione» verso gli Ebrei, riferendosi ai loro antichi nemici, i Filistei, ormai da tempo scomparsi.
Alla divisione dell’Impero Romano dopo Costantino, la Palestina entrò a far parte dell’Impero Romano d’Oriente, conosciuto oggi anche come Impero Bizantino. Le guerre sostenute da questo Impero con il vicino Impero dei Sassanidi (che occupavano l’attuale Iran) portarono la Palestina a passare dagli uni agli altri, prima di essere riconquistata dai Bizantini.
I due contendenti si erano logorati in una serie di scontri che impedirono loro di far fronte all’espansione araba: la Palestina entrò quindi a far parte dell’Impero Omayyade e Fatimide, fu poi liberata dai crociati e divenne il Regno di Gerusalemme, cristiano.
Due secoli dopo questo Regno terminò la sua vita con la conquista da parte dell’Impero Arabo-Curdo Ayyubide; passò poi sotto lo Stato Islamico dei Mamelucchi d’Egitto e, ancora più tardi, dell’Impero Ottomano (Impero Turco, musulmano).
Nel frattempo, dopo la conquista araba del VII secolo, la popolazione locale aveva appreso gradualmente la lingua, la cultura e la religione dei conquistatori, ai quali si era mescolata anche dal punto di vista etnico. Gli Arabi avevano ribattezzato la terra «Falastin». Nel millennio in cui la regione passò dagli Omayyadi agli Abassidi, dagli Ayyumidi ai Fatimidi, dagli Ottomani agli Inglesi, il termine «Falastin» continuò a riferirsi a una regione dai contorni indeterminati e mai a un popolo. Alla fine del Seicento il territorio era quasi disabitato e le poche città (Gerusalemme, Safad, Jaffa, Tiberiade e Gaza) erano abitate in maggioranza da Ebrei e Cristiani; esisteva una minoranza musulmana, prevalentemente di origine beduina, che abitava nell’interno. Quando l’orientalista danese Hadrian Reland pubblicò a Utrecht il suo libro Palaestina ex monumentis veteribus illustrata (1714), non vi era alcuna traccia dell’esistenza di un popolo palestinese, di un’eredità palestinese o di una Nazione palestinese… nessuna traccia di una storia palestinese.
La Prima Guerra Mondiale (1914-1918) ebbe, tra le sue vittime, l’Impero Ottomano. La Palestina finì sotto un mandato britannico. In questo periodo di tempo, che intercorre fra i due conflitti mondiali, cominciò a nascere l’idea di una specifica identità palestinese, cioè il fatto che gli abitanti arabi della Palestina sentivano di appartenere a uno stesso popolo (pur senza separarsi nettamente dalla più generale appartenenza araba), cosa dovuta alla contrapposizione con gli Ebrei emigrati nell’area, che, fuggiti dai Paesi in cui erano sottoposti a «pogrom» e persecuzioni, si stavano trasferendo in massa nell’antica Terra Promessa. Questo provocò i primi scontri con la popolazione ebraica, che divennero nel tempo sempre più frequenti.
L’idea della creazione di uno Stato Arabo musulmano indipendente aveva cominciato a prendere piede in Siria durante l’occupazione francese degli anni Venti; fu il famigerato Gran Mufti di Gerusalemme, Amin al-Husseini, la personalità di maggior spicco tra gli esponenti arabi dell’epoca, a creare un movimento nazionalista in opposizione all’immigrazione ebraica. Al-Husseini era alleato di Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale e le milizie islamiche a lui legate, che combatterono soprattutto nei Balcani al fianco dei nazisti, erano note per la loro ferocia. Al-Hussein non era Palestinese ma Egiziano, e fu in Egitto che trovò riparo dall’arresto per crimini di guerra dopo la fine del conflitto.
Un altro grande leader storico «palestinese» fu Izz al-Din al-Qassam (1882-1935), che però era un Generale, politico e terrorista siriano (era nato a Jableh, una città costiera vicino a Latakia, in Siria, all’epoca parte dell’Impero Ottomano). Fu convinto propugnatore della «Guerra Santa» contro gli Italiani che avevano occupato la Libia, contro l’istituzione del protettorato francese in Siria, contro i Britannici per il mandato in Palestina, ma soprattutto contro gli Ebrei, quelli delle comunità presenti da secoli nella regione ma soprattutto contro i migranti che arrivavano in Palestina dall’Europa, supportati e ispirati dal movimento sionista. Le sue azioni terroristiche suscitarono reazioni ostili anche nelle élite urbane musulmane, poiché minacciavano i loro legami politici e clientelari con le autorità del Mandato Britannico. I Palestinesi lo considerano oggi il simbolo della lotta araba contro i sionisti; da lui prendono il nome le brigate Izz al-Din al-Qassam, la cosiddetta «ala militare di Hamas».
Torniamo al secondo dopoguerra. L’idea che ci fosse una terra chiamata dagli Inglesi «Palestina» e che dovesse essere divisa in due Stati, uno ebraico e uno musulmano, non fu accolta favorevolmente dal mondo arabo: la regione era chiamata «Balad esh sham» («Provincia di Damasco») o «Surya-al-Janubiya» («Siria del Sud») e per i nazionalisti arabi era inestricabilmente legata alla Nazione Siriana. Non c’era la percezione dell’esistenza di una popolazione «palestinese» in senso proprio, e sembrava un’ingiustizia gratuita smembrare la Siria per creare un’altra entità che le apparteneva di diritto.
L’identità palestinese emerse in maniera più netta dopo la guerra arabo-israeliana del 1948, che portò alla nascita dello Stato di Israele e, soprattutto, dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, nella quale lo Stato Ebraico sconfisse gli eserciti alleati di Egitto, Siria e Giordania. Gli abitanti della Cisgiordania e di Gaza persero fiducia nei Paesi Arabi e si proposero di condurre in prima persona la lotta per ottenere il loro Stato, sotto la guida dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina, rappresentativa della popolazione dopo il 1967). Nei decenni successivi, la lotta terroristica ininterrotta contro Israele continuò a rafforzare il sentimento di appartenenza nazionale.
In questo stesso lasso di tempo, cioè dal 1948 al 1967, tutto quello che restava del territorio riservato agli Arabi della Palestina era la West Bank (Giudea e Samaria), che si trovava in quegli anni sotto il dominio giordano, e Gaza, sotto il dominio egiziano. Nessuno dei leader arabi prese in esame il diritto all’autodeterminazione degli Arabi Palestinesi che si trovavano sotto il loro dominio, perché un «popolo palestinese» per i Giordani e gli Egiziani non esisteva. Lo stesso Yasser Arafat (nato in Egitto da genitori egiziani, dato che il padre e la madre erano originari di Gaza, che era territorio egiziano) fino al 1967 usò il termine «Palestinesi» solo come riferimento per gli Arabi che vivevano sotto la sovranità israeliana o che avevano deciso di non essere sottoposti a essa.
Arriviamo ai tempi più recenti che non sono più Storia, ma sconfinano con l’attualità. È dopo la Guerra dei Sei Giorni che i Palestinesi vengono presentati al mondo come un popolo autoctono espropriato della propria terra dai «sionisti imperialisti». A questo punto si è diffusa l’invenzione di una civiltà palestinese risalente a epoche antichissime, fino ai popoli cananei che abitavano la regione al tempo della prigionia ebraica in Egitto, e che furono assoggettati o cacciati dagli invasori sionisti. Ma non esiste, né è mai esistita, una civiltà che si potrebbe definire «palestinese»: non c’è un’economia palestinese, una moneta palestinese (attualmente gli abitanti di Gaza, per esempio, utilizzano principalmente la valuta israeliana), una letteratura palestinese, una musica palestinese, una cucina palestinese, delle tradizioni palestinesi che si possano far risalire a prima del Novecento. Il 31 marzo del 1977 Zahir Mushe’in, membro del Comitato Esecutivo dell’OLP dirà, durante un’intervista, che «il popolo palestinese non esiste. La creazione di uno Stato Palestinese è solo un mezzo per continuare la nostra lotta contro lo Stato di Israele in nome dell’unità araba. In realtà oggi non c’è alcuna differenza tra Giordani, Palestinesi, Siriani e Libanesi. Solo per ragioni tattiche e politiche parliamo dell’esistenza di un popolo palestinese, poiché gli interessi nazionali arabi richiedono la messa in campo dell’esistenza di un popolo palestinese per opporci al sionismo».
Non esiste una storia palestinese prima del 1939 e non si è mai sentito parlare di un popolo palestinese prima del 1967, né che questo fantomatico popolo lottasse contro qualcosa o per qualcosa prima di lottare contro Israele. La stessa Palestina comprende territori giordani (la Cisgiordania) e territori egiziani (la Striscia di Gaza) che Israele aveva conquistato e che ha restituito a Egitto e Giordania, i quali a loro volta li hanno donati a un immaginario popolo palestinese creato solo come ostacolo a Israele.
La formazione di due Stati, lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina, già difficoltosa sulla carta, ha trovato finora insormontabili difficoltà principalmente a causa dei Palestinesi, che mirano non a creare due Stati, ma a inglobare l’intera regione in un loro Stato eliminando del tutto Israele e gli Israeliani, anche se – è doveroso ricordarlo – negli ultimi anni anche Israele ha avuto una progressiva «chiusura» a tutto ciò che non fosse israeliano, isolandosi anche dai suoi tradizionali amici e sostenitori occidentali.
Un esempio tra tutti. Nel luglio 2000, a Camp David, Yasser Arafat, Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, rifiuta lo Stato Palestinese indipendente proposto dal premier israeliano Ehud Barak e dal Presidente Americano Bill Clinton. Due anni dopo, in Israele imperversa la seconda intifada («rivolta», «sollevazione»): lo Stato è investito da un’ondata senza precedenti di attentati esplosivi suicidi sugli autobus, nei bar, nei mercati, contro civili inermi; abitazioni e strade prospicienti i territori governati dall’Autorità Palestinese sono bersagliati da cecchini e da Betlemme i tiratori jihadisti sparano regolarmente contro le case dei vicini quartieri ebraici di Gerusalemme. Il 2 aprile 2002 si giunge a un fatto senza precedenti: decine di terroristi fanno irruzione nella Chiesa della Natività a Betlemme e la occupano con le armi in pugno. Le Forze di Difesa israeliane circondano la basilica e chiedono la resa dei terroristi, che restano asserragliati all’interno trattenendo decine di frati francescani e alcuni civili palestinesi come scudi umani; lo stallo durerà 39 giorni, fino a quando il 10 maggio viene raggiunto un accordo in base al quale i terroristi escono, per essere poi estradati verso Paesi Europei e la Striscia di Gaza. Nello stesso mese di aprile, 23 soldati israeliani muoiono a Jenin durante un’incursione per smantellare una cellula terroristica dentro una fabbrica di bombe: l’attacco è stato sferrato via terra a causa della densità di popolazione di Jenin e della strategia palestinese di posizionare di proposito terroristi e fabbriche di bombe all’interno di aree civili, così da far provocare al nemico un alto numero di vittime civili nel caso di incursioni aeree (ci sono anche casi di numerosi ospedali pagati da altri Stati che vengono usati come prigioni o camere di tortura, ma per chi li vede dall’esterno appaiono come semplici ospedali pieni di pazienti); nello scontro a fuoco muoiono 53 Palestinesi, 48 dei quali sono terroristi armati. Questa moderazione, alla base della strategia detta del «tosare l’erba», prevedeva (ogni volta che Hamas o la Jihad Islamica Palestinese lanciavano missili o attacchi contro Israele) di reagire con attacchi mirati e selettivi per ridurre le capacità terroristiche, distruggere le officine che convertivano forniture teoricamente umanitarie in armi letali o uccidere coloro che fabbricavano razzi e ordigni senza colpire la popolazione civile.
L’apice viene raggiunto il 7 ottobre 2023: per affossare gli Accordi di Abramo, che prevedono la pace, piene relazioni diplomatiche e cooperazione tra Israele e alcuni Stati Arabi in cambio del riconoscimento dello Stato di Israele e del suo diritto a esistere soprattutto da parte dell’Arabia Saudita (che si «trascinerebbe dietro» tutti gli altri Paesi del Golfo), i terroristi di Hamas ricorrono alla loro ultima carta – scatenare un attacco tale da provocare una spropositata reazione da parte di Israele. È la tattica usata da gruppi di partigiani italiani di ispirazione comunista durante la Seconda Guerra Mondiale: costringere il nemico a una rappresaglia talmente ampia e sanguinosa, da provocare contro di esso il sollevamento della popolazione; nel caso qui specifico, c’è la speranza di provocare una tale ondata di indignazione, da portare i Paesi Arabi a unirsi a loro nella lotta armata contro Israele (speranza che si è dimostrata vana, dato che il mito dell’unità araba è, appunto, solo un mito) e di isolare Israele dai suoi alleati occidentali (cosa che si è in parte verificata). Nella mattinata, gruppi armati di Hamas, con il sostegno di altre milizie palestinesi, dalla Striscia di Gaza sfondano il confine con lo Stato di Israele e trucidano 1200 civili e militari, rapendone circa 250: il massacro è avvenuto in località, kibbutz e basi militari nei dintorni della Striscia di Gaza in territorio israeliano, oltre che a un festival musicale, il Nova festival, a cui partecipavano migliaia di giovani. Oltre ai numerosi casi di stupri e violenze sessuali contro donne israeliane, i filmati ripresi dagli stessi terroristi e messi subito in rete mostrano scene di mutilazione e scempio di cadaveri, con una violenza superiore a quella degli stessi nazisti che, se sottoponevano gli Ebrei a fatiche ed «esperimenti scientifici» prima di ucciderli, non ne scempiavano i corpi dopo morti. Alla notizia delle stragi e alla vista delle immagini dei corpi straziati, anche di bambini in fasce, migliaia di Palestinesi scendono per le strade cantando e ballando con folle gioia, e questo li rende complici dei terroristi: un conto è provare una personale intima gioia, seppur malvagia, un conto è esternarla al mondo senza alcun riguardo per le vittime innocenti e le loro famiglie. Israele ha formalmente dichiarato guerra, per la prima volta in 50 anni (l’ultima guerra è stata quella dello Yom Kippur nel 1973), avviando la guerra di Gaza, tuttora in corso.
Israele ha detto che continuerà a combattere fino a quando non avrà completamente eliminato tutti i terroristi di Hamas, e c’è da credere che sia sincero, almeno negli intendimenti. Ma il prosieguo dei combattimenti, e l’aumentare delle vittime civili (su cui non ci sono cifre attendibili, sia perché queste vengono da una fonte totalmente di parte quale Hamas, sia perché molte sono dovute agli stessi terroristi che provocano esplosioni nei loro territori per imperizia militare o che sparano sui loro concittadini che tentano di fuggire dalle zone sottoposte a bombardamenti, quando addirittura non li «giustiziano» nelle strade pubbliche accusandoli di collaborazionismo con il nemico), hanno profondamente scosso parte dell’opinione pubblica occidentale. Così i Palestinesi diventano le «vittime» e gli Ebrei (non solo gli Israeliani) i «sionisti aggressori», in un rigurgito di antisemitismo che sembrava destinato a rimanere solo nei vecchi annali della Storia.
Nessuno ha mai condannato gli Americani quando durante la Seconda Guerra Mondiale hanno raso al suolo intere città tedesche colme di civili (una per tutte: Dresda); o quando hanno sganciato le bombe atomiche sul Giappone, che stava già intavolando trattative per la resa, al solo scopo di scoprirne gli effetti sulla popolazione, uccidendo centinaia di migliaia di persone del tutto inermi. Nessuno ha mai considerato moralmente ignobile la guerra fatta contro l’Irak per liberare il Kuwait negli anni Novanta del secolo scorso. Ma se è Israele a rispondere a un’aggressione, a un odio cieco e folle, allora diventa colpevole.
Sono molti gli Stati che fanno a gara per riconoscere uno Stato di Palestina che non è mai esistito nel passato e non esiste neppure oggi. Uno Stato formato da due tronconi di territori separati l’uno dall’altro: uno dei quali, la Cisgiordania, è amministrato dall’Autorità Nazionale Palestinese, una cricca di politicanti incapaci e corrotti, e l’altro, la Striscia di Gaza, è governato da Hamas, un’organizzazione terroristica che gode di sempre meno simpatie da parte degli stessi Palestinesi.
Per quanto si possa essere favorevoli alla nascita di uno Stato Palestinese, bisogna chiedersi che confini avrà, quale tipo di Governo lo reggerà e con quali credenziali democratiche, quali strutture dovrà avere.
La Palestina oggi non ha nulla che le consenta di divenire uno Stato non solo indipendente, ma soprattutto autonomo: non ha uno straccio di welfare, non ha una politica economica, non ha una moneta o un sistema bancario, non ha un sistema sanitario. Anzi, dipende da Israele per acqua, luce, gas e altro ancora. In più, sta cercando di danneggiare chi la sostiene. Nel mondo animale, chi vive a spese dell’organismo che lo ospita si chiama «parassita». I Palestinesi rischiano di passare per tali. Egitto e Giordania, dopo aver dato loro due pezzi di territorio, hanno chiuso le frontiere e si rifiutano di ospitarli come profughi, per evitare disordini interni. Il Libano ha insegnato qualcosa a proprie spese: negli anni Settanta era il quarto Stato più benestante al mondo, la «Svizzera d’Oriente», con un Governo capace, l’economia più florida del Medio Oriente, un grande dinamismo culturale, un’efficiente rete di servizi e strutture turistiche di prim’ordine; accolse migliaia di profughi palestinesi in fuga dagli Israeliani che sfogarono su di esso la loro rabbia: scavarono tunnel sotterranei, piazzarono depositi di dinamite, fomentarono disordini, scatenarono la guerra civile, divennero un fattore disgregante… in pochi anni, trasformarono il Libano da superpotenza regionale nello Stato del Terzo Mondo che è tutt’ora. I Paesi Arabi possono denunciare Israele, ma nessuno è disposto ad aiutare od ospitare i Palestinesi.
L’Ambasciata di Palestina a Roma ha dichiarato che «i Palestinesi hanno un’identità […] nazionale, araba e umana basata sui valori della conoscenza, della libertà, della virtù e della bellezza. Un’identità […] aperta ed evoluta, che rispetta e mantiene il pluralismo intellettuale, politico e religioso. […] Il senso di appartenenza dei Palestinesi si basa sui valori dell’uguaglianza e libertà. Un patrimonio che contribuisce alla produzione cognitiva dell’intera umanità». Belle parole, ma che cozzano contro la realtà dei fatti che vediamo ogni giorno e che conosciamo dal passato. Ciò non vuol dire che resteranno sempre e solo parole, ma che oggi non c’è nessuno degli elementi politici, economici e soprattutto culturali e «mentali» (basati sulla volontà dell’uomo) che le possano rendere reali. Può darsi che in futuro la Palestina diventi uno Stato non solo indipendente ma anche evoluto, però non è detto che accada durante questa generazione, o la prossima. La Storia ha i suoi tempi, che non sono i tempi dell’uomo. I mesi e gli anni che ci aspettano sono ancora avvolti da una nebbia densa che impedisce di tracciarne una visione. Possiamo solo sperare che si arrivi presto a una soluzione pacifica e condivisa, che liberi Israele dal pericolo terrorista e permetta ai Palestinesi di tracciare un loro cammino nella Storia. Un cammino che, a dispetto di quanto hanno proclamato, non c’è stato nel passato e si può dire che non sia realmente iniziato neppure oggi.