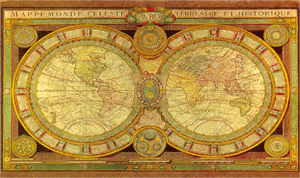Quelli del Mameli: giovanissimi bersaglieri
della Repubblica Sociale Italiana divenuti veterani
combattendo (1944-1945)
Un testo a cura di Antonio Liuzza, con
proemio di Massimo Zamorani, Edizioni Lo Scarabeo, Bologna
2004, 352 pagine
La storia della Seconda Guerra Mondiale sul fronte italiano, che in molti casi ha raggiunto e superato le soglie dell’epopea, dopo un lungo periodo di memorie non certo oggettive della parte vincitrice ha dato voce anche a quelle dei vinti, in un’ottica di pur difficile abbattimento delle polemiche spesso gratuite susseguitesi durante il secolo breve, per approdare alla dignità di testimonianze conformi alla realtà dei fatti, come nel caso dell’impari ed eroica lotta che i Bersaglieri Italiani ingaggiarono sul fronte orientale nell’ultimo periodo della Seconda Guerra Mondiale. Questa testimonianza specifica di Antonio Liuzza, tanto più importante perché prodotta da un giovanissimo Bersagliere Volontario che aveva combattuto valorosamente nelle file del Battaglione «Mameli» assieme alle altre forze piumate per l’ultima difesa del comprensorio isontino, offre un panorama dettagliato del generoso contributo patriottico profuso in quel nobile impegno, con una straordinaria e coinvolgente dovizia di particolari.
Qui è sufficiente rammentare alcune cifre essenziali. A fronte di una struttura operativa del Battaglione in parola, composta da 532 uomini in armi e da sei Ausiliarie, si ebbero 70 vittime, pari al 13% dell’organico (una decina delle quali venne uccisa a guerra finita), 74 feriti, 43 prigionieri, e ben 104 decorazioni al valore, conferite sia da parte italiana che da parte dell’alleato tedesco. Giova aggiungere che, nonostante le condizioni assai difficili in cui il Battaglione doveva operare, sia per l’enorme sperequazione delle forze in campo, sia per il migliore equipaggiamento del nemico, sia per la complessa struttura orografica del territorio, la resistenza italiana non ebbe cedimenti sino al termine del conflitto, quando non vi furono alternative a un tristissimo ammainabandiera finale. Non a caso, il fenomeno delle diserzioni, altrove di entità non indifferente, fu assolutamente marginale, ragguagliandosi a una dozzina di sporadiche vicissitudini personali, maturate soprattutto negli ultimi mesi di guerra, a fronte di un impegno tanto intenso quanto continuativo.
Al pari degli altri commilitoni inquadrati nei diversi Battaglioni del celeberrimo Ottavo Reggimento Bersaglieri, il «Mameli» si distinse per un patriottismo tanto più commendevole, perché nei 16 mesi di appartenenza alla Repubblica Sociale Italiana le sorti del conflitto apparvero sostanzialmente scontate, senza che tale consapevolezza inducesse determinazioni dissociative da uno spirito di corpo che fu sempre esemplare, nel convincimento di non avere alcunché da perseguire, se non l’onore nazionale. Non a caso, nello scorcio conclusivo del conflitto, quando le sorti della guerra iniziarono a precipitare con la rottura del fronte appenninico, diverse decorazioni già statuite dai rispettivi Comandi non ebbero modo di essere materialmente conferite a coloro che le avevano meritate.
A proposito del «Grande Ottavo» si deve porre in luce che la sua Bandiera di Guerra fu oggetto, sempre nel periodo in questione, di parecchie onorificenze collettive, con riguardo specifico a tre Medaglie d’Oro, tre d’Argento e cinque di Bronzo, che si aggiunsero a quella d’Argento già conferita al Reggimento in occasione del terribile terremoto di Reggio Calabria e Messina del dicembre 1908. Si tratta di un ulteriore riconoscimento a integrazione delle medaglie singole, e a testimonianza del grande spirito di corpo che fu prerogativa generalmente riconosciuta all’intero Reggimento e al suo vincolo patriottico con una Patria sofferente come non mai, per non dire del senso dello Stato e della comunità nazionale in cui si riconobbero i suoi protagonisti.
Le cifre in precedenza proposte alle comuni attenzioni consentono qualche altra considerazione integrativa. A esempio, può sorprendere che il numero dei feriti sia stato pressoché uguale a quello dei caduti, confermando l’esistenza di maggiori difficoltà dovute al rapporto con un nemico che in varie occasioni aveva dimostrato la preferenza per uccidere i prigionieri, anziché onorare le convenzioni internazionali in materia. Considerazioni analoghe si possono formulare, in proposito, circa il basso numero dei combattenti catturati e avviati alla prigionia, sia per le ottime capacità operative dei reparti italiani anche nelle operazioni di sganciamento, sia per la ricorrenza dei trattamenti criminali riservati a coloro che, esaurite le munizioni e accerchiati da un nemico largamente maggioritario, si fossero trovati nell’impossibilità di resistere ulteriormente.
I protagonisti dell’epopea in riferimento erano in larga misura giovani, appartenenti alla fascia compresa fra i 18 anni e i 25 anni, pur dovendosi tenere conto che all’epoca la maggiore età si conseguiva al compimento dei 21. Circa il 9% erano addirittura giovanissimi, a cominciare dai 37 diciassettenni nativi del 1928, tra cui i caduti Franco Materazzo (26 settembre 1944), la Medaglia di Bronzo Gino Forato (8 febbraio 1945), e Aribaldo Cattaneo (17 marzo 1945). Non mancavano i sedicenni, quali Sergio Braschi, Albino Dalla Via, Giuseppe Elia e Antonio Liazza (il curatore dell’opera in oggetto), e persino i quindicenni, come Angelo Berlendis ferito a Parma il 26 aprile 1945, Vincenzo Fascetti ferito in Lunigiana il 22 aprile, e Giacomo Turra caduto sempre in Lunigiana nel medesimo fatto d’armi. La presenza di questi giovanissimi tra le reclute combattenti dell’ultima ora, talvolta con il supremo olocausto della vita, costituisce una precisa testimonianza della fede da cui erano animati, che oggi appare quasi inverosimile, e che invece costituisce una testimonianza di altissimo senso dell’italianità e dei «valori non negoziabili».
Dal canto loro, le Ausiliarie impegnate sul fronte in questione, in maggioranza veronesi, furono Tina Artico (23 anni), Rosina Bacchini (26), Zirka Mastini (26), Fiamma Morini (25), Edera Querzola (26) e Alda Vizzotto (20). La più nota di questo gruppo, anche per avere partecipato intensamente, nel dopoguerra e oltre, all’attività volontaria dell’ACSAF (Associazione Culturale del Servizio Ausiliario Femminile), e per avere lasciato il primo incarico nel gennaio 1945 onde trasferirsi, sempre in qualità di Ausiliaria, alle dipendenze della Decima Flottiglia MAS comandata da Junio Valerio Borghese, fu certamente Fiamma Morini. In effetti, anche le Ausiliarie erano generalmente molto giovani, tutte volontarie animate da sano patriottismo e assoluto senso dello Stato e della Patria, e diedero un alto contributo di sangue, soprattutto a guerra finita, quando furono oggetto di nefande persecuzioni, nel segno di ignobili vendette. Al riguardo, basti dire che le Ausiliarie cadute furono circa un migliaio, senza contare quelle che rimasero ignote, e le cui spoglie non poterono essere recuperate.
Con oltre 40 milioni di caduti, la Seconda Guerra Mondiale, come da lucido commento introduttivo proposto da Massimo Zamorani, divenne il più grande e sanguinoso momento collettivo nella storia del mondo. Proprio per questo, pur trattandosi di una «piccola antologia di testimonianze» se non addirittura di «schegge» della cronaca bellica quotidiana, può definirsi quale documento esemplare di una stagione difficile, ma non per questo priva di eroismi e di valori essenziali, come quelli che ebbero luogo nell’Alta Valle dell’Isonzo durante lo scorcio conclusivo del conflitto.
In tutta sintesi, è congruo concludere collocando l’opera in questione nell’ambito di una memorialistica di guerra particolarmente idonea a suffragare l’impegno talvolta eroico della cosiddetta «parte sbagliata» che, secondo la comprensibile interpretazione del curatore, si differenzia da quella «giusta» soltanto perché i suoi uomini non ebbero la ventura di essersi «ritrovati in coda ai vincitori». Se non altro per questo, Antonio Liazza conclude auspicando che, trascorsi tempi ormai ragionevolmente e relativamente brevi, «si scriva e si parli di parti senza distinguere a priori» non solo quella dei vinti e quella dei vincitori, ma soprattutto l’ampia parte di quelli che «rimasero alla finestra» per vedere senza alcun apprezzabile rischio come sarebbe andata a finire, e per imitare gli ignavi di Dante Alighieri che non furono ribelli né fedeli a Dio, ma solo a se stessi.
Benedetto Croce, dall’alto della sua insigne filosofia morale, ebbe ad affermare che la Seconda Guerra Mondiale fu perduta da tutti gli Italiani: ecco una tesi ardita, e tuttavia perfettamente accettabile nella misura in cui si riferisca a comuni meriti, e soprattutto a demeriti, con particolare riferimento a quelli compiuti dopo la fine delle operazioni militari, nel corso di una lunga stagione di vendette, e non certo di pacificazione nazionale. In questo senso, il messaggio alto e solenne del celebre pensatore che fu paladino dell’idealismo e dello storicismo conserva motivi di perenne attualità, inducendo riflessioni non effimere nelle menti e nei cuori degli Italiani di buona volontà, all’insegna di una morale laica pervasa da continui spunti cristiani, e dalla consapevolezza di un imperativo categorico dell’uomo giusto: quello di dover sempre operare, nella buona e nella cattiva fortuna, per il bene comune.