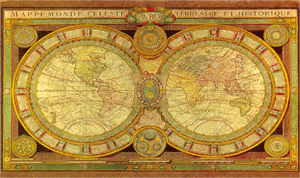Un attentato inutile. Via Rasella. Roma, 23
marzo 1944
Contesto storico. Decisione. Morti.
Rappresaglia. Evidenze
Tra gli episodi che caratterizzarono l’occupazione tedesca a Roma (10 settembre 1943-4 giugno 1944) si colloca pure un attentato attuato a Via Rasella. Furono dei membri dei Gruppi di Azione Patriottica[1] (GAP) a idearlo, malgrado il dissenso espresso da altre forze politiche. L’operazione, avvenuta il 23 marzo del 1944, provocò l’uccisione di 33 soldati tedeschi. Scattò una rappresaglia nella quale morirono 335 persone. In seguito, si verificò un confronto molto acceso tra chi approvò l’operazione e chi la riprovò. Ci furono anche dei processi. Le conflittualità tra opposte fazioni riguardanti l’attentato si sono prolungate nel tempo. Hanno coinvolto gli stessi gappisti, i parenti delle vittime delle Cave Ardeatine, le associazioni partigiane, i comuni cittadini, diversi studiosi, politici e magistrati. Il dibattito si è acuito anche in occasione di alcune medaglie assegnate a ex protagonisti dell’azione partigiana. In tale contesto, l’opinione che a tutt’oggi pare la più diffusa è che l’attentato di Via Rasella fu un’impresa inutile e tragica.
Il 20 settembre del 1943, nel quartiere Parioli (in Via Eleonora Duse), venne attuato un primo attacco partigiano. Un ordigno esplosivo fu utilizzato contro la caserma della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN). Si registrarono morti e feriti. L’operazione, voluta da militanti del Partito d’Azione[2], non venne resa pubblica dal Comando Tedesco. Il giorno seguente furono affissi dei manifesti che intimavano ai civili, pena la morte, la consegna entro 24 ore dei fucili da caccia detenuti.
Il 24 settembre, in ore notturne, si verificarono alcuni scontri nella zona San Giovanni e a Piazza Fiume. Gruppi di partigiani affrontarono i poliziotti in servizio (ora agli ordini del gerarca Guido Buffarini Guidi[3]).
In data 4 ottobre una colonna di automezzi tedeschi in transito venne attaccata da partigiani di «Bandiera Rossa».[4]
Questi chiodi furono disseminati sulle strade di transito delle colonne tedesche (specie quelle dirette al fronte di Cassino).
Un gruppo di partigiani di Pietralata (formazione di «Bandiera Rossa»), il 20 ottobre, assaltò il forte Tiburtino. L’edificio era controllato dai Tedeschi. Il tentativo fu quello di prendere armi, munizioni e viveri. Intervenne un reparto di SS. 22 partigiani caddero prigionieri, tre riuscirono a fuggire, dieci vennero condannati a morte, dopo un processo davanti a un tribunale di guerra tedesco, senza difensori e traduttori, nove furono deportati in Germania con altri 470 antifascisti romani.
Il cappellano militare Don Giuseppe Buttarazzi, il 23 ottobre, venne fucilato per complicità con i partigiani.[5]
Il giorno 25, ufficiali tedeschi rimasero feriti durante un conflitto a fuoco con i partigiani, sulla Via Salaria. Il 28 ottobre furono attaccati (con arma da fuoco e bombe a mano) i militi di guardia alla caserma di Via Brenta. Oltre a questa azione, è da ricordare anche un altro episodio. I GAP lanciarono bombe a mano e spararono con armi leggere contro un corteo di fascisti che transitava per Sant’Andrea della Valle. Furono feriti dodici militi. Venne assalita pure una pattuglia di fascisti in Viale Mazzini, davanti alla scuola Gelasio Gaetani. Nel quartiere di Trastevere e in Piazza Sonnino si registrarono scontri tra partigiani e repubblichini[6]. Un milite fascista venne ucciso nei pressi del ponte che oggi è intitolato a Giacomo Matteotti. Alla fine di ottobre si intensificarono le uccisioni di gerarchi e ufficiali fascisti: un capomanipolo cadde in Corso Umberto, un centurione in Via del Plebiscito, un milite in Piazza Vittorio.
A novembre non riuscì un attentato organizzato al Teatro Adriano (un estintore pieno di tritolo non esplose). Furono distrutti autocarri tedeschi e un automezzo della PAI.[7] Nel mese di dicembre venne ucciso un milite fascista. GAP della IV zona attaccarono una pattuglia tedesca davanti al Teatro dell’Opera, e incendiarono due automezzi. Nell’autorimessa in Via Albalonga occupata dalla Wehrmacht i partigiani incendiarono le autovetture, e lanciarono bombe a mano contro i militari. Morì nell’ospedale San Giovanni un milite fascista ferito dai partigiani alcuni giorni prima. Dal Poligrafico dello Stato, in Piazza Verdi, fu preso di nascosto un notevole quantitativo di carta filigranata per carte annonarie. Servì a realizzare mezzo milione di carte false.
In Via Tasso, durante un interrogatorio, un sottufficiale della Gestapo uccise l’antifascista Aldo Guadagni[8] sparandogli alla nuca. In Via Veneto un gappista uccise un ufficiale tedesco, due fascisti furono soppressi in Via Cola di Rienzo e in Via Donizetti. I partigiani lanciarono una bomba nella trattoria Antonelli (Via Fabio Massimo 101), frequentata da militari tedeschi e da fascisti. Dieci i morti, numerosi i feriti. Una bomba a mano venne lanciata dai gappisti contro i Tedeschi che uscivano dal cinema Barberini. Otto rimasero morti, molti feriti.
Tre ordigni vennero fatti esplodere su altrettanti davanzali delle finestre dell’Albergo Flora, sede del Tribunale Militare Tedesco. I GAP attaccarono una sede militare tedesca in Corso Italia. Attentati con deragliamento dei treni sulle linee ferroviarie Roma-Cassino e Roma- Formia. Venne distrutto il ponte Setteluci sulla Roma- Napoli, provocando la morte di 400 militari tedeschi in avvicendamento dal fronte. Venne fatta esplodere una mina al passaggio di un treno carico di armi e munizioni vicino a Colonna San Cesareo.
A Porta Castello, scambio di colpi d’arma da fuoco tra partigiani e Tedeschi. Fu lanciato un tubo di ferro riempito di esplosivo davanti all’ingresso del carcere di Regina Coeli, mentre 28 Tedeschi stavano effettuando il cambio della guardia. Otto militari morirono per la deflagrazione, altri rimasero feriti. La centralina elettrica situata nel piazzale della stazione Termini venne messa fuori uso.
La situazione che si presentava nei primi mesi del 1944 era articolata. Il 22 gennaio l’intera provincia di Roma fu dichiarata «zona di operazioni». Capo della Gestapo dell’Urbe, e responsabile della gestione dell’ordine pubblico, divenne l’ufficiale delle SS Herbert Kappler. La resistenza si trovava priva di molti membri a motivo di arresti, torture e fucilazioni.[9] Tale realtà fu legata soprattutto all’opera di infiltrati che riuscirono a individuare molti capi partigiani, militanti, tipografi, fabbri. Il 21 gennaio gli Alleati sbarcarono ad Anzio e Nettuno. Si costituì così un secondo fronte (dopo quello di Cassino). Nel frattempo la cronaca continuò a registrare attacchi partigiani in Via del Tritone, in Via Francesco Crispi, in Via dell’Impero, in Via Casilina e a Centocelle. Il 24 gennaio furono fatti evadere da Regina Coeli diversi politici.[10] Il 12 marzo, Pio XII intervenne ufficialmente per condannare la guerra aerea, e per rivolgere alle parti belligeranti l’invito a non rendere Roma un campo di battaglia.[11]
Alle 15.30 Carlo Borsani[12], cieco di guerra, medaglia d’oro, stava ricordando, nel salone di un palazzo in Via Veneto, la nascita del fascismo. Questa era avvenuta 25 anni prima a Milano.[13] In precedenza, i gerarchi e le autorità germaniche avevano partecipato a una Messa nella chiesa di Santa Maria della Pietà, e deposto corone alle lapidi dei caduti fascisti in Campidoglio e al Verano. Alle 15.52 Borsani venne interrotto da forti deflagrazioni. Diciotto chili di tritolo erano esplosi a poca distanza, in Via Rasella, davanti a Palazzo Tittoni. In quel momento, transitava a piedi una compagnia dell’11ª Compagnia del III battaglione del Polizeiregiment «Bozen».[14]
La formazione militare era comandata da un maggiore boemo, Johann «Hans» Dobek. Composta da 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e truppa. Marciava in assetto di guerra, con mitragliatrici montate su carrelli in testa e in coda alla colonna. Tutti indossavano divise della Polizia Tedesca.
A far brillare la mina collocata in un carrettino metallico da spazzino fu Rosario Bentivegna[15] (22 anni; studente in medicina), con la copertura di Carla Capponi[16] (25 anni; impiegata in un laboratorio chimico). L’effetto dell’esplosione fu accresciuto dalle successive indotte esplosioni di granate che i soldati avevano alla cintola. Subito dopo l’esplosione della mina, alcuni gappisti lanciarono quattro bombe a mano, e spararono con armi leggere. I 12 attentatori, protagonisti dell’operazione, rimasero illesi e sfuggirono alla cattura. Il 20 settembre del 1944, si sposarono Bentivegna e la Capponi.
A causa dell’esplosione morirono 26 uomini del Polizeiregiment «Bozen». Altri decessi si verificarono in ore successive per le ferite riportate. Alle ore 8 del mattino del 24 marzo si contarono 32 morti e 105 feriti.
In tale contesto, occorre ricordare pure la morte di un dodicenne (Piero Zuccheretti[17]). Con lui rimasero uccise altre persone (in maggioranza colpite dal fuoco di reazione tedesco): Antonietta Baglioni (anni 66; domestica a Palazzo Tittoni; colpita alla testa da un proiettile dopo essersi affacciata alla finestra; rimase in agonia per 15 giorni), Pasquale Di Marco[18] (anni 34; colpito per caso), Enrico Pascucci (partigiano, Movimento Comunista d’Italia), Antonio Chiaretti (partigiano, Movimento Comunista d’Italia), Erminio Rosetti (anni 20; autista del questore; ucciso dai Tedeschi perché non era in divisa e aveva una pistola in mano). Tra i civili si contarono 11 feriti. Nelle memorie del capitano dei carabinieri, Matteo Mureddu[19], che in quel periodo operava presso il Quirinale, sono riportati i nomi di quattro donne che, con «i visi e i vestiti zuppi di sangue», e di cui una con «un occhio quasi fuoruscito dall’orbita», si erano rifugiate presso le scuderie del Quirinale in cerca di aiuto. Si trattava delle sorelle Margherita Aliotti in Mollo e di sua sorella Elena, di Vincenza Angelina Mollo in Ricci e di sua figlia Adele (ventenne). Erano sfollate da San Giovanni Incarico.[20]
Nel periodo dell’occupazione tedesca erano in vigore le normative germaniche, unitamente a diversi proclami e a prassi consolidate. In caso di attacchi sanguinosi era prevista la rappresaglia. Esistono al riguardo alcuni esempi che qui di seguito si riportano.
– Il 23 settembre del 1943 venne fucilato per rappresaglia il vice brigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto[21] (a Palidoro, vicino a Roma).
– Il 31 gennaio del 1944 fu annunciata, in rappresaglia per l’uccisione di un soldato tedesco e il ferimento di un secondo, la fucilazione di dieci prigionieri avvenuta a Forte Bravetta (Roma).
– Sempre in rappresaglia per attacchi partigiani nel centro città, il 2 febbraio – nel Forte citato – seguì un’altra esecuzione di undici prigionieri.
– Il 5 marzo un gappista uccise un soldato tedesco a Centocelle (Piazza dei Mirti). Due giorni dopo a Forte Bravetta furono fucilati per rappresaglia dieci prigionieri, tra cui i tre gappisti Giorgio Labò, Guido Rattoppatore e Vincenzo Gentile. I Tedeschi annunciarono l’avvenuta rappresaglia tramite un comunicato.
Era quindi ampiamente noto il fatto che i Tedeschi, in caso di attentati sanguinosi, eseguivano una rappresaglia.
Anche nell’episodio di Via Rasella venne decisa un’immediata rappresaglia. Considerando i 32 morti, gli alti comandi della Wehrmacht stabilirono il numero di prigionieri da fucilare secondo una proporzione di dieci per ogni soldato ucciso.
Dopo l’emanazione di detto ordine, si verificò il decesso di un trentatreesimo militare (Vinzenz Haller). Si aggiunsero così altri prigionieri alla lista di chi doveva essere eliminato. L’intera operazione di rappresaglia fu diretta dal Tenente Colonnello delle SS Herbert Kappler.[22]
Tra il pomeriggio del 23 e la mattina del 24, numerosi Ebrei furono arrestati da bande fasciste. Vennero tradotti a Regina Coeli per poi essere eliminati (con altri Ebrei già prigionieri al momento dell’attentato) alle Cave Ardeatine.[23]
Già dalle ore 12 del 24 marzo, si ebbe il concentramento di quanti dovevano essere eliminati. Questi furono condotti fuori dalle celle di Via Tasso, e radunati con le mani legate dietro la schiena. Non venne comunicata alcuna informazione su quanto attendeva le vittime. Kappler e il capitano Schütz[24] volevano prevenire reazioni incontrollate da parte dei prigionieri. Per questo motivo, il loro comportamento rimase segnato da incertezza e segretezza. Inoltre, per tutta la durata dell’operazione, Kappler evitò ogni contatto proveniente dall’esterno (telefonate, messaggi, visitatori). Poco prima delle 14 la colonna degli autoveicoli con i prigionieri si mise in movimento. Raggiunse la Via Ardeatina. Qui si trovavano le cave di tufo, luogo delle esecuzioni (suggerito dal capitano Kohler). Alle 15.30 arrivarono anche i prigionieri provenienti da Regina Coeli.
Dopo le 15.30 ebbero inizio le eliminazioni. I condannati, in gruppi di cinque, furono condotti nelle gallerie illuminate da soldati tedeschi muniti di torce elettriche. All’entrata di questi ambienti, il capitano Priebke[25] richiedeva il nome al condannato, e controllava la lista. Poi le vittime venivano fatte inginocchiare, e gli esecutori sparavano un colpo di pistola dall’alto in basso all’altezza del collo.[26] Kappler prese parte al secondo turno di eliminazione; il capitano Priebke invece sparò con il terzo turno. Alla fine della rappresaglia, i Tedeschi lasciarono nel fondo di due gallerie due enormi cumuli di cadaveri che occupavano uno spazio di circa 5 metri di lunghezza, 3 di larghezza e 1,50 di altezza. Le salme, quando vennero alla fine ritrovate, non apparivano distinte ma ammucchiate, sovrapposte, strette le une alle altre, del tutto irriconoscibili. Dopo il massacro, i Tedeschi minarono il sito, facendolo esplodere allo scopo di eliminare le prove della strage.
Nell’eccidio vennero uccise 335 persone. Si arrivò a questo numero perché cinque uomini, catturati per errore, furono comunque assassinati. I vari gruppi di condannati si possono identificare come segue.
– 154 persone a disposizione dell’Aussenkommando, soggetti a un’inchiesta di polizia;
– 23 in attesa di giudizio del Tribunale Militare Tedesco;
– 16 persone già condannate dallo stesso tribunale a pene varianti da 1 a 15 anni;
– 75 appartenenti alla comunità ebraica romana;[27]
– 40 persone a disposizione della Questura romana[28] fermate per motivi politici;
– 10 fermate per motivi di pubblica sicurezza;
– 10 arrestate nei pressi di Via Rasella;
– una persona già assolta dal Tribunale Militare Tedesco;
– sette persone tuttora non identificate.
I caduti più giovani furono i quindicenni Michele Di Veroli (3 febbraio 1929) e Duilio Cibei (8 gennaio 1929), e i diciassettenni Franco Di Consiglio (21 marzo 1927) e Ilario Canacci (12 febbraio 1927). Il più anziano fu Mosè Di Consiglio (74 anni).
Sono state 328 le salme identificate[29] (su un totale di 335). Da questo esame è stato possibile ricavare alcuni dati che qui di seguito si elencano.
– Circa 39 erano ufficiali, sottufficiali e soldati appartenenti alle formazioni clandestine della Resistenza Militare;[30]
– circa 52 erano gli aderenti alle formazioni del Partito d’Azione[31] e di Giustizia e Libertà;[2]
– circa 55 appartenevano a «Bandiera Rossa»;[33]
– 19 erano fratelli massoni (tra cui 3 anarchici tutti iscritti all’Unione Sindacale Italiana: Manlio Gelsomini, Umberto Scattoni e Mario Tapparelli) appartenenti indistintamente sia all’Obbedienza di Palazzo Giustiniani, sia a quella di Piazza del Gesù;[34]
– 75 erano di religione ebraica.[35] Fu completamente sterminata la famiglia Di Consiglio. Persero la vita in sei (Mosè, Marco, Franco, Santoro, Salomone e Cesare) di cui il più giovane, Franco, aveva appena compiuto diciassette anni;
– altri, fino a raggiungere il numero previsto, furono detenuti comuni.
Non mancarono tuttavia tra gli uccisi i rastrellati a caso, e gli arrestati a seguito di delazioni dell’ultim’ora, come il giovane pugile ebreo Lazzaro Anticoli detto «Bucefalo».[36] Fu tradito da una correligionaria, Celeste Di Porto.[37] Finì alle Cave Ardeatine al posto del fratello della giovane.
Almeno nove furono le vittime straniere. Si tratta di: Giorgio Leone Blumstein (nato a Leopoli, banchiere ebreo; 49 anni), Salomone Drucker (nato a Leopoli, commerciante ebreo), Sandor Kereszti (29 anni; nato a Budapest, giornalista cattolico), Boris Landesman (nato a Odessa, commerciante ebreo), Bernard Soike (biografia ignota), Marian Reicher (Ebreo Polacco, nato a Kolomyja), Eric Heinz Tuchman (nato a Magdeburgo, Ebreo Tedesco), Paul Peisach Wald e Schachne Wald (il primo nato a Berlino, il secondo in Polonia).
Tra le vittime dell’eccidio delle Cave Ardeatine ci fu anche un sacerdote pugliese: Don Pietro Pappagallo. Nato a Terlizzi (in provincia di Bari) nel 1888. Quinto di otto fratelli. Ordinato prete il 3 aprile 1915 a Molfetta. Il 26 novembre 1925, con il permesso del suo Vescovo, si trasferì a Roma per studiare diritto canonico, e per svolgere qualche attività pastorale più continuativa. Pochi mesi dopo ricevette l’incarico di assistere gli operai del convitto della società CISA Viscosa nel quartiere Prenestino di Roma. Qui espresse critiche per le tristi condizioni di lavoro degli operai, e dovette alla fine lasciare l’incarico.
Nel settembre del 1928 venne assegnato a San Giovanni in Laterano come viceparroco. Potendo rimanere ancora a Roma, fu nominato (novembre 1929) cappellano e direttore spirituale delle Suore Oblate del Bambino Gesù (il loro istituto era nei pressi di Santa Maria Maggiore). Don Pappagallo, per motivi pratici, andò a vivere in Via Urbana 2. Nel novembre 1930 fu incardinato nella diocesi di Roma. Ricevette la nomina a chierico beneficiario della basilica liberiana. Divenne segretario del Cardinale Bonaventura Cerretti (arciprete di Santa Maria Maggiore) fino alla morte di quest’ultimo (1933).
Fu pure membro della commissione preposta alla sistemazione logistica dei pellegrini attesi a Roma per l’anno santo straordinario del 1933. Per tutto quel periodo Don Pappagallo accolse più giovani, specie quelli di Molfetta e Terlizzi.
Dopo l’8 settembre 1943, anche su sollecitazione di Gioachino Gesmundo[38], suo compaesano ed ex allievo, militante del Partito Comunista, mise a disposizione la sua abitazione a militari sbandati, nonché a perseguitati per motivi politici o razziali, offrendo ospitalità e documenti falsificati. In questo impegno Don Pappagallo trovò appoggio nelle suore di Nostra Signora di Namur[39], che avevano una casa in Via Urbana.
Il Tenente Colonnello Kappler venne a sapere delle attività di Don Pietro da una donna che si faceva chiamare «contessa». Questa era andata dal sacerdote a chiedere aiuto. Poi lo tradì per una somma di denaro. Il fatto fu rivelato da Kappler nell’interrogatorio dell’8 giugno 1948.[40] Questa delatrice non fu l’unica a segnalare il prete. Come ha scritto Andrea Riccardi in L’inverno più lungo[41], a costare l’arresto e poi la vita a Don Pietro fu la delazione di Gino Crescentini, disertore, figlio della proprietaria dell’albergo Littorio, un luogo di collaborazionisti situato proprio in Via Urbana vicino alle suore.
Crescentini, dopo aver ricevuto aiuto da religiosi, nascosto nel convento di Cosma e Damiano, una volta uscito tradì per denaro Don Pietro, conosciuto in precedenza. Dopo la Liberazione, Crescentini venne arrestato e condannato su denuncia della governante di Don Pietro.
Don Pietro subì l’arresto il 29 gennaio 1944. Venne rinchiuso nel carcere di Via Tasso (cella numero 13). Fu perquisita la sua abitazione. Non si trovò, comunque, la lista con i nomi delle persone protette (a tutt’oggi non è noto il numero).
Sulla sua prigionia ci sono alcune testimonianze del suo compagno di cella Oscar Caggegi.[42] Questi ha raccontato di una prigionia dura, in cui il sacerdote, privato del breviario, sottoposto al dileggio al grido di corvo nero, umiliato fino alla nudità nella convinzione che nascondesse documenti addosso, assisteva i detenuti provati da interrogatori brutali, uno dei quali lo stesso Don Pietro aveva subito al momento dell’arresto.[43]
Dopo l’attentato di Via Rasella, Don Pietro Pappagallo venne alla fine trasportato con gli altri detenuti da eliminare in località Cave Ardeatine. Qui trovò la morte. In tempi recenti, questo sacerdote è stato proclamato «Giusto tra le Nazioni» per il sostegno dato agli Ebrei.[44]
Negli anni successivi all’attentato di Via Rasella, e all’eccidio delle Cave Ardeatine, si sviluppò un confronto acceso tra i sostenitori dell’azione partigiana e quanti accusarono i gappisti di aver provocato inutilmente la morte di centinaia di persone. In tale contesto, e preso atto che le azioni partigiane si collocavano in un movimento di Resistenza, sembra utile rivedere gli obiettivi che gli attentatori si erano prefissi.
1) Lo scopo immediato dell’azione fu quello di colpire l’esercito tedesco.
2) Si tentò poi di «scuotere» la popolazione romana che era ritenuta passiva.
3) Si volle, infine, dimostrare una presenza partigiana capace di operare nelle situazioni più rischiose.
Nel periodo in cui si svolse l’operazione partigiana a Via Rasella, l’esercito tedesco era impegnato su due fronti. Per questo motivo qualsiasi attentato a Roma non avrebbe provocato un arrivo di forze tedesche nell’Urbe, indebolendo in tal modo le posizioni germaniche a Cassino (sconfitte nel maggio del 1944), e nelle aree vicine ad Anzio e Nettuno. Occorre poi sottolineare il fatto che la morte dei soldati altoatesini non aveva indebolito il nucleo operativo delle forze tedesche posizionate a Roma. Queste mantenevano inalterata la forza operativa, con molti capi della Resistenza Romana arrestati.
Di ciò, ne è prova a esempio: la fucilazione di Don Giuseppe Morosini[45], e il rastrellamento del Quadraro (17 aprile 1944): 744 persone (tra i 16 e i 55 anni) furono deportate in Germania per lavori forzati, altre finirono in carcere.[46]
In tale contesto, si colloca pure un ulteriore episodio. Gugliemo Blasi, gappista già impegnato in numerose azioni, anche in Via Rasella, venne arrestato per furto. Gli furono trovati in tasca documenti tedeschi falsificati. Per salvarsi, si offrì di collaborare con la banda Koch. Ne entrò a far parte. Riuscì a far arrestare Carlo Salinari, Pietro Calamandrei, Roul Falcioni, Duilio Grigioni, Luigi Pintor, Silvio Serra.
Nei giorni successivi furono arrestati il Generale Filippo Caruso[47] (comandante di una formazione partigiana degli autonomi), il colonnello Caratti e il capitano dei carabinieri Geniola. In Piazza della Libertà vennero bloccati dalla polizia nazifascista il Generale Odone e il colonnello Scalera dopo un conflitto a fuoco nel quale persero la vita i carabinieri partigiani Salvatore Meloni ed Enrico Zuddas.
Da parte di taluni partigiani si riteneva necessario attivare un tipo di azione che fosse in grado di «spronare» in qualche modo la popolazione romana. Tale ragionamento si basava su presupposti deboli. La gente che in quel periodo viveva nell’Urbe non era assolutamente interessata a partecipare a un conflitto con le forze tedesche di occupazione. Al contrario, si preferiva una linea attendista (sostenuta dal Vaticano) sperando in un rapido arrivo degli Alleati.
Unitamente a ciò, in molti istituti religiosi e anche in abitazioni private erano nascosti Ebrei, ma anche oppositori politici e renitenti alla leva e al lavoro coatto.[48] C’era quindi un interesse diffuso a conservare uno «status quo», pur precario, capace di non far precipitare ulteriormente la situazione del tempo, specie dopo la deportazione in Germania di quasi 2.000 carabinieri[49], la razzia di più di 1.000 Ebrei avvenuta il 16 ottobre del 1943, e gli arresti (specie di Ebrei) avvenuti a causa di delatori.
Anche l’idea di dimostrare una combattiva presenza partigiana nell’Urbe si dimostrò poco attenta alle dinamiche circostanti. I resistenti del tempo, infatti, non risultavano un’entità capace di azioni unitarie. Esistevano idee differenti tra i rappresentanti dei partiti politici presenti nell’Urbe.[50] Giuseppe Spataro[51] (Democrazia Cristiana), nella giunta militare «manifesta[va] in ogni occasione la necessità di osservare cautela per non provocare le rappresaglie».[52] Inoltre, un dirigente della Democrazia Cristiana si oppose senza successo alla proposta di Giorgio Amendola[53] di inserire, in un documento del Comitato di Liberazione Nazionale ai partigiani, la precisazione secondo cui bisognava colpire il nemico anche «negli uomini».[54]
Esistevano anche dei confronti accentuati all’interno del Partito Comunista Italiano. Già la cronaca del partito aveva registrato, tra il 1941 e il 1943, una dura dialettica tra Amendola e Palmiro Togliatti.[55] C’erano state delle reciproche critiche sul rapporto tra rivoluzione e riformismo. Adesso Togliatti stava ritornando dalla Russia (marzo 1944), e Amendola era interessato a mostrare al leader la propria capacità direzionale.[56] Unitamente a ciò, non si può dimenticare il fatto che il centro comunista di Milano[57] aveva rimproverato al Partito Comunista Italiano romano[58] una scarsa attività partigiana.
C’erano, poi, altri problemi. I membri di «Bandiera Rossa» rimanevano autonomi rispetto ai comunisti e al Comitato di Liberazione Nazionale. Inoltre, alcune formazioni politiche non erano preparate sul piano militare.
Un altro aspetto significativo riguardò i militari. Il Fronte Militare Clandestino, guidato dal colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo[59], aveva come diretto interlocutore il legittimo Governo Italiano, e con lui concordava le strategie.
In tale contesto, lo stesso Montezemolo, ucciso poi alle Ardeatine, per evitare rappresaglie da parte nazista sui civili vietò di compiere attentati dinamitardi e omicidi contro i Tedeschi.
Scrisse in particolare: «Nelle grandi città la gravità delle conseguenti rappresaglie impedisce di condurre molto attivamente la guerriglia». La nota, che fa parte di un ordine di operazioni intitolato «Direttive per l’organizzazione e la condotta della guerriglia» (10 dicembre 1943), prosegue: «Vi assume preminente importanza la propaganda atta a mantenere nelle popolazioni spirito ostile ed ostruzionistico verso il Tedesco, propaganda che è compito essenzialmente dei partiti; e l’organizzazione della tutela dell’ordine pubblico, compito militare sia in previsione del momento della liberazione, sia per l’eventualità che il collasso germanico induca l’occupante ad abbandonare improvvisamente il territorio italiano».[60]
In definitiva, l’azione di Via Rasella non fu, a livello politico-operativo, un’iniziativa corale. Rimane solo un’operazione dei GAP.
L’azione di Via Rasella fu rivendicata dal Partito Comunista Italiano con un comunicato dei GAP, datato 26 marzo. Il testo venne pubblicato su «L’Unità» clandestina del 30 marzo. Il 31 dello stesso mese, per iniziativa del socialista Pietro Nenni[61], Bonomi[62] accettò di scrivere a nome del Comitato di Liberazione Nazionale una nota. Tale documento attestava indignazione e protesta verso l’eccidio avvenuto presso le Cave Ardeatine. Il testo costituì un compromesso. Anche se venne diramato sulla stampa clandestina a metà aprile, si operò una scelta. Per nascondere l’esitazione e il dissenso interni venne retrodatato al 28 marzo.
L’operazione partigiana fu, in anni successivi, riconosciuta come atto legittimo di guerra dal Governo e dal Parlamento Italiano, e dalla magistratura. Ad alcuni ex gappisti venne assegnata una medaglia al valore.[63]
A distanza di anni dall’attentato di Via Rasella, che cosa rimane dopo tante polemiche? Resta una riflessione. Quella sull’opportunità o meno di attivare un attentato che, come era prevedibile, avrebbe causato un altissimo numero di vittime tra i civili. Si inserisce qui un commento di una signora ebrea. La incontrai in un convegno promosso dalla Comunità Ebraica di Roma (2002) nel salone sottostante il Tempio Maggiore Ebraico.[64] Si parlò anche di Via Rasella e dell’eccidio delle Cave Ardeatine. Questa donna, che aveva da una parte un’amica e dall’altra chi scrive, seguì i lavori in silenzio. Solo alla fine, alzandosi dalla sedia, disse all’improvviso: «Se vuoi fare l’eroe fallo con la tua pelle, non con quella degli altri».
Alle ore 9 del 25 marzo, Monsignor Mario Nasalli Rocca di Corneliano[65] incontrò Pio XII. E lo informò sul fatto che alcuni prigionieri del carcere romano di Regina Coeli erano stati uccisi. Non poté però indicare né il luogo, né le modalità del massacro. Il 6 maggio del 1974, questo ecclesiastico (divenuto Cardinale) fece una dichiarazione significativa di cui si riporta qui di seguito il testo.
«Sono stato confessore dei detenuti di Regina Coeli, nel 1944 ed anche prima, e fui anche confessore dei condannati a morte. Io mi recavo a Regina Coeli ogni giorno e posso dire che verso le 23 del 24 marzo 1944, un agente di custodia mi disse, con aria un po’ strana, di andare al quarto braccio, ove erano i prigionieri politici.
Appena giunto lì, fui accolto dai detenuti, maschi e femmine, – dato che le porte delle celle non erano tutte chiuse, – con alte grida e, gli stessi – con aria spaventata – mi chiesero se per caso non vi fosse un’altra esecuzione, dato che in quello stesso giorno erano stati portati via moltissimi prigionieri, ai quali era stato detto che andavano a lavorare, mentre poi avevano appreso che erano stati fucilati.
Rimasi sbalordito ed incredulo, e dagli agenti di custodia mi fu confermata la notizia della esecuzione senza però sapermi precisare altri particolari. Rimasi in carcere fino alle 7 del mattino seguente, 25 marzo, e verso le ore 9, per ragioni del mio ufficio, essendo “prelato vicino”, mi recai dal Pontefice Pio XII (da solo) e gli comunicai quanto avevo appreso al carcere.
Il Santo Padre si portò le mani al capo, in atteggiamento di stupore e dolore, e disse: “Cosa mi dice mai!”, dandomi chiaramente a manifestare di nulla sapere di quanto era avvenuto.
Mi recai, poi, da Monsignor Tardini[66] – prosegretario di Stato – il quale si mostrò all’oscuro di tutto, dandomi convulsamente incarico di attingere notizie di particolari dettagli, che però, non potetti sapere. Posso assicurare che a nessun sacerdote, e tantomeno a me, fu chiesto di assistere spiritualmente i giustiziandi.
A fine maggio 1944 io assistetti, poco prima che fosse ucciso, tale Franco Sabelli[67], una SS italiana, che fu presente all’esecuzione delle Fosse Ardeatine. Da questi appresi che tra i giustiziandi vi era un sacerdote, Don Pappagallo, al quale era stata offerta la possibilità di non essere incluso nella lista, ma egli aveva risposto che voleva seguire la sorte degli altri, ai quali impartì l’assoluzione».[68]
Nel 1980 la Libreria Editrice Vaticana pubblicò il decimo volume degli Atti e documenti della Santa Sede relativi alla Seconda Guerra Mondiale. Vi si trova un’informativa catalogata con il numero 15. Nel testo si fa riferimento a un non meglio identificato Ingegner Ferrero[69], del Governatorato di Roma. Questi informò per telefono dell’attentato la Segreteria di Stato Vaticana il 24 marzo, alle ore 10.15 (circa cinque ore prima dell’inizio del massacro delle Cave Ardeatine). Si riporta qui di seguito la trascrizione dell’episodio.
«L’Ingegner Ferrero, del Governatorato di Roma, dà i seguenti particolari circa l’incidente di ieri: il numero delle vittime tedesche è di 26 militari; tra i civili italiani si lamentano tre o quattro morti; non è facile ricostruire la scena dato che tutti si sono dati alla fuga; alcuni appartamenti sono stati saccheggiati e la polizia tedesca ha preso l’assoluto controllo della zona senza permettere ingerenza di altre autorità; sembra ad ogni modo che una colonna di automezzi tedeschi attraversando Via Rasella abbia la responsabilità di aver provocato gli Italiani che poi avrebbero lanciato delle bombe dall’edificio di fianco al Palazzo Tittoni; finora sono sconosciute le contromisure: si prevede però che per ogni Tedesco ucciso saranno passati per le armi 10 Italiani. L’Ingegner Ferrero spera di dare più tardi maggiori particolari».[70]
Questo documento è significativo perché è caratterizzato dall’incertezza. Fa esplicito riferimento a Via Rasella, ma afferma che non sono note le contromisure tedesche. L’unico canale in quel momento efficiente era Padre Pancrazio Pfeiffer[71] il quale, essendo stato compagno di scuola del Generale Kurt Mälzer[72], comandante la città di Roma, aveva la possibilità di avere qualche informazione sull’eventualità di una rappresaglia. Ma nella mattina del 24 marzo, tutti gli uffici e i comandi tedeschi erano chiusi. Quindi il Padre Pancrazio non poté avvicinare Kappler (al quale doveva tra l’altro consegnare la domanda di grazia per il Generale Simone Simoni).[73]
Tra gli scritti riguardanti l’attentato di Via Rasella, si colloca anche quello di Rolf Hochhuth.[74] Nel 1964, questo autore definì l’iniziativa dei GAP «un atto inutile e vile».[75] In tempi successivi, Pino Loperfido, in un suo scritto su «trentinomese.org» (2004) cita anche il parere di Norberto Bobbio.[76] Si riporta qui di seguito il passo che interessa. «Senza consultare la Giunta Militare della Resistenza e all’insaputa degli altri partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, il GAP dà avvio a quello che Norberto Bobbio definirà, nel 1984, “il più grosso errore della Resistenza”. Già, un errore. Non solo perché porterà alla tremenda carneficina delle Fosse Ardeatine, ma perché segnerà di lì in poi una recrudescenza nel sistema repressivo tedesco, un cambio di atteggiamento nei confronti delle popolazioni più indifese. Pensiamo alle stragi, Marzabotto e Sant’Anna di Stazzema “in primis”.
È lecito supporre che senza questo inutile attentato si sarebbero risparmiate migliaia di vite umane?
“Inutile”, certo. A che pro, infatti, uccidere soldati nemici con mansioni di sorveglianza, in una città che sta per essere liberata pacificamente, quando sai benissimo che per ogni avversario caduto, a dieci dei tuoi verrà chiesta la vita? Perché un’azione del genere quando il giorno prima, il 22 marzo, il direttore de “Il Messaggero”, Bruno Spampanato[77], scrive che il comando tedesco avrebbe ritirato a breve le sue truppe da Roma? Un’altra domanda senza risposta».[78]
Sulla stessa linea si posizionerà anche lo storico militare Pierluigi Romeo di Colloredo Mels.[79] Questo autore, nel suo libro su Kesserling, ha scritto tra l’altro: «Via Rasella era stata militarmente inutile: i Romani non si erano ribellati, la battaglia per Roma non era stata accorciata di un sol giorno».[80]
G. Angelozzi Gariboldi, Pio XII, Hitler e Mussolini, Mursia, Milano 1988
M. Avagliano e M. Palmieri, Le vite spezzate delle Fosse Ardeatine. Le storie delle 335 vittime dell’eccidio simbolo della Resistenza, Einaudi, Torino 2024
E. A. Cicchino e R. Olivo, Via Rasella. L’azione partigiana e l’eccidio delle Fosse Ardeatine 23-24 marzo 1944, Nordpress Edizioni, Chiari 2007
M. Crippa, Il dibattito politico (inutile) su Via Rasella. Galli della Loggia dirada la nebbia, in: «Il Foglio», 4 aprile 2023
L. Iaquinti, Via Rasella e le Fosse Ardeatine. Una storia da riscrivere?, Ginevra Bentivoglio Editori, Roma 2013 (Luigi Iaquinti è nipote di Antonio Chiaretti, un passante che morì in Via Rasella)
A. Lepre, Via Rasella. Leggenda e realtà della Resistenza a Roma, Laterza, Bari-Roma 1996
P. Maurizio, Via Rasella. 80 anni di menzogne, Maurizio Edizioni, Fregene 2023
A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Feltrinelli, Milano 2012.
Fondo Bentivegna-Capponi, e Fiorenti-Ottobrini, in: Archivio Storico del Senato della Repubblica. Fondo Famiglia Calamandrei Regard, in: Archivio Storico del Senato della Repubblica. Archivio Museo della Liberazione (Roma, Via Tasso). Bundesarchiv di Koblenz, serie Bild 101 I/312/983. Archivio Luce, Roma (documenti del Fondo «Combat film» tra i quali quelli relativi alla fucilazione del questore Pietro Caruso, con l’accusa, tra le altre, di aver fornito ai Tedeschi una lista di persone da fucilare dopo l’attentato di Via Rasella. Accanto a queste ci sono le immagini del processo contro i responsabili dell’eccidio che si concluse con la condanna di Herbert Kappler). Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Centro Documentazione Territoriale «Maria Baccante», Archivio Storico Viscosa.
Tenente Arrigo Paladini (†). Esercito Italiano. Subì carcere e torture a Via Tasso (Roma). Divenne poi direttore del Museo della Liberazione di Via Tasso.
1 I Gruppi d’Azione Patriottica si formarono per iniziativa del Partito Comunista Italiano. Erano dei piccoli nuclei partigiani, costituiti dal comando generale delle Brigate Garibaldi. Ogni nucleo era formato da quattro o cinque persone (uomini e donne). I GAP operavano nelle azioni di guerriglia urbana.
2 Il Partito d’Azione fu un partito politico fondato nel 1942 e sciolto nel 1947. Di ispirazione antifascista e liberal-socialista.
3 Guido Buffarini Guidi (1895-1945). Ministro dell’Interno nella Repubblica Sociale Italiana. Corresponsabile dell’eccidio delle Cave Ardeatine (era a Roma in quei giorni). Fucilato il 10 luglio 1945.
4 La denominazione ufficiale era Movimento Comunista d’Italia, conosciuto con il titolo del suo giornale, «Bandiera Rossa». Tale organizzazione, di ispirazione marxista leninista, non condivideva la linea del Partito Comunista Italiano. Di questo, respingeva la politica di unità nazionale con i partiti antifascisti borghesi, e la mancanza di democrazia all’interno del partito.
5 L’ex tenente cappellano Don Giuseppe Buttarazzi (1906-1943), nativo di Monte San Giovanni Campano, dopo l’8 settembre si era aggregato a un gruppo di «Bandiera Rossa». Il nucleo operava sulle zone montagnose di Capranica Prenestina. Assisteva gli ex prigionieri alleati e alcuni giovani braccati dai nazifascisti. Sorpreso a fare dei segnali con una lanterna presso Guadagnolo (frazione di Capranica), il sacerdote venne arrestato e torturato. Fu ucciso a colpi di mitra.
6 Fascisti aderenti alla Repubblica Sociale Italiana.
7 Polizia Africa Italiana.
8 Militante di «Bandiera Rossa». Fu gettato dal terzo piano di Via Tasso per simulare un suicidio.
9 Vengono catturati importanti esponenti del Partito di Azione (tra cui il capo dell’organizzazione militare del partito, Pilo Albertelli), numerosi militanti di «Bandiera Rossa», il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo (1901-1944; comandante del Fronte Militare Clandestino) insieme ai suoi più stretti collaboratori, nonché vari fra i più attivi militanti del Partito Comunista Italiano, tra i quali Giorgio Labò e Gianfranco Mattei.
10 24 gennaio 1944, Alessandro Pertini, detto Sandro (1896-1990), e Giuseppe Saragat (1898-1988), futuri Presidenti della Repubblica, vennero fatti evadere dal carcere di Regina Coeli insieme a cinque loro compagni di prigionia socialisti. Erano stati arrestati il 18 ottobre 1943, e rinchiusi nel braccio nazista del carcere romano, condannati a morte in attesa dell’esecuzione.
11 Discorso di Sua Santità Pio XII ai profughi di guerra rifugiatisi in Roma e agli abitanti dell’Urbe, domenica 12 marzo 1944. «Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, VI, Quinto anno di Pontificato, 2 marzo 1944-1° marzo 1945», pagine 5-9, Tipografia Poliglotta Vaticana.
12 Carlo Borsani (1917-1945).
13 In Piazza San Sepolcro.
14 Polizeiregiment «Bozen», già Polizeiregiment «Südtirol» (e in seguito SS-Polizeiregiment «Bozen»). Si trattava di un reparto militare della Ordnungspolizei. Venne costituito in Alto Adige (autunno 1943), nel periodo dell’occupazione tedesca della regione (Zona d’Operazioni delle Prealpi).
15 Rosario Bentivegna (1922-2012).
16 Carla Capponi (1918-2000).
17 Piero Zuccheretti (all’anagrafe Pietro; 1931-1944). Anni 12. Apprendista presso un negozio di ottica in Via degli Avignonesi.
18 Pasquale Di Marco. Falegname. Nato a Civitella del Tronto. Deceduto il giorno successivo all’attentato all’ospedale San Giovanni.
19 Matteo Mureddu, nato a Nuoro nel 1907. Era membro del Fronte Clandestino di Resistenza dei carabinieri.
20 M. Mureddu, Il Quirinale del Re, Feltrinelli, Milano 1977, pagina 141.
21 Salvo D’Acquisto (1920-1943: Venerabile). P. L. Guiducci, Salvo D’Acquisto. Una morte per la vita. Il contesto storico. La figura del vice brigadiere Salvo D’Acquisto. Il sacrificio. La memoria, Educatt, Milano 2023.
22 Herbert Kappler (1907-1978). Ufficiale delle SS e comandante della polizia tedesca a Roma.
23 A. Foa, Portico d’Ottavia 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno del ’43, capitolo 5, Laterza, Bari Roma 2013.
24 Karl Theodor Schutz, capitano dell’Aussenkommando der Sicherheitpolizei.
25 Erich Priebke (1913-2013), ufficiale tedesco, capitano delle SS e membro della Gestapo a Roma.
26 In questo modo si riteneva di ottenere una morte immediata.
27 La comunità ebraica romana era stata già colpita con la razzia del 16 ottobre 1943.
28 Il questore era Pietro Caruso (1899-1944).
29 Identificò le salme delle Cave Ardeatine il Professor Attilio Ascarelli (1875-1962) con i suoi collaboratori. In seguito, altri resti vennero identificati.
30 Tra le vittime vi furono 12 carabinieri, tra ufficiali, sottufficiali e appuntati carabinieri. F. Martinelli, I carabinieri durante l’occupazione nazista. Da Fertilia alle Fosse Ardeatine, in: «Historia», luglio 1961.
31 D. Intreccialagli, Mario Intreccialagli, calzolaio. Il Partito d’Azione, le fosse Ardeatine, la memoria, Controluce, Monte Compatri 2022.
32 AA.VV., Le formazioni Giustizia e Libertà nella Resistenza, atti del Convegno, Milano 5-6 maggio 1995, Fiap, Roma 1995.
33 S. Antonini, La storia di «Bandiera Rossa» nella Resistenza Romana, in: «Patria Indipendente», ANPI, 16 dicembre 2009, pagina 29 e seguenti.
34 F. Guida, I martiri massoni delle Fosse Ardeatine, Gagliano Edizioni, Bari 2019.
35 AA.VV., Le Fosse Ardeatine. Dodici storie, Gangemi, Roma 2020.
36 Lazzaro Anticoli (1917-1944). A. De Caprio, Bucefalo il pugilatore, Infinito Edizioni, Formigine 2025.
37 Celeste Di Porto (1925-1981). G. Pederiali, Stella di Piazza Giudìa, Giunti, Firenze 1995.
38 Gioachino Gesmundo (1908-1944). A. Lisi, L’altro martire di Terlizzi: Gioacchino Gesmundo, raccolta di documenti e testimonianze, Comune di Terlizzi, «Quaderni della Biblioteca» numero 8, Arti Grafiche Nobili Sud, Santa Rufina di Città Ducale 1993 (riedizione nel 2006).
39 Le Suore di Nostra Signora di Namur sono state inserite tra i «Giusti tra le Nazioni» per aver salvato Ebrei durante le persecuzioni tedesche a Roma.
40 L’8 giugno 1948, Herbert Kappler fu interrogato dal Tribunale Militare Territoriale di Roma durante il processo per l’eccidio delle Fosse Ardeatine.
41 A. Riccardi, L’inverno più lungo, Laterza, Bari-Roma 2008.
42 Oscar Cageggi, capo della Banda «Vespri».
43 Intervista a Oscar Cageggi, in: «Il Quotidiano», 26 giugno 1944.
44 A. Lisi, Don Pietro Pappagallo. Un Eroe un Santo, Libreria Moderna, San Donà di Piave 1996.
45 Don Giuseppe Morosini (1913-1944). Ottenne da un ufficiale della Wehrmacht, assegnato al comando posto nel monte Soratte, il piano delle forze tedesche sul fronte di Cassino. Fu tradito da un delatore (un certo Dante Bruna, infiltrato dalla Gestapo tra i partigiani, che fu ricompensato con 70.000 lire). Venne arrestato il 4 gennaio del 1944.
46 W. De Cesaris, La borgata ribelle. Il rastrellamento del Quadraro e la resistenza popolare a Roma, Odradek, Roma, 2004. C. Guidi, Operazione Balena Unternehmen Walfisch, Edilazio, Roma, 2013. F. Sirleto, Quadraro: una storia esemplare. Le vite e le lotte dei lavoratori edili di un quartiere periferico romano, Ediesse, Napoli 2006.
47 Generale Filippo Caruso (1884-1979). Comandante del Fronte clandestino di Resistenza dei carabinieri, noto come Banda Caruso. Insignito di medaglia d’oro al valor militare a vivente.
48 Confronta anche: G. Loparco, Gli Ebrei negli istituti religiosi a Roma (1943-1944) dall’arrivo alla partenza, in: «Rivista di storia della Chiesa in Italia», anno LVIII, numero 1, gennaio-giugno 2004.
49 A. M. Casavola, Carabinieri tra resistenza e deportazioni. 7 ottobre 1943-4 agosto 1944, Studium, Roma 2021.
50 Il Comitato di Liberazione Nazionale si era costituito a Roma dal 9 settembre 1943. A dirigere la lotta nell’Urbe c’era una giunta militare. Vi facevano parte rappresentanti del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito d’Azione, della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale Italiano, e del partito Democrazia del Lavoro. Di fatto, le operazioni partigiane erano attivate dai partiti di sinistra.
51 Giuseppe Spataro (1897-1979).
52 Lettera di Giorgio Amendola al centro del Partito Comunista Italiano di Milano, Roma, 20 gennaio 1944, in: L. Longo (a cura di), I centri dirigenti del Partito Comunista Italiano nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma 1973, pagina 243.
53 Giorgio Amendola (1907-1980). Dall’aprile 1943 partecipò alla Resistenza. Membro del Partito Comunista Italiano, e delle Brigate Garibaldi. Di queste, fece parte del Comando Generale insieme a Luigi Longo, Pietro Secchia, Gian Carlo Pajetta e Antonio Carini. A lui facevano riferimento i GAP che operavano nel centro di Roma. Nel 1944 fu anche membro designato dal Partito Comunista Italiano per la Giunta Militare Antifascista del Comitato di Liberazione Nazionale.
54 Lettera di Giorgio Amendola al centro del Partito Comunista Italiano di Milano, Roma, 20 gennaio 1944, in: L. Longo (a cura di), I centri dirigenti del Partito Comunista Italiano nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma 1973, pagina 320.
55 Palmiro Togliatti (1893-1964).Tra i fondatori del Partito Comunista d’Italia (1921). Di questo organismo ne fu segretario e leader dal 1927 fino al 1964, con un’interruzione dal 1934 al 1938, durante la quale fu il rappresentante all’interno del Comintern (organizzazione internazionale dei partiti comunisti).
56 U. Finetti, Togliatti e Amendola. La lotta politica nel Partito Comunista Italiano. Dalla Resistenza al terrorismo, Ares, Milano 2008.
57 Luigi Longo (1900-1980) e Pietro Secchia (1903-1973).
58 Mauro Scoccimarro (1895-1972) e Giorgio Amendola.
59 Colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo (1901-1944).
60 Confronta al riguardo: A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito, Donzelli, Roma 1999. G. Pisanò, Storia della Guerra Civile in Italia, CED, Roma 1964, tomo I.
61 Pietro Nenni (1891-1980). Leader storico del Partito Socialista Italiano.
62 Ivànoe Bonomi (1873-1951). Fu presidente del Comitato di Liberazione Nazionale.
63 Nel 1950 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi (1874-1961), su proposta del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi (1881-1954), conferì ai partigiani dei GAP Rosario Bentivegna e Franco Calamandrei la medaglia d’argento al valor militare per l’attacco di Via Rasella. Anche altri gappisti furono decorati: Lucia Ottobrini, Mario Fiorentini, Maria Teresa Regard, Ernesto Borghesi, Marisa Musu, Pasquale Balsamo, Carlo Salinari. A Carla Capponi venne assegnata una medaglia d’oro.
64 G. Mogavero, I muri ricordano. La guerra e la Resistenza a Roma: epigrafi e memorie (1943-1945), Massari Editore, Bolsena 2002.
65 Monsignor Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1903-1988). Ricevette la consacrazione episcopale il 20 aprile 1969. Per decenni svolse attività come assistente ecclesiastico del Circolo San Pietro, e come cappellano del carcere di Regina Coeli. Paolo VI lo creò Cardinale nel 1969.
66 Monsignor Domenico Tardini (1888-1961). Creato Cardinale nel 1958.
67 Franco Sabelli, giovane romano di padre italiano e madre tedesca. Nazista convinto. Dopo l’8 settembre 1943 si arruolò nelle SS. Al termine della guerra venne condannato per collaborazionismo e fucilato a Forte Bravetta il 26 giugno 1945.
68 G. Angelozzi Gariboldi, Pio XII, Hitler e Mussolini, Mursia, Milano 1988, pagine 245-246.
69 Aveva in quel momento il ruolo di commissario prefettizio (governatore era Francesco Boncompagni Ludovisi).
70 «Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale (ADSS)», volume 10, Le Saint Siège et les victimes de la guerre. Janvier, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1980, documento 115, «Notes de la Secrétairerie d’Etat, Récit de l’attentat de la Via Rasella. Contremesures encore incertaines», pagine 189-190.
71 Padre Pancrazio Pfeiffer (1872-1945). Superiore generale della Società del Divin Salvatore.
72 Kurt Mälzer (1894-1952).
73 Generale di Divisione Simone Simoni (1880-1944). Membro del Fronte Militare Clandestino.
74 Rolf Hochhuth (1931-2020). Scrittore. Drammaturgo. Sceneggiatore.
75 R. Hochhuth, Delucidazioni storiche, in: Idem, Il Vicario. Dramma in 5 atti, Feltrinelli, Milano 1964 [1963], pagine 407-487.
76 Professor Norberto Bobbio (1909-2004). Filosofo. Giurista. Storico. Senatore a vita dal 1984 alla morte. Nel 1943 (ottobre) aderì al Partito d’Azione clandestino. È considerato tra i maggiori teorici del diritto, e tra i più importanti filosofi italiani della politica nella seconda metà del Novecento (XX secolo).
77 Bruno Spampanato (1902-1960).
78 https://www.trentinomese.it/blog/files/Via-rasella-1944.html.
79 Pierluigi Romeo di Colloredo Mels (nato nel 1966). Archeologo e storico militare. Autore di numerosi lavori sulla storia delle due guerre mondiali e dei conflitti del periodo interbellico (Etiopia e Spagna), e delle unità della MVSN, argomento del quale è considerato uno dei maggiori esperti a livello internazionale.
80 P. Romeo di Colloredo Mels, Kesselring: una biografia militare dell’Oberbefehlshaber Süd, 1885-1960, Tomo II (1944-1960), Luca Cristini Editore, E SPS-071, Bergamo 2020.