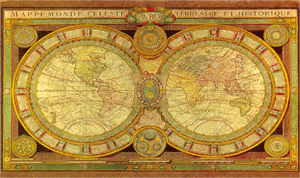Per un ricordo propositivo: il ruolo del 10
febbraio
Le ragioni per una continuità della legge
istitutiva del Ricordo, a vent’anni dalla sua promulgazione
Il prossimo 30 marzo 2024 si compie il primo ventennio dall’approvazione della Legge 30 marzo 2004 numero 92, istitutiva del Ricordo di tutti i martiri infoibati o altrimenti massacrati dai partigiani titoisti durante la guerra del 1941-1945, e di un’adeguata Memoria delle «complesse vicende del confine orientale». In tale ricorrenza, l’occasione è congrua per fare il punto sul ruolo di quella legge, sulla realizzazione dei suoi scopi, e sugli auspici per la sua più efficace continuità, lungi da ogni tentazione meramente ripetitiva. Ciò, nello spirito di un provvedimento voluto dal legislatore italiano dopo un sessantennio di attesa, e finalmente suffragato da una volontà pressoché generale, testimoniata dalla larghissima maggioranza con cui il Parlamento della Repubblica Italiana seppe approvare il disegno di legge in questione, dovuto quale primo proponente all’Onorevole Roberto Menia, figlio di esuli.
La scelta del 10 febbraio come data idonea al Ricordo, pur nella presenza di altre che sarebbero state ugualmente pertinenti, fu ponderata e condivisa per una ragione molto semplice: l’anniversario dell’iniquo trattato di pace firmato nel 1947, con cui l’Italia volle rinunciare alla propria sovranità sulla Dalmazia e su gran parte della Venezia Giulia, pari al 3% del territorio nazionale. Con tale atto, si premiava – oltre ogni limite oggettivo – uno Stato come la Repubblica Federativa Jugoslava che non aveva fatto mistero della sua volontà di perseguire una vera e propria pulizia etnica, realizzata promuovendo l’esodo di 350.000 cittadini italiani e il «genocidio programmato» (come da lucida definizione del grande patriota Italo Gabrielli) di almeno 20.000 vittime[1] colpevoli della propria inderogabile italianità, e soltanto di quella.
Non poche «vulgate» insistono nell’affermare che quelle persecuzioni non furono casuali, dovendosi interpretarle alla luce di una «motivata reazione alle violenze italiane» che ovviamente non mancarono come in tanti altri conflitti all’ultimo sangue, ma che non sono assimilabili al suddetto disegno di conquista, tanto pervicace e tanto violento, come non era accaduto nemmeno al tempo della dura presenza asburgica. Non a caso, l’esodo coinvolse oltre nove decimi della popolazione italiana residente, con le sole eccezioni di persone anziane, malate e sole che non ebbero la possibilità né la forza di muoversi, e con quelle di un numero piuttosto esiguo di appartenenti al movimento comunista che sognavano la luce dell’avvenire.
In Venezia Giulia e Dalmazia, non certo casualmente, l’incidenza delle vittime sul totale della popolazione residente fu superiore, spesso di parecchio, a quella rilevata nelle altre zone italiane. Inoltre, diversamente da quanto era accaduto nell’Unione Sovietica e negli altri suoi satelliti dell’Europa Orientale, le forze agli ordini di Tito non rappresentavano la Jugoslavia ufficiale perché il suo Governo legittimo era stato quello in esilio a Londra, sin quasi alla fine della guerra, quando il Primo Ministro Winston Churchill riconobbe ufficialmente il nuovo regime[2].
Diversamente da quanto sarebbe accaduto per Germania e Giappone, che firmarono la resa soltanto durante il 1945 (rispettivamente nei mesi di maggio e di agosto), il Regno d’Italia era uscito dal conflitto con largo anticipo grazie all’armistizio del 3 settembre 1943, reso noto cinque giorni più tardi, e un mese dopo divenne «cobelligerante» degli Alleati. Tuttavia, alla fine della guerra ciò non valse a prevenire gli effetti della sconfitta militare, compendiati nella perdita delle colonie, del Dodecaneso, di Briga e Tenda, e soprattutto di Venezia Giulia e Dalmazia, con evidente vantaggio principale proprio dal punto di vista di Tito. Il leader di Belgrado ebbe modo di sedersi al tavolo della pace con la protervia di un vincitore assoluto, dimostrata sin dalla conclusione delle operazioni belliche con l’occupazione di Fiume, di Pola e della stessa Trieste, dove le sue milizie – pur nell’ambito dei «40 giorni» compresi tra gli inizi di maggio e la prima decade di giugno – si affrettarono, come altrove, a compiere violenze tradottesi nella scomparsa di troppi Italiani incolpevoli (alcune migliaia).
Questa pagina di storia, ormai incontrovertibile, suffraga a più forte ragione l’idoneità del «Giorno del Ricordo» a proporsi come riferimento permanente alla grande tragedia collettiva culminata nel «Diktat» del 10 febbraio, quando gli Alleati Occidentali, ancor prima dello stesso Giuseppe Stalin, si affrettarono a compiacere proprio Tito ignorando il «grido di dolore» del popolo giuliano, istriano e dalmata, e cancellando – con un semplice tratto di penna – millenni di presenza latina, e poi italica, sull’altra sponda dell’Amarissimo.
Oggi, dopo l’ingresso di Slovenia e Croazia nell’Unione Europea, la volontà di avviare rapporti di normale collaborazione con queste nuove Repubbliche, e con tutte quelle che avevano fatto parte della vecchia Jugoslavia, è cosa compiuta. L’obiettivo raggiunto potrà essere più facilmente consolidato a fronte di un riconoscimento esauriente e completo delle ragioni e dei torti, con riguardo prioritario al trattato italo-jugoslavo di Osimo, che nel novembre 1975, chiudendo le questioni ancora in essere, intese cedere a Belgrado, senza contropartite a favore di Roma, la cosiddetta Zona «B» del vecchio Territorio Libero di Trieste. Del resto, il medesimo Territorio Libero di Trieste non era mai stato costituito formalmente, per cui, almeno dal punto di vista nominale, la sovranità italiana vi era rimasta in essere sin dal 1954, anno della cosiddetta «restituzione».
A vent’anni dalla Legge istitutiva del Ricordo, costellata da tante celebrazioni che sono andate sviluppandosi soprattutto nell’ambito delle scuole, implementando una conoscenza dei fatti non ancora esaustiva, unitamente a quella delle idee da cui avevano tratto origine, è tempo di un primo bilancio. Non si tratta di una conclusione necessariamente negativa, se non altro alla luce di comunicazioni meno effimere circa i valori del grande sacrificio giuliano, istriano e dalmata, ma non certo interamente positiva, alla stregua di visibili momenti di mancata informazione su cui è necessario continuare ad agire, con perseveranza e convinzione. Del resto, un Ricordo efficace, e quindi degno del suo spirito maieutico, è veramente tale se contribuisce a diffondere la conoscenza della storia, e con essa, un salutare «risveglio delle coscienze».
Nella nuova Francia democratica che era subentrata all’esperienza autoritaria dell’ultimo Napoleone dopo il disastro della guerra contro la Prussia (1870) che aveva dato luogo al sacrificio di Alsazia e Lorena, per non dire della tragica esperienza della Comune che gli aveva fatto seguito, si era diffuso l’uso, sostanzialmente irredentista, di rammentare quel dramma con l’invito a «pensarci sempre e non parlarne mai» nell’attesa di tempi migliori, che si sarebbero puntualmente manifestati mezzo secolo più tardi. Dal canto suo, l’Italia del secondo millennio, inserita nel sistema europeo sotto la guida di una compagine governativa finalmente idonea a far sentire la sua voce «coeteris paribus», non ha bisogno di proporre rivendicazioni che non siano quelle compatibili con la sua consolidata vocazione cristiana, e quindi con l’obbligo in primo luogo morale di non dimenticare le tristi imposizioni del 1947, coniugandole con la matura fede nella verità e nella giustizia, di cui gli esuli offrirono prove davvero tangibili.
In questo senso, la profezia di Monsignor Antonio Santin[3], il grande Vescovo di Trieste degli anni bui, si è andata realizzando almeno in parte, nel momento in cui «le vie dell’iniquità» hanno dimostrato di «non essere eterne» restituendo un’aggiornata validità al pensiero del celebre Presule, nuove speranze al popolo dell’esodo, e nuova fiducia in uno spirito europeo conforme alla logica del 10 febbraio, che dopo lungo e non facile avviamento sta dimostrando di avere fatto presa ormai maggioritaria nelle coscienze dei cittadini di un Vecchio Continente sempre più propenso a seguire, lungi da ogni tentazione contraria, le vie della comprensione, del rispetto e della giustizia.
1 Le cifre in riferimento corrispondono a quelle, ormai convenzionali, riportate dalla storiografia prevalente, pur non mancando valutazioni ampiamente riduttive, soprattutto di parte jugoslava, senza dire di altre indicazioni che, invece, sono sensibilmente maggiori, e tra le quali è congruo citare, a titolo di esempio, la lunga introduzione di Guido Deconi all’opera di AA.VV., Slovenia 1941-1952: anche noi siamo morti per la Patria, Associazione per la sistemazione dei Sepolcri tenuti nascosti, Lubiana 2000, pagine LXVI-792, dove le stime ufficiali sono oggetto di motivato dissenso, e di un dettagliato aggiornamento del numero complessivo di Italiani colpiti dalla diaspora e dalle uccisioni indiscriminate, notevolmente superiore al mezzo milione.
2 Con tipica astuzia levantina, Tito riuscì nell’intento non solo in quanto naturale alleato dell’Unione Sovietica, ma nello stesso tempo perché ebbe modo di utilizzare a proprio vantaggio le divisioni in essere tra le altre forze jugoslave in campo, come gli indipendentisti sloveni, i cetnici legati al Governo Monarchico in esilio, gli ustascia croati (alleati dell’Asse solo sulla carta) e via dicendo. In effetti, il contributo di Tito alla vittoria era stato circoscritto a quello del suo movimento, ma egli ebbe l’intuito di proporsi quale vessillifero di una nuova unità jugoslava che nella realtà esisteva solo sulla carta, come sarebbe stato dimostrato dagli eventi successivi alla sua scomparsa. A cose fatte, Churchill si accorse dell’errore che aveva compiuto, ma ormai era tardi per porvi rimedio.
3Monsignor Antonio Santin (Rovigno 1895-Trieste 1981), dopo cinque anni di esercizio dell’incarico episcopale a Fiume, dove fu insediato nel 1933 quando era appena trentottenne, venne trasferito alla Cattedra Triestina di San Giusto durante il 1938, quasi in concomitanza con la promulgazione delle leggi razziali, sulla cui antitesi al Verbo Cristiano si espresse con naturale immediatezza. Poi, visse il periodo bellico, l’occupazione jugoslava del maggio-giugno 1945 e la lunga vigenza del Governo Militare Alleato (chiusa nel 1954) con affettuosa e paterna vicinanza al proprio gregge, sottoposto a prove durissime. Al nome del Vescovo Santin è legata, fra l’altro, la realizzazione del grande Tempio Mariano di Monte Grisa, sul Carso Triestino, quale voto del Presule per l’affrancamento del capoluogo giuliano dal dominio dell’ateismo di Stato.