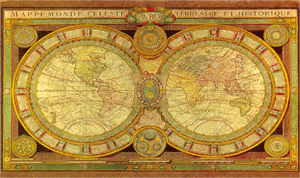Il confine orientale italiano dall’Unità al
nuovo millennio
Storia dell’assenza secolare dello Stato e
degli effetti conseguenti
Da almeno un secolo e mezzo, il confine orientale italiano, che storicamente ha insistito dalle Alpi Giulie al Golfo del Carnaro e alla Dalmazia, è stato oggetto di vicende particolarmente complesse, che del resto sono state riconosciute come tali anche dalla Legge 30 marzo 2004 numero 92, istitutiva del Ricordo. Si tratta di una storia che è stata oggetto d’interpretazioni non sempre convergenti, ma da cui emerge oggettivamente una pervicace penalizzazione dei diritti e degli interessi legittimi di parte italiana, assistita da perseveranti atteggiamenti rinunciatari cui non è possibile attribuire una matrice casuale, se non altro per le loro iterazioni.
Nel lontano 1866, la Terza Guerra d’Indipendenza, conclusa con la «gloriuzza» di Lissa esorcizzata solo in parte dalle nuove imprese garibaldine, diede luogo all’annessione del Veneto «girato» all’Italia da parte francese, ma la Venezia Giulia e l’Istria rimasero austriache, nella generale costernazione dei patrioti che avevano sognato l’abbraccio con Roma e l’affrancamento dall’autocrazia asburgica, inutilmente sognato per tutto il Risorgimento, se non anche dall’epoca dei lumi, nel pensiero di Gian Rinaldo Carli. Il peggio avvenne più tardi a seguito dello smacco di Tunisi, e della sua regione acquisita inopinatamente dalla Francia, quando l’Italia si vide costretta alla nuova Triplice Alleanza con Austria e Germania, che a molti parve innaturale, e che avrebbe ulteriormente coartato le speranze di quei patrioti per un altro quarantennio. Considerazioni analoghe si potrebbero formulare per le prime suggestioni coloniali concluse nel disastro di Adua del 1896, cui si sarebbe rimediato soltanto in parte nel nuovo secolo con l’acquisizione della Libia, cui non fu certamente estraneo lo sfascio dell’Impero Ottomano.
La Prima Guerra Mondiale, che a molti parve correttamente costituire la conclusione del Risorgimento, si chiuse con il «sole» di Vittorio Veneto, il cui splendore fu altrettanto giustamente assimilato a quello che aveva salutato Napoleone ad Austerlitz. Nondimeno, le trattative in sede di conferenza della pace furono gestite dalla delegazione italiana – guidata da Vittorio Emanuele Orlando e da Sidney Sonnino – in modo poco ortodosso se non anche velleitario, in specie quando decise di assentarsi dai negoziati per circa due mesi in segno di pur motivata protesta, ma lasciando campo libero alle pretese altrui, con l’effetto prioritario di cancellare definitivamente il Patto di Londra che Antonio Salandra aveva firmato nel 1915 alla vigilia della discesa in campo da parte italiana, a dieci mesi dall’inizio del conflitto.
Ne trasse origine il cosiddetto mito della «Vittoria Mutilata» che peraltro aveva già acquistato il carattere di una triste realtà, tradotta nella rinuncia a tutta la Dalmazia – con la sola eccezione della piccola «enclave» di Zara – statuita a Versailles il 10 settembre 1919. A quel punto, non fu certamente un caso che, appena due giorni dopo, il Comandante Gabriele d’Annunzio avesse guidato la Marcia di Ronchi, alla testa dei suoi «Giurati» e del piccolo esercito legionario, conquistando Fiume l’indomani stesso fra l’immenso tripudio popolare, dopo avere abbattuto la «barra» di Cantrida davanti allo sguardo attonito dei Generali Sabaudi. Analogamente, non fu un caso che, due mesi più tardi, il movimento legionario, sorto sulle ali dell’entusiasmo per l’impresa dannunziana, immediatamente accresciuto da tanti volontari e diventato espressione di una nuova Italia finalmente libera e consapevole dei propri diritti, avesse coraggiosamente iterato la sfida di Ronchi, occupando anche una parte ragguardevole del territorio dalmata, grazie al colpo di mano dell’Ammiraglio Enrico Millo, anch’egli Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Col trattato di Versailles l’Italia riconobbe la nuova Jugoslavia sorta dal disfacimento dell’Impero Asburgico per iniziativa degli Alleati Occidentali, e segnatamente di Francia e Gran Bretagna. Con quella firma la Monarchia di Vittorio Emanuele III accettava la cancellazione delle garanzie «segrete» che avevano presieduto al suo ingresso nel conflitto, e subiva la creazione di un nuovo Stato confinante dove non si faceva mistero di ricorrenti mire nazionaliste sull’Istria, Fiume e la stessa Trieste, rese meno teoriche dalla sostanziale acquiescenza dei suddetti Alleati nei confronti della soluzione adottata per la Dalmazia, che rimaneva irredenta e che diede vita al grande «esodo dimenticato» dei suoi cittadini italiani: fenomeno tanto più ragguardevole tenuto conto che costoro, diversamente da quanto avevano fatto sotto il pur pesante Governo Austriaco, preferirono lasciare in modo quasi plebiscitario le loro città, le loro apprezzate professioni, le proprie dimore e i sepolcri degli avi, pur di non subire l’avvento della sovranità jugoslava, con quello che ai loro occhi assumeva le ovvie sembianze del tradimento, premessa dell’ostracismo da cui sarebbero stati colpiti laddove avessero deciso di accettarlo: cosa impossibile!
Il tentativo dannunziano, in un primo momento, parve destinato a trovare ascolto nei connazionali migliori, nel cui ambito furono tanti gli Italiani che accorsero a Fiume per mettersi al servizio della causa legionaria. Peraltro, la mossa del Vate non ebbe successo per l’opposizione governativa, costringendo il Comandante a proclamare, nel settembre 1920, la Reggenza Italiana del Carnaro. Nella sostanza, si trattava di uno Stato indipendente che, tra l’altro, si sarebbe dato una Costituzione particolarmente avanzata sul piano dei doveri, ma nello stesso tempo su quello dei diritti, con particolare riguardo ai riconoscimenti per le donne, i lavoratori, i combattenti e gli stessi alloglotti, mentre si riprometteva di penalizzare i proprietari «infingardi» onde riportarli sulla buona strada dell’investimento produttivo. Nonostante le ottime intenzioni, il tentativo ebbe vita breve perché sopravvenne il trattato di Rapallo con cui l’Italia dell’ultimo Giolitti istituiva lo Stato Libero di Fiume d’accordo con la neonata Jugoslavia, e non esitava a promuovere lo scontro armato con i Legionari: un vero e proprio episodio di guerra civile, passato alla storia con la pertinente denominazione di «Natale di Sangue» ma protrattosi per un’intera settimana (24-31 dicembre) con parecchie decine di vittime da entrambe le parti.
Il confronto fu naturalmente impari, tanto che la «Città Olocausta» venne costretta a subire il bombardamento delle navi «giolittiane», ed ebbe termine con la resa dei Legionari, motivata dalla necessità di non spargere altro sangue fraterno, e con il «Commiato fra le tombe» nel Camposanto di Cosala, pronunciato dal Comandante in onore di tutti i caduti (3 gennaio 1921) prima della partenza dei suoi uomini (nei cui confronti l’accusa primigenia di sedizione non ebbe seguito) e del suo volontario esilio «dorato» nell’eremo del Vittoriale, in agro di Gardone Riviera (Brescia) dove avrebbe vissuto sino alla morte (1° maggio 1938) in sintonia solo apparente col regime fascista[1].
Dal canto suo, il Governo Mussolini, salito al potere dopo la Marcia su Roma (28 ottobre 1922), già dall’anno successivo, in occasione dell’incidente di Janina in cui erano caduti quattro militari italiani, a cui aveva fatto seguito l’occupazione temporanea di Corfù, si fece premura di dare un segnale immediato circa l’interesse italiano per le questioni orientali, reso più concreto dall’accordo con la Jugoslavia del 27 gennaio 1924 che chiuse anche formalmente la breve esperienza autonomista di Fiume e rese operativa la sua annessione, lasciando alla controparte il sobborgo di Susak e lo scalo marittimo di Porto Baross. Parve una svolta, ma gli anni successivi furono caratterizzati da un difficile mantenimento dello «status quo» in cui l’Italia fu impegnata in un aspro confronto con l’irredentismo slavo e i suoi ripetuti conati terroristici.
Le residue speranze degli esuli dalmati si andarono spegnendo soprattutto negli anni Trenta, quando il rapporto fra Belgrado e Roma divenne progressivamente più disteso. Non a caso, nel 1935 l’Ambasciatore Italiano Guido Viola di Campalto avrebbe affermato che il suo Governo coltivava sentimenti amichevoli e non intendeva turbare lo sviluppo e l’integrità della Jugoslavia, mentre un anno dopo il Presidente del Consiglio Milan Stojadinovic ottenne adeguate garanzie sul fatto che l’Italia considerava ormai chiusa ogni rivendicazione territoriale, avendo dato evidente preferenza all’espansione coloniale in Africa. Nel 1937, le intese di buon vicinato furono codificate a più alto livello con la firma del trattato di collaborazione fra i due Paesi, apposta dallo stesso Stojadinovic e dal Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano. In realtà, il Governo Italiano aveva bisogno di mani libere, sia per la politica coloniale sia per quella balcanica, dove la questione albanese stava assumendo una rilevanza ormai prevalente. Peraltro, resta indubitabile che le concessioni alla Jugoslavia ebbero carattere sostanzialmente unilaterale, e che, non appena le circostanze lo avessero consentito, Belgrado si sarebbe affrettata a dissociarsi, come accadde nella primavera del 1941, a guerra già iniziata anche da parte italiana, quando la Jugoslavia decise improvvisamente di cambiare campo schierandosi nella nuova guerra a fianco degli Alleati Occidentali e creando un nuovo fronte d’impegno bellico per le forze dell’Asse[2].
Nondimeno, proprio a causa della defezione belgradese, promossa da ambienti militari molto vicini alla Gran Bretagna, la maggior parte della Dalmazia fu trasferita sotto la sovranità italiana proprio nel 1941, con l’importante eccezione di Ragusa. La guerra ebbe termine nel giro di poche settimane, ma nella realtà fu soltanto l’inizio, perché rapidamente seguita da una lunga guerriglia fino al «ribaltone» del 1943, culminato nell’armistizio dell’8 settembre. In sostanza, quella della Dalmazia «italiana» fu una parentesi effimera, rapidamente travolta dalla nuova Jugoslavia a prevalente trazione titoista che, grazie alla soverchia disponibilità degli Alleati e al progressivo dissolvimento delle capacità difensive del Regno d’Italia, ebbe modo di conseguire una facile vittoria anche sul Moverno Monarchico in esilio a Londra, e sulle limitate forze militari cetniche favorevoli al vecchio regime, il cui leader Draza Mihajlovic sarebbe stato fucilato dai comunisti a guerra finita.
La conferenza della pace, iniziata a Parigi nell’estate del 1946, si protrasse per parecchi mesi sino alla firma del trattato di pace che chiuse le lunghe trattative il successivo 10 febbraio nella capitale francese. L’Italia, come il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi pose in evidenza sin dall’inizio, fu costretta a confrontarsi con un’assemblea ostile, fatta eccezione per la «personale cortesia» di alcuni delegati; d’altro canto, la sconfitta non era stata parzialmente elisa nemmeno dalla cosiddetta «cobelligeranza» a fianco degli Alleati, successiva all’armistizio, dando luogo alla posizione di una subalternità davvero ineludibile. Per di più, qualche opportunità marginale di verdetti meno pesanti fu condizionata negativamente dall’atteggiamento dei delegati italiani che non seppero o non vollero rivolgere a proprio vantaggio le divisioni ancora più forti intervenute fra gli Alleati medesimi, con particolare riguardo a quelle fra l’Unione Sovietica e gli Stati Occidentali: ciò, fino al punto di rinunciare anche all’ipotesi di un plebiscito popolare cui conferire le decisioni conclusive circa le sorti di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Certamente, fu un’altra occasione perduta nella lunga storia dell’Alto Adriatico.
Sin dal giugno 1946, De Gasperi aveva dichiarato, riscuotendo le soddisfazioni dei patrioti, che l’Italia non avrebbe mai sottoscritto un trattato di pace che le togliesse Pola e le altre città istriane, dando per scontate le perdite di Fiume e della Dalmazia: era una buona intenzione, ma destinata al confronto perdente con un realismo politico indotto dalla concomitanza di parecchi interessi alternativi, in specie di natura economica, come quelli collegati alle esigenze della ricostruzione post-bellica e degli investimenti.
In altri termini, le buone intenzioni iniziali furono vanificate dalla priorità degli aiuti occidentali, con riguardo prioritario al celebre Piano Marshall voluto dagli Stati Uniti per promuovere la ripresa europea, e «last but not least» per supportare la difesa del Trentino-Alto Adige, che premeva in modo particolare allo stesso De Gasperi: a quel punto, era scontato che il trattato di pace diventasse un vero e proprio «diktat». Quello che andò alla firma il 10 febbraio, piuttosto che un trattato, fu un documento che gli Alleati avevano già dichiarato valido a priori, prescindendo dalla ratifica italiana oggettivamente irrilevante, e dalle espressioni di voto contrario che, per quanto minoritarie, non mancarono in Parlamento, a cominciare dalle nobili parole di Benedetto Croce in difesa dell’onore nazionale, ma nell’ambito di una sovranità ormai pesantemente limitata. Invano, nello stesso giorno l’Italia si sarebbe fermata per dieci minuti in segno di civile protesta; a più forte ragione, ebbe un significato puramente simbolico il tragico gesto di Maria Pasquinelli che, con tre colpi di rivoltella, lasciò senza vita il Generale Robert De Winton, Comandante Britannico della piazzaforte di Pola, affrontando un lunghissimo periodo di detenzione e di espiazione.
Quanto accadde dopo il 10 febbraio del 1947 è una storia che potrebbe essere definita di corollari, ossia di vicende in buona parte determinate dai fatti che le avevano precedute. Ciò, con la ricorrente impronta della rinuncia cui si accennava in premessa, come accadde nel 1954 quando la linea di «demarcazione» fra le due zone del cosiddetto Territorio Libero di Trieste – creato col trattato di pace ma rimasto indefinito anche nella sua struttura giuridica – fu spostata senza motivazioni accettabili a vantaggio di quella affidata all’amministrazione jugoslava (la cosiddetta Zona B) con l’unico risultato di incrementare ancora una volta il grande Esodo del dopoguerra, di cui furono protagonisti, con tale ultima aggiunta, almeno 350.000 profughi (secondo talune fonti furono di più), dando luogo a una modificazione etnica oggettivamente rivoluzionaria, di cui non si era visto l’eguale almeno da tredici secoli.
Non è tutto. Oltre alla diaspora, il popolo giuliano, istriano e dalmata fu costretto a subire anche una serie di efferate persecuzioni, culminate nell’uccisione di oltre 20.000 vittime, molte delle quali cadute ben oltre la fine delle operazioni belliche, con procedimenti sommari tra cui ha assunto aspetti emblematici quello della precipitazione violenta nelle foibe, ovvero nelle voragini naturali spesso assai profonde di cui sono particolarmente ricchi il territorio istriano e quello carsico; ma senza esclusione di altri metodi parimenti crudeli come l’annegamento, le lapidazioni e le ricorrenti torture mortali, talvolta dopo lunghe sevizie. Come si è riconosciuto in massima parte delle fonti storiografiche, si è trattato di un vero e proprio delitto contro l’umanità, perpetrato a danno di un popolo senza difesa, che ebbe la «sola colpa di essere italiano».
Il nutrito elenco di pagine dolorose, sorvolando su tante minori, prosegue col trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con cui Italia e Jugoslavia definirono anche formalmente il trasferimento della predetta «Zona B» sotto la piena sovranità di Belgrado. Era la codifica di una condizione sostanzialmente consolidata, ma giova aggiungere che avvenne a prescindere da qualsiasi contropartita sia pure formale: anzi, l’Italia fu «partner» assai attenta di altri Stati Occidentali nel promuovere un ampio supporto alle dissestate finanze di Belgrado, inserito in programmi di recupero che si sarebbero dimostrati velleitari. Il caso più ragguardevole, ma non unico, fu quello dell’accordo fra i due Presidenti Giovanni Goria e Branko Mikulic (gennaio 1988) con cui l’Italia avrebbe erogato 500 miliardi di lire, in parte a fondo perduto, a favore della Jugoslavia.
La storia prosegue con gli eventi del 1991, quando la crisi del sistema di Belgrado era giunta al punto di non ritorno grazie alla secessione di Croazia e Slovenia, non senza momenti di rilevanti contrasti anche dal punto di vista militare: ebbene, in tale occasione il Ministro degli Esteri Gianni De Michelis si spinse al punto di augurarsi di «non dover mai affrontare il ritorno all’Italia dell’Istria o della Dalmazia». Analogamente, all’inizio dell’anno successivo le nuove Repubbliche furono immediatamente riconosciute da parte italiana, senza dire che il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga fu il primo Capo di Stato a visitare Lubiana e Zagabria per puro gesto di cortesia, a prescindere da qualsiasi accenno ai problemi ancora irrisolti con la ex Jugoslavia.
In realtà, la preoccupazione del Ministro De Michelis non aveva alcun apprezzabile fondamento, anche perché l’irredentismo italiano, ancora vivo in alcune rilevanti minoranze, si era già fatto premura, ormai da gran tempo, di onorare una pregiudiziale etica, che era quella dell’impegno per l’affrancamento dei popoli dalle tirannie, riconoscendo che non era più attuale il riferimento ai territori (come nel lucido pensiero di Monsignor Luigi Stefani, il celebre Cappellano militare esule da Zara che aveva portato in Italia un messaggio destinato all’illuminazione di tante coscienze). Quanto al messaggio di Cossiga, è chiaro che si sarebbe dovuto leggere in una semplice ottica di disponibilità, ovviamente reciproche; invece, anche negli anni successivi alla sistemazione della nuova geografia politica, i problemi di cui si diceva restarono tali.
Quali esempi considerevoli giova ricordare, anzitutto, il regime delle acque territoriali nell’Alto Adriatico, dove la Croazia non avrebbe mancato di avanzare pretese non conformi alla prassi giuridica vigente. Lo stesso dicasi per la tutela della pesca italiana, caratterizzata da una latitanza che già nel 1986 aveva visto l’uccisione di Bruno Zerbin a bordo del suo peschereccio, per i colpi di fucile sparati nel Golfo di Trieste da una motovedetta slava. Infine, si deve menzionare la grande questione dei beni che a suo tempo il sistema comunista aveva espropriato ai profughi senza alcun indennizzo, fatta eccezione per tardivi e ridotti risarcimenti da parte italiana (talvolta talmente minimi da indurre qualche sofferto e dignitoso rifiuto).
Alcune conclusioni non sono difficili da trarre: anzi, acquistano una valenza quasi ovvia. Nel secondo dopoguerra, a cominciare dalla primavera del 1945, l’Italia era in condizioni molto critiche da cui conseguiva una condizione di oggettivo e naturale svantaggio, anche se questo non è un motivo sufficiente per giustificare pienamente la rinunzia a far valere i suoi diritti, per lo meno alla luce del ruolo di «sentinella dell’Occidente» nelle relazioni internazionali dell’epoca. A più forte ragione, ciò vale per avere accettato supinamente il rifiuto che la Conferenza della pace oppose all’audizione dei delegati giuliani e dalmati, che – è facilmente intuibile – avrebbero avuto molto da dire, se non altro a futura memoria.
Nei tempi successivi, potendo muovere da condizioni socio-politiche ed economiche di maggior favore, l’Italia avrebbe potuto e dovuto proporsi il perseguimento di risultati migliori. Proprio per questo, non è infondato chiedersi quali siano stati i motivi che hanno indotto risultati opinabili come quelli in precedenza indicati. A esempio, è ragionevole domandarsi ancor oggi perché mai le trattative «segrete» che furono la premessa di Osimo avessero la sorte di essere gestite in un clima da autentica consorteria, e peggio ancora, senza il coinvolgimento ufficiale della diplomazia italiana, tanto da essere affidate alla responsabilità di un dirigente del Ministero dell’Industria nella persona di Eugenio Carbone: il meno che si possa supporre, è la concomitanza d’interessi diversi. Del resto, anche l’atto finale del trattato di Osimo non fu immune da analoghe vicende, per alcuni aspetti surreali, come il dirottamento aereo dei plenipotenziari da Rimini a Falconara, e la scelta di un luogo privato (Villa Leopardi) per la firma dei documenti.
Nel dibattito parlamentare del 1947 per la ratifica del trattato di pace, sia pure ininfluente ai fini sostanziali, Benedetto Croce volle evocare la «cupidigia di servilismo» quale matrice prioritaria di un comportamento obiettivamente opinabile, sia sul piano morale sia su quello politico. Considerando corsi e ricorsi storici[3] si tratta di un fattore ricorrente con singolare pervicacia, che peraltro non è in grado di spiegare tutto. Verosimilmente, ancor prima dei limiti in questione, un ruolo propedeutico di rilevanza considerevole fu costituito dalla natura di una classe politica troppo asservita al «particulare» di Francesco Guicciardini, e non sempre consapevole del compito prioritario che avrebbe dovuto essere un vero e proprio «quid sui»: quello di «operare nella vita associata per fini di pubblica utilità» e quindi, in aderenza al senso etico dello Stato.
1 Non a caso, nell’ultimo incontro che il Comandante ebbe con Benito Mussolini, avvenuto alla stazione ferroviaria di Verona nel settembre 1937, quando il Duce del fascismo stava rientrando in Italia da un viaggio in Germania dove aveva incontrato Adolf Hitler nel pieno della sua potenza, Gabriele d’Annunzio si fece premura di invitare il proprio interlocutore, senza mezzi termini, a «guardarsi bene da Attila imbianchino» attribuendo al Cancelliere Tedesco questa definizione non propriamente esaltante, con chiaro riferimento alla prima esperienza professionale del Fuhrer.
2 Il voltafaccia di Belgrado compiuto nel 1941 ebbe conseguenze molto importanti per il prosieguo del conflitto, in quanto fu causa dell’apertura di un nuovo fronte bellico che, unitamente alla campagna italiana su quello greco-albanese, avrebbe dato luogo, se non altro, allo slittamento dell’iniziativa tedesca sul fronte orientale, con tutte le conseguenze strategiche dovute alla riduzione dei tempi disponibili per conseguirvi un successo decisivo prima del terribile inverno russo.
3 Per un inquadramento della vicenda storica in questione nell’ambito di maggiori dimensioni cronologiche, confronta Carlo Cesare Montani, Venezia Giulia Istria Dalmazia – Pensiero e vita morale – Tremila anni di storia, Aviani & Aviani Editori, Udine 2021, 410 pagine (Fiorino d’Oro del XXXVIII Premio Firenze per la storiografia). Al riguardo, basti menzionare la tragedia senza pari delle grandi invasioni avaro-slave in epoca medievale, per non dire del tentativo sostanzialmente velleitario di eliderne gli effetti peggiori, compiuto col Placito di Risano, che vi fece seguito. Considerazioni analoghe si devono proporre per le più recenti concessioni al nazionalismo slavo fino al cosiddetto «Osimo bis», e soprattutto, il fatto che l’Italia abbia perseverato nel disattendere «gli auspici della filosofia morale e della scienza politica» nell’ambito di una triste «rassegnazione all’ineluttabile» in palese distonia dai principi fondanti della sua stessa Costituzione (Ibidem, pagina 93).