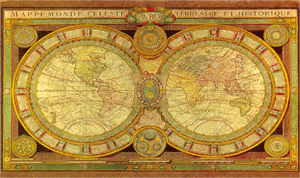Un sessantennio dalla grande tragedia del
Vajont
Il lungo percorso dal disastro annunciato
alle odierne riflessioni in ricordo delle 2.000 vittime
Durante la tarda sera del 9 ottobre 1963, almeno 2.000 persone furono assassinate da 50 milioni di metri cubi d’acqua e fango, che la gigantesca frana del monte Toc aveva fatto precipitare nel lago sottostante, presso gli abitati friulani di Erto e Casso. Buona parte di quella valanga, creando un’onda d’urto dalle dimensioni bibliche, non trovò alcun ostacolo nemmeno nella grande diga del Vajont, che era stata costruita durante la prima metà degli anni Sessanta a seguito di tanti studi pluridecennali, iniziati sin dal 1926, e si scagliò con la sua tremenda forza d’urto sulla sottostante valle del Piave[1].
La cittadina di Longarone fu quasi cancellata dalla faccia della terra, salvo qualche edificio in zone sovrastanti, ma il disastro coinvolse anche parecchie località contigue, senza dire degli effetti drammatici che aveva già provocato in quelle di montagna. Tra gli altri, scomparvero anche 487 bambini, come ha ricordato Mauro Corona[2] nella sua ultima rievocazione della tragedia, che ha fatto seguito, in occasione del sessantennio, alle tante opere dello stesso Autore dedicate al Vajont, nel quadro di una triste ma necessaria conoscenza.
Il numero delle vittime è rimasto indefinito, riducendosi alla stima compiuta in tempi successivi muovendo da rilevazioni anagrafiche tanto più difficili, perché non poche spoglie furono trascinate a valle dalla furia delle acque, e ritrovate – ma non sempre – a decine di chilometri di distanza, in quali condizioni è facile immaginare. Eppure, non si può dire che il giacimento non avesse dato avvertimenti: nel 1960 una frana di 700.000 metri cubi era già precipitata dal monte Toc riversandosi nel lago, e negli anni successivi non mancarono movimenti del terreno e smottamenti, talvolta ben visibili nella stessa conformazione vegetale del territorio, e tali da far comprendere che il processo franoso era ben lungi dall’essersi assestato. Anzi, aveva assunto un ritmo sempre più celere, ma a quel punto i tempi per ogni possibile intervento erano scaduti.
In realtà, alla stregua di quanto ha scritto Marco Armiero nella nuova esegesi circa le origini della tragedia, sarebbe stato necessario riflettere in maniera più approfondita su quanto è accaduto nel Vajont, e in qualche misura, anche con opportune riserve circa le fonti archivistiche, onde raccontare in un’ottica di effettiva oggettività «le storie silenziate dall’organizzazione maggioritaria della memoria»[3]. In tutta sintesi, è necessario prendere atto che in quella dolorosa storia la volontà di pochi avrebbe prevalso nettamente sulle preoccupazioni e sull’interesse di tanti, nella logica del perseguimento di profitti, sia pure collegati al presunto miglioramento delle condizioni di vita nel comprensorio in questione, destinati soprattutto agli azionisti della Società Adriatica di Elettricità, sostituita dall’ENEL quasi alla vigilia del disastro (Legge 6 dicembre 1962 numero 1643, istitutiva del nuovo soggetto energetico di matrice pubblica).
Per dare un’idea sia pure approssimativa delle dimensioni del fenomeno, basti dire che il fronte superiore della frana si ragguagliava a circa due chilometri, con una larghezza di almeno 500 metri e un’altezza di circa 250; e che per trasportare a valle un volume di roccia e detriti di tale rilievo, sarebbero stati necessari sette secoli, avendo a disposizione giornaliera un centinaio di dumper!
I maggiori artefici della diga, rimasta pressoché indenne nonostante la straordinaria forza dell’acqua e del fango che si riversarono sulla struttura, furono il progettista Carlo Semenza e il geologo Giorgio Dal Piaz, ma quando il processo penale di primo grado ebbe inizio, costoro erano già scomparsi. Dal canto loro, gli 11 imputati chiamati a rispondere dei reati di competenza furono personaggi sostanzialmente minori, uno dei quali, il Direttore dei lavori Mario Pancini, si tolse la vita nel 1968, ancor prima della sentenza che un anno dopo decise per pene relativamente miti agli altri, ulteriormente ridotte nel giudizio d’appello. Non meno estenuante è stato quello civile, che oltre un trentennio dopo i fatti era sempre in piedi, senza che fosse avvenuta la corresponsione di adeguati risarcimenti.
Dopo lo svuotamento del lago, la natura ha cominciato a riprendere possesso dell’alveo, ma i danni ambientali sono tuttora evidenti, al pari di quelli economici, nonostante gli incentivi, le provvidenze legislative, e la creazione del nuovo Comune di Vajont, allocato nel versante friulano della Valcellina, anche se parecchi abitanti di Erto e Casso, tra cui lo stesso Mauro Corona, hanno preferito rimanere nei luoghi d’origine.
Gli anni trascorsi dal disastro sono diventati 60, caratterizzati dal rinnovo naturale della popolazione in misura ormai maggioritaria, ma il ricordo è sempre vivo come il primo giorno, nella consapevolezza di una violenza perseguita a danno dell’ambiente e del genere umano per inseguire il profitto, e nell’impegno di molti protagonisti per una società più giusta. Ciò, iniziando da quello di Tina Merlin, che aveva intravisto sin dall’inizio i pericoli dell’operazione, e che proprio per questo aveva dovuto affrontare gli effetti di una denunzia iniqua da cui sarebbe stata assolta, prima che dalla giustizia, proprio dalla natura e dalla sua tragica sentenza.
Oggi, chi intenda trarre un insegnamento dalla tragedia del Vajont, se non altro in ossequio al sacrificio delle tante vittime innocenti che riposano nel Sacrario di Fortogna, ha il dovere di riflettere sul fatto che non si possono dare alla natura «colpe» di sorta, mentre è necessario conoscerla, e quindi interpretarla nell’ambito di una convivenza positiva, idonea a promuovere il progresso comune. In questo senso, esiste pur sempre un problema di programmazione: a più forte ragione, in un sistema economico nazionale e mondiale che sembra indulgere alle tentazioni di un «laisser faire» senza limiti ragionevoli, e quindi al sostanziale appiattimento sulla posizione del più forte, in palese deroga non tanto agli interessi della maggioranza, quanto ai valori essenziali della cooperazione, momento prioritario dell’etica sociale cristiana.
1 Per una coinvolgente documentazione del dramma avvenuto nel 1963, si veda: Gianni Olivier e Bruno Venturini, Vajont il giorno dopo, Edizioni Elzeviro, Padova 2005, 114 pagine (con toccanti testimonianze di superstiti, anche a carattere poetico, e con ampia illustrazione fotografica all’indomani della tragedia).
2 Mauro Corona, Le Altalene, Mondadori Editore, Milano 2023, 174 pagine. L’Autore, cittadino di Erto, dopo una prima esperienza giovanile nella cava del marmo rosso porfirico, situata in agro di Monte Buscada, e mai riaperta dopo il disastro del Vajont, ha dedicato tutta la vita al ricordo di quella tragedia, contribuendo a farla conoscere meglio, ben oltre i confini del comprensorio.
3 Confronta Marco Armiero, La tragedia del Vajont: ecologia politica di un disastro, Einaudi Editore, Torino 2023, 146 pagine. Si tratta di un’utile integrazione ad ampio spettro dell’opera di Marco Paolini e Gabriele Vacis, Il racconto del Vajont, Arti Grafiche Garzanti, Cernusco sul Naviglio 1999, 144 pagine (contiene il testo del celebre monologo, integrato da un’esaustiva e documentata cronologia).