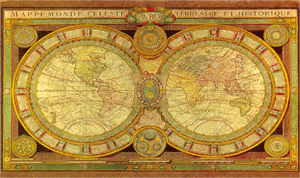Accademia delle Notti Vaticane
Un’iniziativa di alto spessore culturale
(1562-1565) durante il Pontificato di Pio IV a opera
precipua di San Carlo Borromeo
Nell’anno di grazia 1564 il Papa Pio IV dei Medici, che cinque anni prima era stato elevato al soglio di Pietro dopo la scomparsa del predecessore Paolo IV – alla fine di un conclave lungo e complesso – ebbe il forte merito di condurre a termine il lunghissimo Concilio di Trento concludendo 24 anni di lavori, e di affermare i valori della tradizione cattolica confermando i decreti conciliari con la Bolla Benedictus Deus. Il Pontificato di Pio IV, se non altro per questo, sarebbe passato alla storia nonostante la durata relativamente breve, pari a poco meno di sei anni; nondimeno, ebbe notevole importanza artistica e culturale, anche per talune grandi opere come la costruzione di Santa Maria degli Angeli nell’area delle terme di Diocleziano, la realizzazione del Belvedere nei Giardini Vaticani, e la progettazione di Porta Pia, affidata a Michelangelo.
Papa Pio IV, anche alla luce della sua impronta fiorentina, si sarebbe distinto per un poliedrico mecenatismo in cui ebbe un collaboratore importante nel nipote Carlo Borromeo, uomo di grande rettitudine destinato alla gloria degli altari, e assai lontano dalle vecchie consuetudini fondate su diffuse concessioni nepotistiche. Per l’appunto, si deve a Carlo la fondazione dell’Accademia che fu detta delle Notti Vaticane per la consuetudine di tenere quattro riunioni alla settimana in ore serali, nell’intento di non sottrarre tempo alle occupazioni ordinarie degli Accademici. Costituita il 20 aprile 1562, l’iniziativa avrebbe avuto regolare seguito fino al 14 settembre 1565, quando si tenne l’ultima seduta, seguita dalla partenza del Borromeo per la sede episcopale di Milano (e, nel successivo dicembre, dalla morte del Pontefice).
In effetti, nonostante la presenza di parecchi grandi nomi del mondo vaticano, tra cui Ugo Boncompagni – destinato a diventare Papa Gregorio XIII dopo la scomparsa di Pio V Ghislieri, immediato successore di Pio IV Medici –, l’Accademia ebbe modo di distinguersi per un’importante attività culturale, soprattutto in campo letterario e filosofico, ma poi anche in quello teologico, che divenne prioritario per l’impulso che proprio il Borromeo seppe conferirle attraverso il libero confronto, in una logica di approfondimento critico e oggettivo. Si parlò, tanto per fare qualche esempio significativo, delle tante e grandi opere di Cicerone, Livio, Lucrezio, Varrone e Virgilio, delle Lettere greche di San Gregorio Nazanzieno, delle opere dei Padri della Chiesa e degli stessi Evangelisti. Un ciclo specifico venne dedicato anche ai vizi capitali e alle virtù teologali.
Le testimonianze del tempo sono concordi nel sostenere la notevole importanza che i tempi dell’Accademia ebbero nella completa maturazione di Carlo Borromeo, anzitutto sul piano dell’approfondimento dei valori etici che poi avrebbe trasferito nella prassi quotidiana del proprio ministero, fino alla santità; ma nello stesso tempo sull’ottimizzare l’arte dello scrivere e quella del predicare. Del resto, diversi anni più tardi, in una lettera al Vescovo di Padova, Borromeo avrebbe ribadito che l’Accademia «era stata istituita per trattenerci in oneste occupazioni» e che il confronto sulle «cose profane» era stato progressivamente sostituito da quello sulle «cose sacre». Dal canto suo, Carlo Bascapé, che fu il primo biografo di San Carlo, avrebbe soggiunto che parecchi Accademici, proprio a fronte del suo esempio, si rivolsero a più alti studi e «a vita più pura»[1].
È utile precisare, ma la cosa è facilmente comprensibile, che la lingua d’uso comune nelle attività dell’Accademia era quella latina: scelta indubbiamente formativa, come lo stesso Borromeo avrebbe scritto al Cardinale Francesco Gonzaga il 15 settembre 1565, all’indomani dell’ultima riunione, sottolineando che nelle sedute bisognava rispondere «ex abrupto» – con dialettica adeguata ma senza uno specifico approfondimento propedeutico – a interventi e «orazioni» improntati ad alta valenza etica e culturale.
In ultima analisi, una realtà storica come quella dell’Accademia delle Notti Vaticane, grazie all’opera maieutica del futuro San Carlo[2] contribuisce a illustrare in maniera più realistica e oggettiva, lungi da tante vulgate, la presenza di un forte impegno morale e spirituale nell’ambito di uno Stato come quello pontificio dell’epoca tridentina: ciò, nel contesto di una complessa ricostruzione dei valori tradizionali che erano stati compromessi dalla Riforma ma che stavano trovando in questi valori uno spunto notevole per nuove affermazioni di speranza e di fede.
1 Confronta Carlo Bascapé, De Vita Rebus gestis Caroli S.R.E. Cardinalis libri septem, Basilica Petri auctore, Ingolstadt 1592, citato in Pio Paschini, Il soggiorno di San Carlo Borromeo a Roma, Società Editrice Internazionale, Torino 1935, pagina 72. Confronta altresì: L. Berra, L’Accademia delle Notti Vaticane fondata da San Carlo Borromeo, Roma 1915 (pagina 64 e seguenti). L’iniziativa ebbe durata relativamente breve, pari a poco più di triennio, in quanto interrotta con l’ascesa del Borromeo alla Cattedra Arcivescovile di Milano, ma avrebbe continuato a costituire un riferimento significativo nel pensiero e nell’azione del Presule.
2 Carlo Borromeo (1538-1584), proclamato Santo dal Sommo Pontefice Paolo V nel 1610, quando erano trascorsi appena 26 anni dall’immatura scomparsa, fu «anima e guida della Controriforma» e alfiere indomito del nuovo corso rigorista, nonostante le forti opposizioni che gli furono riservate anche nell’ambiente ecclesiastico, ivi compresi quattro attentati, tra cui l’archibugiata nella schiena, vibratagli miracolosamente senza danni il 22 ottobre 1569 da Gerolamo Donati, poi giustiziato assieme a tre complici durante l’anno successivo. Nipote del Pontefice Pio IV, e da questi eletto alla porpora cardinalizia poco più che ventenne, il futuro San Carlo osservava con scrupolo la regola di Sant’Ambrogio per la diffusione del digiuno e del risparmio da destinare ai poveri, oltre a quella di «ascetica povertà» non disgiunta da una forte azione pastorale, contro la prassi di parecchi Cardinali, volta a risiedere in luoghi diversi da quello della propria Cattedra, con chiara dissociazione dall’obbligo di assisterne il gregge cristiano. Definito non a caso il «Secondo Ambrogio», ebbe molte opposizioni anche da parte dei Governatori Spagnoli e del Senato Milanese, senza dire delle aggressioni subite persino da religiosi e da suore contrari al suo nuovo corso, oltre che dalla Congregazione degli «Umiliati», propensi a rilevanti deviazioni protestanti e calviniste. In occasione della terribile pestilenza che avrebbe imperversato anche a Milano nel 1576-1577, si fece premura di guidare la processione per intercedere la Grazia Divina camminando a piedi nudi e portando in mano la reliquia del «Santo Chiodo». Dopo la morte, e deposta ogni opposizione strumentale, entrò immediatamente in odore di santità, anche alla luce della sua esemplare vita morale, e in prosieguo divenne Patrono di un alto numero di regioni e di città italiane ed estere (Lombardia, Canton Ticino, Monterrey, San Carlos, Acquaviva del Capo, Casalmaggiore, Castelgerundo, Forenza, Francavilla Fontana, Nizza Monferrato, Portomaggiore, Rocca di Papa, Salò). In buona sostanza, il culto di San Carlo Borromeo è diventato un momento fondamentale di prassi etica e religiosa da parte del popolo di Dio.